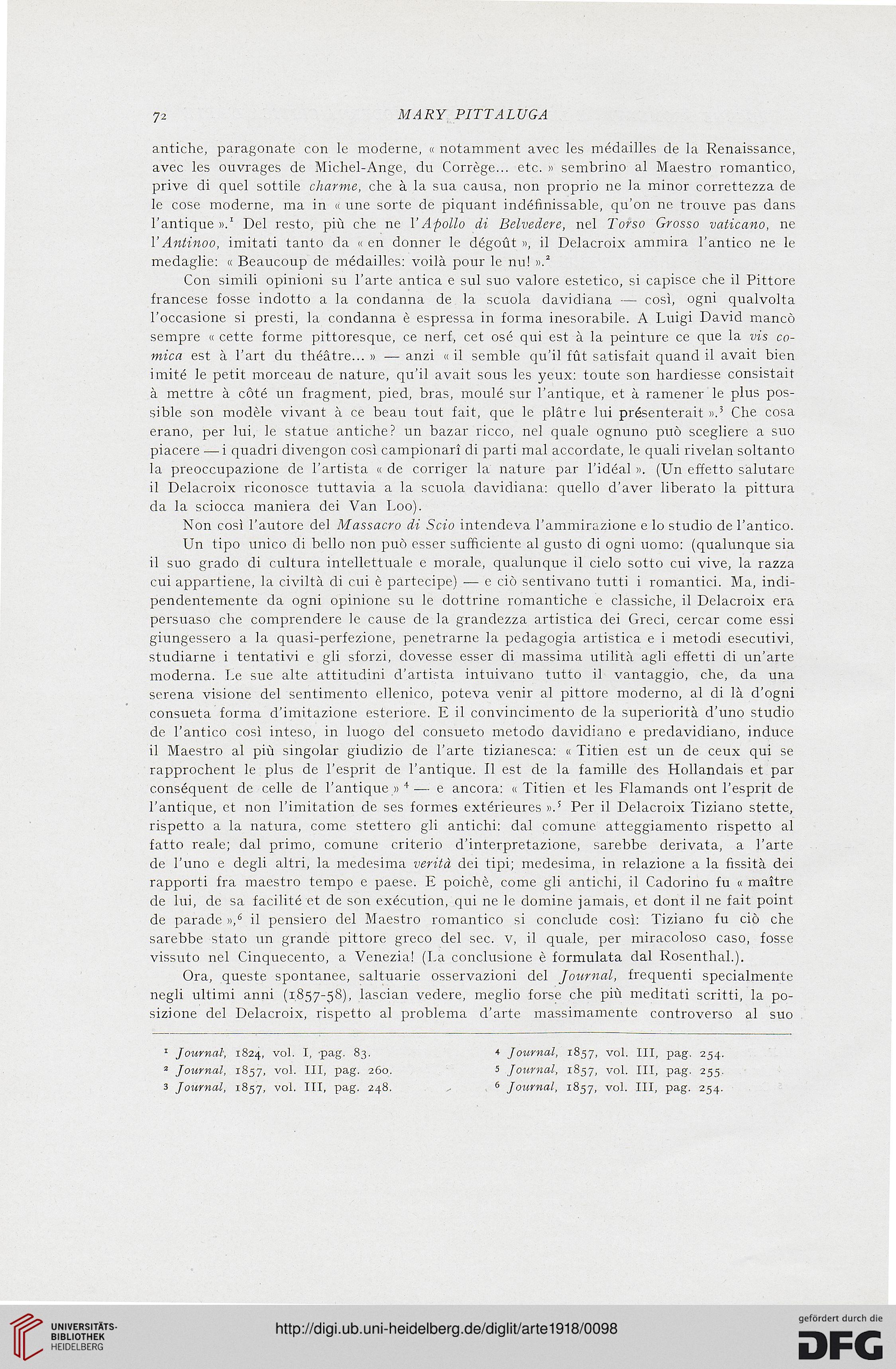72
MARY PITTALVGA
antiche, paragonate con le moderne, « notamment avec les médailles de la Renaissance,
avec les ouvrages de Michel-Ange, du Corrège... etc. » sembrino al Maestro romantico,
prive di quel sottile charme, che à la sua causa, non proprio ne la minor correttezza de
le cose moderne, ma in « une sorte de piquant indéfinissable, qu'on ne trouve pas dans
l'antique».1 Del resto, più che ne l'Apollo di Belvedere, nel Torso Grosso vaticano, ne
VAntimo, imitati tanto da « en donner le dégoùt », il Delacroix ammira l'antico ne le
medaglie: « Beaucoup de médailles: voilà pour le riu! ».2
Con simili opinioni su l'arte antica e sul suo valore estetico, si capisce che il Pittore
francese fosse indotto a la condanna de la scuola davidiana — così, ogni qualvolta
l'occasione si presti, la condanna è espressa in forma inesorabile. A Luigi David mancò
sempre « cette forme pittoresque, ce nerf, cet osé qui est à la peinture ce que la vis co-
mica est à l'art du théàtre... » — anzi « il scmble qu'il fùt satisfait quand il avait bien
imité le petit morceau de nature, qu'il avait sous les yeux: toute son hardiesse consistait
à mettre à coté un fragment, pied, bras, moulé sur l'antique, et à ramener le plus pos-
sible son modèle vivant à ce beau tout fait, que le plàtre lui présenterait ».3 Che cosa
erano, per lui, le statue antiche? un bazar ricco, nel quale ognuno può scegliere a suo
piacere —i quadri divengon così campionari di parti mal accordate, le quali rivelan soltanto
la preoccupazione de l'artista « de corriger la nature par l'idéal ». (Un effetto salutare
il Delacroix riconosce tuttavia a la scuola davidiana: quello d'aver liberato la pittura
da la sciocca maniera dei Van Loo).
Non così l'autore del Massacro di Scio intendeva l'ammirazione e lo studio de l'antico.
Un tipo unico di bello non può esser sufficiente al gusto di ogni uomo: (qualunque sia
il suo grado di cultura intellettuale e morale, qualunque il cielo sotto cui vive, la razza
cui appartiene, la civiltà di cui è partecipe) — e ciò sentivano tutti i romantici. Ma, indi-
pendentemente da ogni opinione su le dottrine romantiche e classiche, il Delacroix era
persuaso che comprendere le cause de la grandezza artistica dei Greci, cercar come essi
giungessero a la quasi-perfezionc, penetrarne la pedagogia artistica e i metodi esecutivi,
studiarne i tentativi e gli sforzi, dovesse esser di massima utilità agli effetti di un'arte
moderna. Le sue alte attitudini d'artista intuivano tutto il vantaggio, che, da una
serena visione del sentimento ellenico, poteva venir al pittore moderno, al di là d'ogni
consueta forma d'imitazione esteriore. E il convincimento de la superiorità d'uno studio
de l'antico così inteso, in luogo del consueto metodo davidiano e predavidiano, induce
il Maestro al più singoiar giudizio de l'arte tizianesca: « Titien est un de ceux qui se
rapprochent le plus de l'esprit de l'antique. 11 est de la famille des Hollandais et par
conséquent de celle de l'antique»4— e ancora: «Titien et les Flamands ont l'esprit de
l'antique, et non l'imitation de ses formes extérieures ».s Per il Delacroix Tiziano stette,
rispetto a la natura, come stettero gli antichi: dal comune atteggiamento rispetto al
fatto reale; dal primo, comune criterio d'interpretazione, sarebbe derivata, a l'arte
de l'uno e degli altri, la medesima verità dei tipi; medesima, in relazione a la fissità dei
rapporti fra maestro tempo e paese. E poiché, come gli antichi, il Cadorino fu « maitre
de lui, de sa facilitò et de son exécution, qui ne le domine jamais, et dont il ne fait point
de parade »,6 il pensiero del Maestro romantico si conclude così: Tiziano fu ciò che
sarebbe stato un grande pittore greco del sec. v, il quale, per miracoloso caso, fosse
vissuto nel Cinquecento, a Venezia! (La conclusione è formulata dal Rosenthal.).
Ora, queste spontanee, saltuarie osservazioni del Journal, frequenti specialmente
negli ultimi anni (1857-58), lascian vedere, meglio forse che più meditati scritti, la po-
sizione del Delacroix, rispetto al problema d'arte massimamente controverso al suo
1 Journal', 1824, voi. I, 'pag. 83.
2 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 260.
3 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 248.
•t Joitmal, 1857, voi. Ili, pag. 254.
5 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 255.
6 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 254.
MARY PITTALVGA
antiche, paragonate con le moderne, « notamment avec les médailles de la Renaissance,
avec les ouvrages de Michel-Ange, du Corrège... etc. » sembrino al Maestro romantico,
prive di quel sottile charme, che à la sua causa, non proprio ne la minor correttezza de
le cose moderne, ma in « une sorte de piquant indéfinissable, qu'on ne trouve pas dans
l'antique».1 Del resto, più che ne l'Apollo di Belvedere, nel Torso Grosso vaticano, ne
VAntimo, imitati tanto da « en donner le dégoùt », il Delacroix ammira l'antico ne le
medaglie: « Beaucoup de médailles: voilà pour le riu! ».2
Con simili opinioni su l'arte antica e sul suo valore estetico, si capisce che il Pittore
francese fosse indotto a la condanna de la scuola davidiana — così, ogni qualvolta
l'occasione si presti, la condanna è espressa in forma inesorabile. A Luigi David mancò
sempre « cette forme pittoresque, ce nerf, cet osé qui est à la peinture ce que la vis co-
mica est à l'art du théàtre... » — anzi « il scmble qu'il fùt satisfait quand il avait bien
imité le petit morceau de nature, qu'il avait sous les yeux: toute son hardiesse consistait
à mettre à coté un fragment, pied, bras, moulé sur l'antique, et à ramener le plus pos-
sible son modèle vivant à ce beau tout fait, que le plàtre lui présenterait ».3 Che cosa
erano, per lui, le statue antiche? un bazar ricco, nel quale ognuno può scegliere a suo
piacere —i quadri divengon così campionari di parti mal accordate, le quali rivelan soltanto
la preoccupazione de l'artista « de corriger la nature par l'idéal ». (Un effetto salutare
il Delacroix riconosce tuttavia a la scuola davidiana: quello d'aver liberato la pittura
da la sciocca maniera dei Van Loo).
Non così l'autore del Massacro di Scio intendeva l'ammirazione e lo studio de l'antico.
Un tipo unico di bello non può esser sufficiente al gusto di ogni uomo: (qualunque sia
il suo grado di cultura intellettuale e morale, qualunque il cielo sotto cui vive, la razza
cui appartiene, la civiltà di cui è partecipe) — e ciò sentivano tutti i romantici. Ma, indi-
pendentemente da ogni opinione su le dottrine romantiche e classiche, il Delacroix era
persuaso che comprendere le cause de la grandezza artistica dei Greci, cercar come essi
giungessero a la quasi-perfezionc, penetrarne la pedagogia artistica e i metodi esecutivi,
studiarne i tentativi e gli sforzi, dovesse esser di massima utilità agli effetti di un'arte
moderna. Le sue alte attitudini d'artista intuivano tutto il vantaggio, che, da una
serena visione del sentimento ellenico, poteva venir al pittore moderno, al di là d'ogni
consueta forma d'imitazione esteriore. E il convincimento de la superiorità d'uno studio
de l'antico così inteso, in luogo del consueto metodo davidiano e predavidiano, induce
il Maestro al più singoiar giudizio de l'arte tizianesca: « Titien est un de ceux qui se
rapprochent le plus de l'esprit de l'antique. 11 est de la famille des Hollandais et par
conséquent de celle de l'antique»4— e ancora: «Titien et les Flamands ont l'esprit de
l'antique, et non l'imitation de ses formes extérieures ».s Per il Delacroix Tiziano stette,
rispetto a la natura, come stettero gli antichi: dal comune atteggiamento rispetto al
fatto reale; dal primo, comune criterio d'interpretazione, sarebbe derivata, a l'arte
de l'uno e degli altri, la medesima verità dei tipi; medesima, in relazione a la fissità dei
rapporti fra maestro tempo e paese. E poiché, come gli antichi, il Cadorino fu « maitre
de lui, de sa facilitò et de son exécution, qui ne le domine jamais, et dont il ne fait point
de parade »,6 il pensiero del Maestro romantico si conclude così: Tiziano fu ciò che
sarebbe stato un grande pittore greco del sec. v, il quale, per miracoloso caso, fosse
vissuto nel Cinquecento, a Venezia! (La conclusione è formulata dal Rosenthal.).
Ora, queste spontanee, saltuarie osservazioni del Journal, frequenti specialmente
negli ultimi anni (1857-58), lascian vedere, meglio forse che più meditati scritti, la po-
sizione del Delacroix, rispetto al problema d'arte massimamente controverso al suo
1 Journal', 1824, voi. I, 'pag. 83.
2 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 260.
3 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 248.
•t Joitmal, 1857, voi. Ili, pag. 254.
5 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 255.
6 Journal, 1857, voi. Ili, pag. 254.