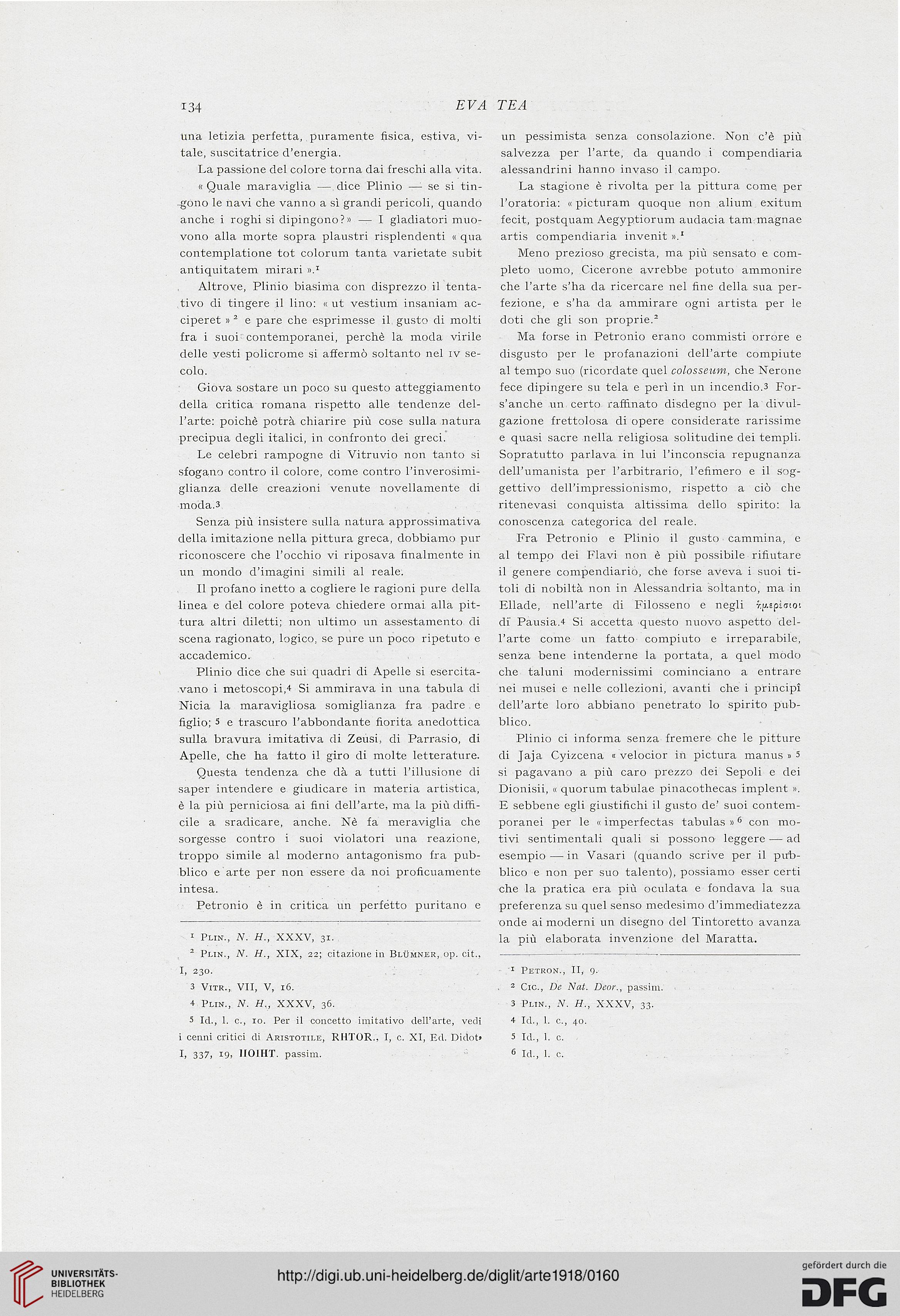134
EVA TEA
Una letizia perfetta, puramente fisica, estiva, vi-
tale, suscitatrice d'energia.
La passione del colore torna dai freschi alla vita.
«Quale maraviglia — dice Plinio —1 se si tin-
gono le navi che vanno a sì grandi pericoli, quando
anche i roghi si dipingono?» — I gladiatori muo-
vono alla morte sopra plaustri risplendenti « qua
contemplatione tot colorum tanta varietate subit
antiquitatem mirari n.1
Altrove, Plinio biasima con disprezzo il tenta-
tivo di tingere il lino: « ut vestium insaniam ac-
ciperet »2 e pare che esprimesse il gusto di molti
fra i suoi: contemporanei, perchè la moda virile
delle vesti policrome si affermò soltanto nel iv se-
colo.
Giova sostare un poco su questo atteggiamento
della critica romana rispetto alle tendenze del-
l'arte: poiché potrà chiarire più cose sulla natura
precipua degli italici, in confronto dei greci.
Le celebri rampogne di Vitruvio non tanto si
sfogano contro il colore, come contro l'inverosimi-
glianza delle creazioni venute novellamente di
moda.3
Senza più insistere sulla natura approssimativa
della imitazione nella pittura greca, dobbiamo pur
riconoscere che l'occhio vi riposava finalmente in
un mondo d'imagini simili al reale.
Il profano inetto a cogliere le ragioni pure della
linea e del colore poteva chiedere ormai alla pit-
tura altri diletti; non ultimo un assestamento di
scena ragionato, logico, se pure un poco ripetuto c
accademico. . ...
Plinio dice che sui quadri di Apelle si esercita-
vano i metoscopi,4 Si ammirava in una tabula di
Nicia la maravigliosa somiglianza fra padre e
figlio; 5 e trascuro l'abbondante fiorita anedottica
sulla bravura imitativa di Zeusi, di Parrasio, di
Apelle, che ha fatto il giro di molte letterature.
Questa tendenza che dà a tutti l'illusione di
saper intendere e giudicare in materia artistica,
è la più perniciosa ai fini dell'arte, ma la più diffi-
cile a sradicare, anche. Nè fa meraviglia che
sorgesse contro i suoi violatori una reazione,
troppo simile al moderno antagonismo fra pub-
blico e arte per non essere da noi proficuamente
intesa.
Petronio è in critica un perfètto puritano e
x1 Plin., N.- H., XXXV, 31.,
2 Plin., N. H., XIX, 22; citazione in Blumner, op. cit.,
I, 230.
3 ViTR.,. VII, V, 16. ,
4, Plin.,. N. H,, XXXV, 36.
5 Id., 1. e, 10. Per il concetto imitativo dell'arte, vedi
i cenni critici di Aristotile, RHTOR.', I, c. XI, Ed. Didot»
I, 337, 19, IIOIHT. passim.
un pessimista senza consolazione. Non c'è più
salvezza per l'arte, da quando i compendiaria
alessandrini hanno invaso il campo.
La stagione è rivolta per la pittura come, per
l'oratoria: « picturam quoque non alium exitum
fecit, postquam Aegyptiorum audacia tam magnae
artis compendiaria invenit ».'
Meno prezioso grecista, ma più sensato e com-
pleto uomo, Cicerone avrebbe potuto ammonire
che l'arte s'ha da ricercare nel fine della sua per-
fezione, e s'ha da ammirare ogni artista per le
doti che gli son proprie.2
Ma forse in Petronio erano commisti orrore e
disgusto per le profanazioni dell'arte compiute
al tempo suo (ricordate quel colosseum, che Nerone
fece dipingere su tela e perì in un incendio.3 For-
s'anche un certo raffinato disdegno per la divul-
gazione frettolosa di opere considerate rarissime
e quasi sacre nella religiosa solitudine dei templi.
Sopratutto parlava in luì l'inconscia repugnanza
dell'umanista per l'arbitrario, l'efimero e il sog-
gettivo dell'impressionismo, rispetto a ciò che
ritenevasi conquista altissima dello spirito: la
conoscenza categorica del reale.
Fra Petronio e Plinio il gusto cammina, e
al tempo dei Flavi non è più possibile rifiutare
il genere compendiario, che forse aveva i suoi ti-
toli di nobiltà non in Alessandria soltanto, ma in
Fllade, nell'arte di Filosseno e negli fcjjirpsatot
di' Pausia.4 Si accetta questo nuovo aspetto del-
l'arte come un fatto compiuto e irreparabile,
senza bene intenderne la portata, a quel modo
che taluni modernissimi cominciano a entrare
nei musei e nelle collezioni, avanti che i principi
dell'arte loro abbiano penetrato lo spirito pub-
blico.
Plinio ci informa senza fremere che le pitture
di Jaja Cyizcena « velocior in pictura manus » 5
si pagavano a più caro prezzo dei Sepoli e dei
Dionisii, « quorum tabulae pinacothecas implent ».
E sebbene egli giustifichi il gusto de' suoi contem-
poranei per le « imperfectas tabulas »6 con mo-
tivi sentimentali quali si possono leggere — ad
esempio — in Vasari (quando scrive per il pub-
blico e non per suo talento), possiamo esser certi
che la pratica era più oculata e fondava la sua
preferenza su quel senso medesimo d'immediatezza
onde ai moderni un disegno del Tintoretto avanza
la più elaborata invenzione del Maratta.
- Petron., II,. 9. ,■.
. 2 Cic, De Nat. Deor., passim. ■
-3 Pun., N. H., XXXV, 33.
4 Id., 1. e, 40.
5 Id., 1. c.
6 Id., 1. c.
EVA TEA
Una letizia perfetta, puramente fisica, estiva, vi-
tale, suscitatrice d'energia.
La passione del colore torna dai freschi alla vita.
«Quale maraviglia — dice Plinio —1 se si tin-
gono le navi che vanno a sì grandi pericoli, quando
anche i roghi si dipingono?» — I gladiatori muo-
vono alla morte sopra plaustri risplendenti « qua
contemplatione tot colorum tanta varietate subit
antiquitatem mirari n.1
Altrove, Plinio biasima con disprezzo il tenta-
tivo di tingere il lino: « ut vestium insaniam ac-
ciperet »2 e pare che esprimesse il gusto di molti
fra i suoi: contemporanei, perchè la moda virile
delle vesti policrome si affermò soltanto nel iv se-
colo.
Giova sostare un poco su questo atteggiamento
della critica romana rispetto alle tendenze del-
l'arte: poiché potrà chiarire più cose sulla natura
precipua degli italici, in confronto dei greci.
Le celebri rampogne di Vitruvio non tanto si
sfogano contro il colore, come contro l'inverosimi-
glianza delle creazioni venute novellamente di
moda.3
Senza più insistere sulla natura approssimativa
della imitazione nella pittura greca, dobbiamo pur
riconoscere che l'occhio vi riposava finalmente in
un mondo d'imagini simili al reale.
Il profano inetto a cogliere le ragioni pure della
linea e del colore poteva chiedere ormai alla pit-
tura altri diletti; non ultimo un assestamento di
scena ragionato, logico, se pure un poco ripetuto c
accademico. . ...
Plinio dice che sui quadri di Apelle si esercita-
vano i metoscopi,4 Si ammirava in una tabula di
Nicia la maravigliosa somiglianza fra padre e
figlio; 5 e trascuro l'abbondante fiorita anedottica
sulla bravura imitativa di Zeusi, di Parrasio, di
Apelle, che ha fatto il giro di molte letterature.
Questa tendenza che dà a tutti l'illusione di
saper intendere e giudicare in materia artistica,
è la più perniciosa ai fini dell'arte, ma la più diffi-
cile a sradicare, anche. Nè fa meraviglia che
sorgesse contro i suoi violatori una reazione,
troppo simile al moderno antagonismo fra pub-
blico e arte per non essere da noi proficuamente
intesa.
Petronio è in critica un perfètto puritano e
x1 Plin., N.- H., XXXV, 31.,
2 Plin., N. H., XIX, 22; citazione in Blumner, op. cit.,
I, 230.
3 ViTR.,. VII, V, 16. ,
4, Plin.,. N. H,, XXXV, 36.
5 Id., 1. e, 10. Per il concetto imitativo dell'arte, vedi
i cenni critici di Aristotile, RHTOR.', I, c. XI, Ed. Didot»
I, 337, 19, IIOIHT. passim.
un pessimista senza consolazione. Non c'è più
salvezza per l'arte, da quando i compendiaria
alessandrini hanno invaso il campo.
La stagione è rivolta per la pittura come, per
l'oratoria: « picturam quoque non alium exitum
fecit, postquam Aegyptiorum audacia tam magnae
artis compendiaria invenit ».'
Meno prezioso grecista, ma più sensato e com-
pleto uomo, Cicerone avrebbe potuto ammonire
che l'arte s'ha da ricercare nel fine della sua per-
fezione, e s'ha da ammirare ogni artista per le
doti che gli son proprie.2
Ma forse in Petronio erano commisti orrore e
disgusto per le profanazioni dell'arte compiute
al tempo suo (ricordate quel colosseum, che Nerone
fece dipingere su tela e perì in un incendio.3 For-
s'anche un certo raffinato disdegno per la divul-
gazione frettolosa di opere considerate rarissime
e quasi sacre nella religiosa solitudine dei templi.
Sopratutto parlava in luì l'inconscia repugnanza
dell'umanista per l'arbitrario, l'efimero e il sog-
gettivo dell'impressionismo, rispetto a ciò che
ritenevasi conquista altissima dello spirito: la
conoscenza categorica del reale.
Fra Petronio e Plinio il gusto cammina, e
al tempo dei Flavi non è più possibile rifiutare
il genere compendiario, che forse aveva i suoi ti-
toli di nobiltà non in Alessandria soltanto, ma in
Fllade, nell'arte di Filosseno e negli fcjjirpsatot
di' Pausia.4 Si accetta questo nuovo aspetto del-
l'arte come un fatto compiuto e irreparabile,
senza bene intenderne la portata, a quel modo
che taluni modernissimi cominciano a entrare
nei musei e nelle collezioni, avanti che i principi
dell'arte loro abbiano penetrato lo spirito pub-
blico.
Plinio ci informa senza fremere che le pitture
di Jaja Cyizcena « velocior in pictura manus » 5
si pagavano a più caro prezzo dei Sepoli e dei
Dionisii, « quorum tabulae pinacothecas implent ».
E sebbene egli giustifichi il gusto de' suoi contem-
poranei per le « imperfectas tabulas »6 con mo-
tivi sentimentali quali si possono leggere — ad
esempio — in Vasari (quando scrive per il pub-
blico e non per suo talento), possiamo esser certi
che la pratica era più oculata e fondava la sua
preferenza su quel senso medesimo d'immediatezza
onde ai moderni un disegno del Tintoretto avanza
la più elaborata invenzione del Maratta.
- Petron., II,. 9. ,■.
. 2 Cic, De Nat. Deor., passim. ■
-3 Pun., N. H., XXXV, 33.
4 Id., 1. e, 40.
5 Id., 1. c.
6 Id., 1. c.