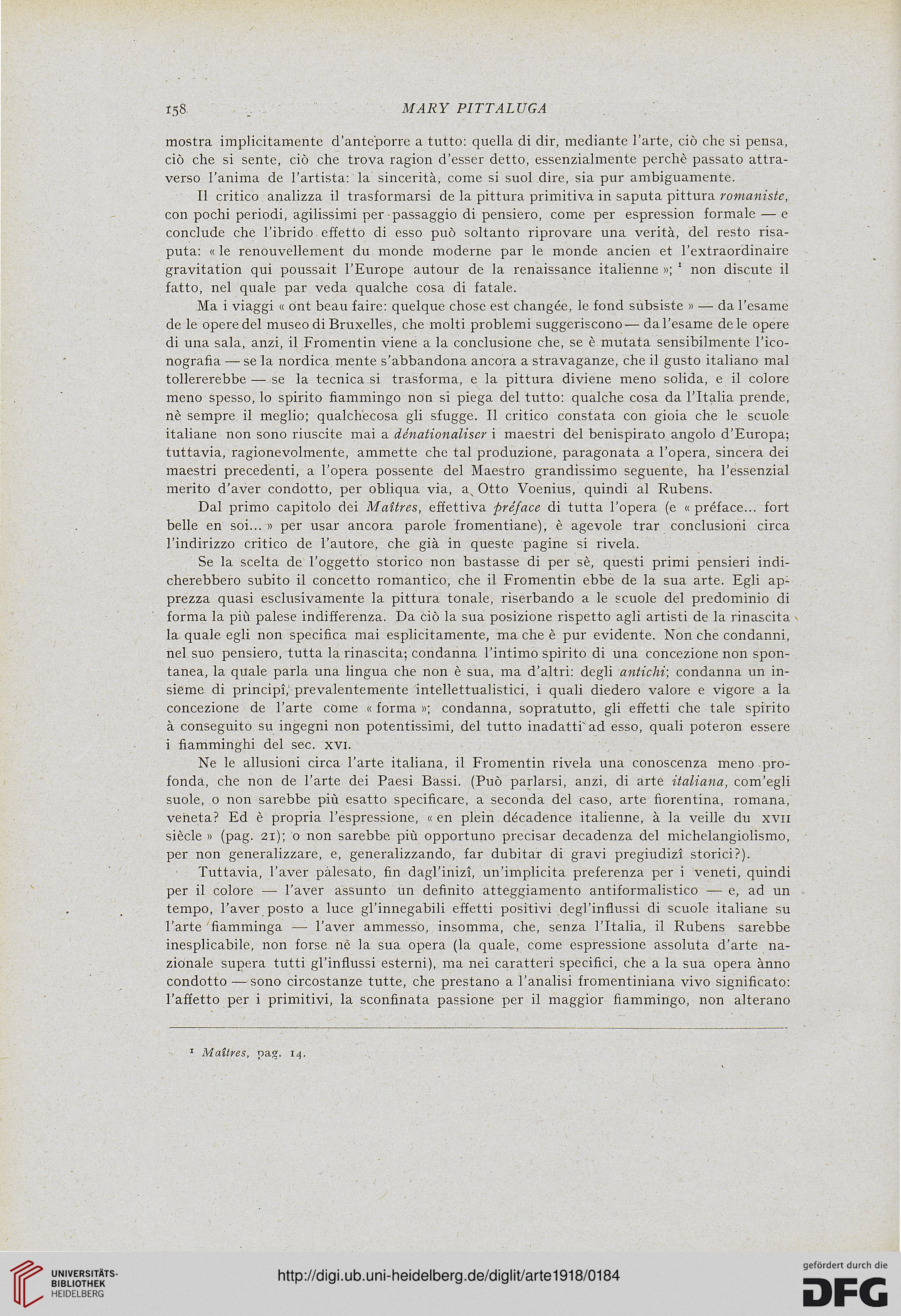158.
MARY PITTALUGA
mostra implicitamente d'anteporre a tutto: quella di dir, mediante l'arte, ciò che si pensa,
ciò che si sente, ciò che trova ragion d'esser detto, essenzialmente perchè passato attra-
verso l'anima de l'artista: la sincerità, come si suol dire, sia pur ambiguamente.
Il critico analizza il trasformarsi de la pittura primitiva in saputa pittura romaniste,
con pochi periodi, agilissimi per-passaggio di pensiero, come per espression formale — e
conclude che l'ibrido. effetto di esso può soltanto riprovare una verità, del resto risa-
puta: « le renouvellement du monde moderne par le monde ancien et l'extraordinaire
gravitation qui poussait l'Europe autour de la renaissance italienne »; 1 non discute il
fatto, nel quale par veda qualche cosa di fatale.
Ma i viaggi « ont beau faire: quelque chose est changée, le fond subsiste » —• da l'esame
de le opere del museo di Bruxelles, che molti problemi suggeriscono—da l'esame de le opere
di una sala, anzi, il Fromentin viene a la conclusione che, se è mutata sensibilmente l'ico-
nografia — se la nordica mente s'abbandona ancora a stravaganze, che il gusto italiano mal
tollererebbe — se la tecnica si trasforma, e la pittura diviene meno solida, e il colore
meno spesso, lo spirito fiammingo non si piega del tutto: qualche cosa da l'Italia prende,
nè sempre il meglio; qualchecosa gli sfugge. Il critico constata con gioia che le scuole
italiane non sono riuscite mai a dénationaliscr i maestri del benispirato angolo d'Europa;
tuttavia, ragionevolmente, ammette che tal produzione, paragonata a l'opera, sincera dei
maestri precedenti, a l'opera possente del Maestro grandissimo seguente, ha l'essenzial
merito d'aver condotto, per obliqua via, ax Otto Voenius, quindi al Rubens.
Dal primo capitolo dei Mattres, effettiva préface di tutta l'opera (e « préface... fort
belle en soi... » per usar ancora parole fromentiane), è agevole trar conclusioni circa
l'indirizzo critico de l'autore, che già in queste pagine si rivela.
Se la scelta de l'oggetto storico non bastasse di per sè, questi primi pensieri indi-
cherebbero subito il concetto romantico, che il Fromentin ebbe de la sua arte. Egli ap-
prezza quasi esclusivamente la pittura tonale, riserbando a le scuole del predominio di
forma la più palese indifferenza. Da ciò la sua posizione rispetto agli artisti de la rinascita \
la quale egli non specifica mai esplicitamente, ma che è pur evidente. Non che condanni,
nel suo pensiero, tutta la rinascita; condanna l'intimo spirito di una concezione non spon-
tanea, la quale parla una lingua che non è sua, ma d'altri: degli antichi; condanna un in-
sieme di principi; prevalentemente intellettualistici, i quali diedero valore e vigore a la
concezione de l'arte come « forma »; condanna, sopratutto, gli effetti che tale spirito
à conseguito su ingegni non potentissimi, del tutto inadatti" ad esso, quali poteron essere
i fiamminghi del sec. xvi.
Ne le allusioni circa l'arte italiana, il Fromentin rivela una conoscenza meno pro-
fonda, che non de l'arte dei Paesi Bassi. (Può parlarsi, anzi, di arte italiana, com'egli
suole, o non sarebbe più esatto specificare, a seconda del caso, arte fiorentina, romana,
veneta? Ed è propria l'espressione, « en plein décadence italienne, à la veille du xvn
siècle » (pag. 21); o non sarebbe, più opportuno precisar decadenza del michelangiolismo,
per non generalizzare, e, generalizzando, far dubitar di gravi pregiudizi storici?).
Tuttavia, l'aver palesato, fin dagl'inizi, un'implicita preferenza per i veneti, quindi
per il colore — l'aver assunto un definito atteggiamento antiformalistico — e, ad un
tempo, l'aver posto a luce gl'innegabili effetti positivi degl'influssi di scuole italiane su
l'arte fiamminga — l'aver ammesso, insomma, che, senza l'Italia, il Rubens sarebbe
inesplicabile, non forse né la sua opera (la quale, come espressione assoluta d'arte na-
zionale supera tutti gl'influssi esterni), ma nei caratteri specifici, che a la sua opera ànno
condotto —sono circostanze tutte, che prestano a l'analisi fromentiniana vivo significato:
l'affetto per i primitivi, la sconfinata passione per il maggior fiammingo, non alterano
1 Mattres, pa,e. 14.
MARY PITTALUGA
mostra implicitamente d'anteporre a tutto: quella di dir, mediante l'arte, ciò che si pensa,
ciò che si sente, ciò che trova ragion d'esser detto, essenzialmente perchè passato attra-
verso l'anima de l'artista: la sincerità, come si suol dire, sia pur ambiguamente.
Il critico analizza il trasformarsi de la pittura primitiva in saputa pittura romaniste,
con pochi periodi, agilissimi per-passaggio di pensiero, come per espression formale — e
conclude che l'ibrido. effetto di esso può soltanto riprovare una verità, del resto risa-
puta: « le renouvellement du monde moderne par le monde ancien et l'extraordinaire
gravitation qui poussait l'Europe autour de la renaissance italienne »; 1 non discute il
fatto, nel quale par veda qualche cosa di fatale.
Ma i viaggi « ont beau faire: quelque chose est changée, le fond subsiste » —• da l'esame
de le opere del museo di Bruxelles, che molti problemi suggeriscono—da l'esame de le opere
di una sala, anzi, il Fromentin viene a la conclusione che, se è mutata sensibilmente l'ico-
nografia — se la nordica mente s'abbandona ancora a stravaganze, che il gusto italiano mal
tollererebbe — se la tecnica si trasforma, e la pittura diviene meno solida, e il colore
meno spesso, lo spirito fiammingo non si piega del tutto: qualche cosa da l'Italia prende,
nè sempre il meglio; qualchecosa gli sfugge. Il critico constata con gioia che le scuole
italiane non sono riuscite mai a dénationaliscr i maestri del benispirato angolo d'Europa;
tuttavia, ragionevolmente, ammette che tal produzione, paragonata a l'opera, sincera dei
maestri precedenti, a l'opera possente del Maestro grandissimo seguente, ha l'essenzial
merito d'aver condotto, per obliqua via, ax Otto Voenius, quindi al Rubens.
Dal primo capitolo dei Mattres, effettiva préface di tutta l'opera (e « préface... fort
belle en soi... » per usar ancora parole fromentiane), è agevole trar conclusioni circa
l'indirizzo critico de l'autore, che già in queste pagine si rivela.
Se la scelta de l'oggetto storico non bastasse di per sè, questi primi pensieri indi-
cherebbero subito il concetto romantico, che il Fromentin ebbe de la sua arte. Egli ap-
prezza quasi esclusivamente la pittura tonale, riserbando a le scuole del predominio di
forma la più palese indifferenza. Da ciò la sua posizione rispetto agli artisti de la rinascita \
la quale egli non specifica mai esplicitamente, ma che è pur evidente. Non che condanni,
nel suo pensiero, tutta la rinascita; condanna l'intimo spirito di una concezione non spon-
tanea, la quale parla una lingua che non è sua, ma d'altri: degli antichi; condanna un in-
sieme di principi; prevalentemente intellettualistici, i quali diedero valore e vigore a la
concezione de l'arte come « forma »; condanna, sopratutto, gli effetti che tale spirito
à conseguito su ingegni non potentissimi, del tutto inadatti" ad esso, quali poteron essere
i fiamminghi del sec. xvi.
Ne le allusioni circa l'arte italiana, il Fromentin rivela una conoscenza meno pro-
fonda, che non de l'arte dei Paesi Bassi. (Può parlarsi, anzi, di arte italiana, com'egli
suole, o non sarebbe più esatto specificare, a seconda del caso, arte fiorentina, romana,
veneta? Ed è propria l'espressione, « en plein décadence italienne, à la veille du xvn
siècle » (pag. 21); o non sarebbe, più opportuno precisar decadenza del michelangiolismo,
per non generalizzare, e, generalizzando, far dubitar di gravi pregiudizi storici?).
Tuttavia, l'aver palesato, fin dagl'inizi, un'implicita preferenza per i veneti, quindi
per il colore — l'aver assunto un definito atteggiamento antiformalistico — e, ad un
tempo, l'aver posto a luce gl'innegabili effetti positivi degl'influssi di scuole italiane su
l'arte fiamminga — l'aver ammesso, insomma, che, senza l'Italia, il Rubens sarebbe
inesplicabile, non forse né la sua opera (la quale, come espressione assoluta d'arte na-
zionale supera tutti gl'influssi esterni), ma nei caratteri specifici, che a la sua opera ànno
condotto —sono circostanze tutte, che prestano a l'analisi fromentiniana vivo significato:
l'affetto per i primitivi, la sconfinata passione per il maggior fiammingo, non alterano
1 Mattres, pa,e. 14.