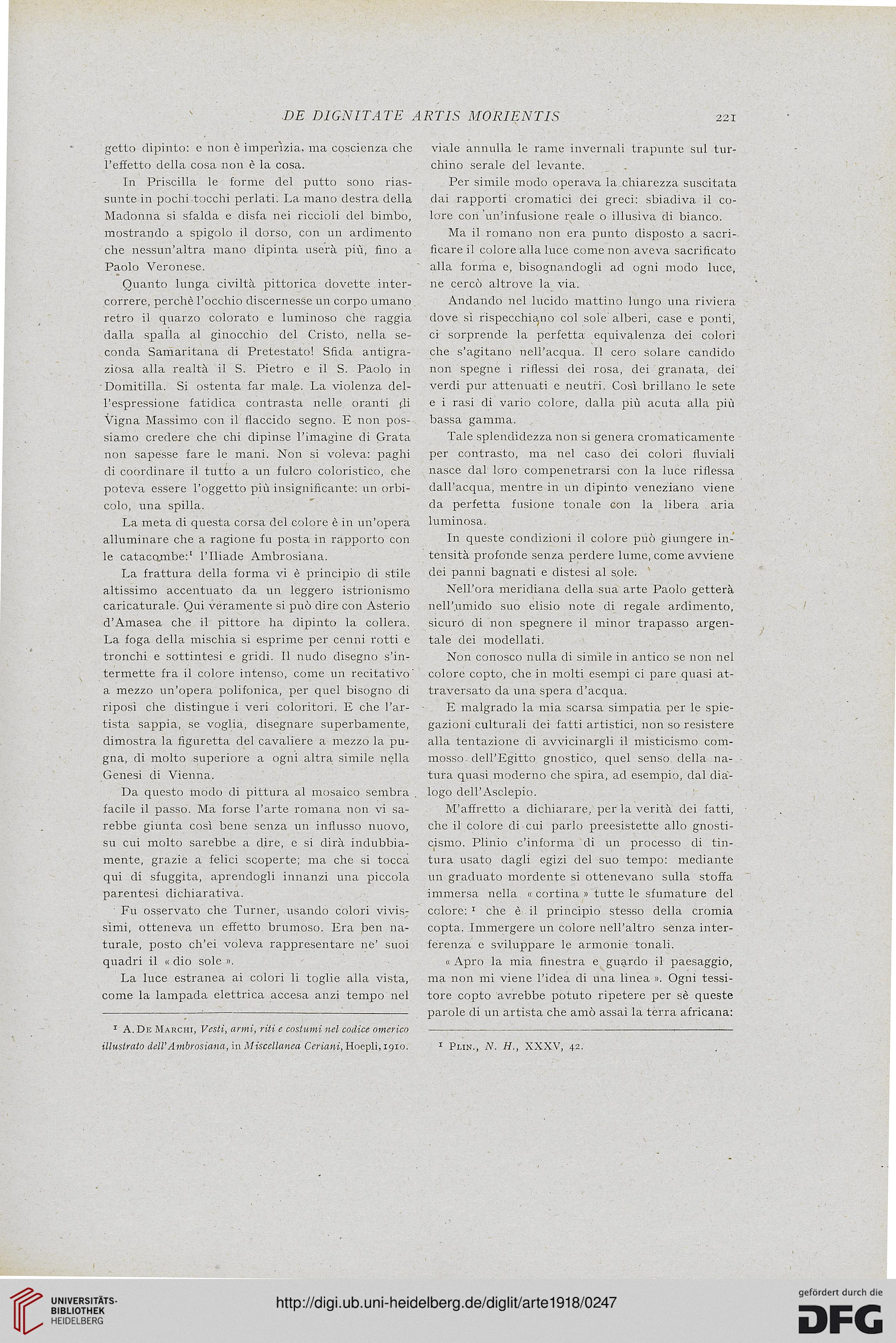DE D1GNITATE ARTIS MORIENTIS
221
getto dipinto: c non è imperizia, ma coscienza che
l'effetto della cosa non è la cosa.
In Priscilla le forme del putto sono rias-
sunte in pochi tocchi periati. La mano destra della
Madonna si sfalda e disfa nei riccioli del bimbo,
mostrando a spigolo il dorso, con un ardimento
che nessun'altra mano dipinta userà più, fino a
Paolo Veronese.
Quanto lunga civiltà pittorica dovette inter-
correre, perchè l'occhio discernesse un corpo umano
retro il quarzo colorato e luminoso che raggia
dalla spalla al ginocchio del Cristo, nella se-
conda Samaritana di Pretestato! Sfida antigra-
ziosa alla realtà il S. Pietro e il S. Paolo in
Domitilla. Si ostenta far male. La violenza del-
l'espressione fatidica contrasta nelle oranti {[i
Vigna Massimo con il flaccido segno. E non pos-
siamo credere che chi dipinse l'imagine di Grata
non sapesse fare le mani. Non si voleva: paghi
di coordinare il tutto a un fulcro coloristico, che
poteva essere l'oggetto più insignificante: un orbi-
colo, una spilla.
La meta di questa corsa del colore è in un'opera
alluminare che a ragione fu posta in rapporto con
le catacombe:1 l'Iliade Ambrosiana.
La frattura della forma vi è principio di stile
altissimo accentuato da un leggero istrionismo
caricaturale. Qui veramente si può dire con Asterio
d'Amasea che il pittore ha dipinto la collera.
La foga della mischia si esprime per cenni fotti e
tronchi e sottintesi e gridi. Il nudo disegno s'in-
termette fra il colore intenso, come un recitativo'
a mezzo un'opera polifonica, per quel bisogno di
riposi che distingue i veri coloritori. E che l'ar-
tista sappia, se voglia, disegnare superbamente,
dimostra la fìguretta del cavaliere a mezzo la pu-
gna, di molto superiore a ogni altra simile nella
Genesi di Vienna.
Da questo modo di pittura al mosaico sembra
facile il passo. Ma forse l'arte romana non vi sa-
rebbe giunta così bene senza un influsso nuovo,
su cui molto sarebbe a dire, e si dirà indubbia-
mente, grazie a felici scoperte; ma che si tocca
qui di sfuggita, aprendogli innanzi una piccola
parentesi dichiarativa.
' Fu osservato che Turner, usando colori vivis-
simi, otteneva un effetto brumoso. Era ben na-
turale, posto ch'ei voleva rappresentare ne' suoi
quadri il « dio sole ».
La luce estranea ai colori li toglie alla vista,
come la lampada elettrica accesa anzi tempo nel
1 A. De Marchi, Vesti, armi, riti e costumi nel codice omerico
illustrato dell' Ambrosiana, in M iscellanca Ceriani, Hoepli, 1910.
viale annulla le rame invernali trapunte sul tur-
chino serale del levante.
Per simile modo operava la chiarezza suscitata
dai rapporti cromatici dei greci: sbiadiva il co-
lore con un'infusione reale o illusiva di bianco.
Ma il romano non era punto disposto a sacri-
ficare il colore alla luce come non aveva sacrificato
alla forma e, bisognandogli ad ogni modo luce,
ne cercò altrove la via.
Andando nel lucido mattino lungo una riviera
dove si rispecchiano col sole alberi, case e ponti,
ci sorprende la perfetta equivalenza dei colori
che s'agitano nell'acqua. Il cero solare candido
non spegne i riflessi dei rosa, dei granata, dei
verdi pur attenuati e neutri. Così brillano le sete
e i rasi di vario colore, dalla più acuta alla più
bassa gamma.
Tale splendidezza non si genera cromaticamente
per contrasto, ma nel caso dei colori fluviali
nasce dal loro compenetrarsi con la luce riflessa
dall'acqua, mentre in un dipinto veneziano viene
da perfetta fusione tonale con la libera aria
luminosa.
In queste condizioni il colore può giungere in-
tensità profonde senza perdere lume, come avviene
dei panni bagnati e distesi al s.ole.
Nell'ora meridiana della sua arte Paolo getterà
nell'umido suo elisio note di regale ardimento,
sicuro di non spegnere il minor trapasso argen-
tale dei modellati.
Non conosco nulla di simile in antico se non nel
colore copto, che in molti esempi ci pare quasi at-
traversato da una spera d'acqua.
E malgrado la mia scarsa simpatia per le spie-
gazioni culturali dei fatti artistici, non so resistere
alla tentazione di avvicinargli il misticismo com-
mosso. dell'Egitto gnostico, quel senso della na-
tura quasi moderno che spira, ad esempio, dal dia-
logo dell'Asclepio.
M'affretto a dichiarare, per la verità dei fatti,
che il colore di ■ cui parlo preesistette allo gnosti-
cismo. Plinio c'informa di un processo di tin-
tura usato dagli egizi del suo tempo: mediante
un graduato mordente si ottenevano sulla stoffa
immersa nella « cortina » tutte le sfumature del
colore: 1 che è il principio stesso della cromia
copta. Immergere un colore nell'altro senza inter-
ferenza e sviluppare le armonie tonali.
« Apro la mia finestra e guardo il paesaggio,
ma non mi viene l'idea di una linea ». Ogni tessi-
tore copto avrebbe potuto ripetere per sè queste
parole di un artista che amò assai la terra africana:
1 Plin., N. H., XXXV, 42.
221
getto dipinto: c non è imperizia, ma coscienza che
l'effetto della cosa non è la cosa.
In Priscilla le forme del putto sono rias-
sunte in pochi tocchi periati. La mano destra della
Madonna si sfalda e disfa nei riccioli del bimbo,
mostrando a spigolo il dorso, con un ardimento
che nessun'altra mano dipinta userà più, fino a
Paolo Veronese.
Quanto lunga civiltà pittorica dovette inter-
correre, perchè l'occhio discernesse un corpo umano
retro il quarzo colorato e luminoso che raggia
dalla spalla al ginocchio del Cristo, nella se-
conda Samaritana di Pretestato! Sfida antigra-
ziosa alla realtà il S. Pietro e il S. Paolo in
Domitilla. Si ostenta far male. La violenza del-
l'espressione fatidica contrasta nelle oranti {[i
Vigna Massimo con il flaccido segno. E non pos-
siamo credere che chi dipinse l'imagine di Grata
non sapesse fare le mani. Non si voleva: paghi
di coordinare il tutto a un fulcro coloristico, che
poteva essere l'oggetto più insignificante: un orbi-
colo, una spilla.
La meta di questa corsa del colore è in un'opera
alluminare che a ragione fu posta in rapporto con
le catacombe:1 l'Iliade Ambrosiana.
La frattura della forma vi è principio di stile
altissimo accentuato da un leggero istrionismo
caricaturale. Qui veramente si può dire con Asterio
d'Amasea che il pittore ha dipinto la collera.
La foga della mischia si esprime per cenni fotti e
tronchi e sottintesi e gridi. Il nudo disegno s'in-
termette fra il colore intenso, come un recitativo'
a mezzo un'opera polifonica, per quel bisogno di
riposi che distingue i veri coloritori. E che l'ar-
tista sappia, se voglia, disegnare superbamente,
dimostra la fìguretta del cavaliere a mezzo la pu-
gna, di molto superiore a ogni altra simile nella
Genesi di Vienna.
Da questo modo di pittura al mosaico sembra
facile il passo. Ma forse l'arte romana non vi sa-
rebbe giunta così bene senza un influsso nuovo,
su cui molto sarebbe a dire, e si dirà indubbia-
mente, grazie a felici scoperte; ma che si tocca
qui di sfuggita, aprendogli innanzi una piccola
parentesi dichiarativa.
' Fu osservato che Turner, usando colori vivis-
simi, otteneva un effetto brumoso. Era ben na-
turale, posto ch'ei voleva rappresentare ne' suoi
quadri il « dio sole ».
La luce estranea ai colori li toglie alla vista,
come la lampada elettrica accesa anzi tempo nel
1 A. De Marchi, Vesti, armi, riti e costumi nel codice omerico
illustrato dell' Ambrosiana, in M iscellanca Ceriani, Hoepli, 1910.
viale annulla le rame invernali trapunte sul tur-
chino serale del levante.
Per simile modo operava la chiarezza suscitata
dai rapporti cromatici dei greci: sbiadiva il co-
lore con un'infusione reale o illusiva di bianco.
Ma il romano non era punto disposto a sacri-
ficare il colore alla luce come non aveva sacrificato
alla forma e, bisognandogli ad ogni modo luce,
ne cercò altrove la via.
Andando nel lucido mattino lungo una riviera
dove si rispecchiano col sole alberi, case e ponti,
ci sorprende la perfetta equivalenza dei colori
che s'agitano nell'acqua. Il cero solare candido
non spegne i riflessi dei rosa, dei granata, dei
verdi pur attenuati e neutri. Così brillano le sete
e i rasi di vario colore, dalla più acuta alla più
bassa gamma.
Tale splendidezza non si genera cromaticamente
per contrasto, ma nel caso dei colori fluviali
nasce dal loro compenetrarsi con la luce riflessa
dall'acqua, mentre in un dipinto veneziano viene
da perfetta fusione tonale con la libera aria
luminosa.
In queste condizioni il colore può giungere in-
tensità profonde senza perdere lume, come avviene
dei panni bagnati e distesi al s.ole.
Nell'ora meridiana della sua arte Paolo getterà
nell'umido suo elisio note di regale ardimento,
sicuro di non spegnere il minor trapasso argen-
tale dei modellati.
Non conosco nulla di simile in antico se non nel
colore copto, che in molti esempi ci pare quasi at-
traversato da una spera d'acqua.
E malgrado la mia scarsa simpatia per le spie-
gazioni culturali dei fatti artistici, non so resistere
alla tentazione di avvicinargli il misticismo com-
mosso. dell'Egitto gnostico, quel senso della na-
tura quasi moderno che spira, ad esempio, dal dia-
logo dell'Asclepio.
M'affretto a dichiarare, per la verità dei fatti,
che il colore di ■ cui parlo preesistette allo gnosti-
cismo. Plinio c'informa di un processo di tin-
tura usato dagli egizi del suo tempo: mediante
un graduato mordente si ottenevano sulla stoffa
immersa nella « cortina » tutte le sfumature del
colore: 1 che è il principio stesso della cromia
copta. Immergere un colore nell'altro senza inter-
ferenza e sviluppare le armonie tonali.
« Apro la mia finestra e guardo il paesaggio,
ma non mi viene l'idea di una linea ». Ogni tessi-
tore copto avrebbe potuto ripetere per sè queste
parole di un artista che amò assai la terra africana:
1 Plin., N. H., XXXV, 42.