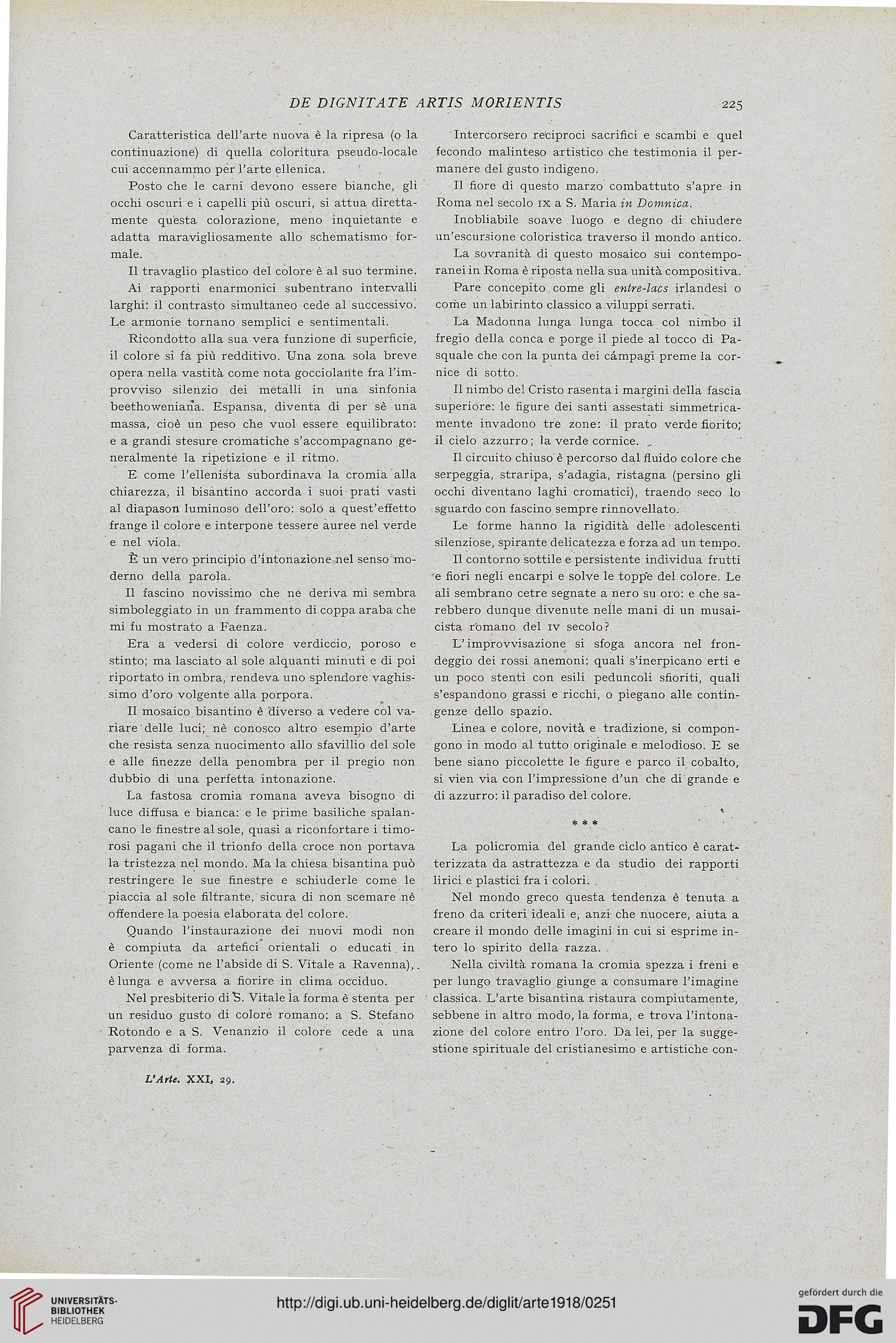DE DIGNITÀ TE ARTIS MORIENTIS
225
Caratteristica dell'arte nuova è la ripresa (o la
continuazione) di quella coloritura pseudo-locale
cui accennammo per l'arte ellenica.
Posto che le carni devono essere bianche, gli
occhi oscuri e i capelli più oscuri, si attua diretta-
mente questa colorazione, meno inquietante e
adatta maravigliosamente allo schematismo for-
male.
Il travaglio plastico del colore1 è al suo termine.
Ai rapporti enarmonici subentrano intervalli
larghi: il contrasto simultaneo cede al successivo.
Le armonie tornano semplici e sentimentali.
Ricondotto alla sua vera funzione di superficie,
il colore si fa più redditivo. Una zona sola breve
opera nella vastità come nota gocciolante fra l'im-
provviso silenzio dei metalli in una sinfonia
beethoweniana. Espansa, diventa di per sè una
massa, cioè un peso che vuol essere equilibrato:
e a grandi stesure cromatiche s'accompagnano ge-
neralmente la ripetizione e il ritmo.
E come l'ellenista subordinava la cromia alla
chiarezza, il bisantino accorda i suoi prati vasti
al diapason luminoso dell'oro: solò a quest'effetto
frange il colore e interpone tessere auree nel verde
e nel viola.
È un vero principio d'intonazione nel senso mo-
derno della parola.
Il fascino novissimo che ne deriva mi sembra
simboleggiato in un frammento di coppa araba che
mi fu mostrato a Faenza.
Era a vedersi di colore verdiccio, poroso e
stinto; ma lasciato al sole alquanti minuti e di poi
riportato in ombra, rendeva uno splendore vaghis-
simo d'oro volgente alla porpora.
Il mosaico bisantino è diverso a vedere col va-
riare delle luci; nè conosco altro esempio d'arte
che resista senza nuocimento allo sfavillio del sole
e alle finezze della penombra per il pregio non
dubbio di una perfetta intonazione.
La fastosa cromia romana aveva bisogno di
luce diffusa e bianca: e le prime basiliche spalan-
cano le finestre al sole, quasi a riconfortare i timo-
rosi pagani che il trionfo della croce non portava
la tristezza nel mondo. Ma la chiesa bisantina può
restringere le sue finestre e schiuderle come le
piaccia al sole filtrante, sicura di non scemare nè
offendere la poesia elaborata del colore.
Quando l'instaurazione dei nuovi modi non.
è compiuta da artefici orientali o educati . in
Oriente (come ne l'abside di S. Vitale a Ravenna),,
è lunga e avversa a fiorire in clima occiduo.
Nel presbiterio diS. Vitale la forma è stenta per
un residuo gusto di colore romano: a S. Stefano
Rotondo e a S. Venanzio il colore cede a una
parvenza di forma. '
Intercorsero reciproci sacrifici e scambi e quel
fecondo malinteso artistico che testimonia il per-
manere del gusto indigeno.
Il fiore di questo marzo combattuto s'apre in
Roma nel secolo IX a S. Maria in Domnica.
Inobliabile soave luogo e degno di chiudere
un'escursione coloristica traverso il mondo antico.
La sovranità di questo mosaico sui contempo-
ranei in Roma è riposta nella sua unità compositiva.
Pare concepito come gli entre-lacs irlandesi o
come un labirinto classico a viluppi serrati.
. La Madonna lunga lunga tocca col nimbo il
fregio della conca e porge il piede al tocco di Pa-
squale che con la punta dei càmpagi preme la cor-
nice di sotto.
Il nimbo del Cristo rasenta i margini della fascia
superiore: le figure dei santi assestati simmetrica-
mente invadono tre zone: il prato verde fiorito;
il cielo azzurro; la verde cornice. ,
Il circuito chiuso è percorso dal fluido colore che
serpeggia, straripa, s'adagia, ristagna (persino gli
occhi diventano laghi cromatici), traendo seco lo
sguardo con fascino sempre rinnovellato.
Le forme hanno la rigidità delle adolescenti
silenziose, spirante delicatezza e forza ad un tempo.
Il contorno sottile e persistente individua frutti
'e fiori negli encarpi e solve le toppe del colore. Le
ali sembrano cetre segnate a nero su oro: e che sa-
rebbero dunque divenute nelle mani di un musai-
cista romano del iv secolo?
L'improvvisazione si sfoga ancora nel fron-
deggio dei rossi anemoni: quali s'inerpicano erti e
vin poco stenti con esili peduncoli sfioriti, quali
s'espandono grassi e ricchi, o piegano alle contin-
genze dello spazio.
Linea e colore, novità e tradizione, si compon-
gono in modo al tutto originale e melodioso. E se
bene siano piccolette le figure e parco il cobalto,
si vien via con l'impressione d'un che di grande e
di azzurro: il paradiso del colore.
*
La policromia del grande ciclo antico è carat-
terizzata da astrattezza e da studio dei rapporti
lirici e plastici fra i colori. .
Nel mondo greco questa tendenza è tenuta a
freno da criteri ideali e, anzi che nuocere, aiuta a
creare il mondo delle imagini in cui si esprime in-
tero lo spirito della razza.
Nella civiltà romana la cromia spezza i freni e
per lungo travaglio giunge a consumare l'imagine
classica. L'arte bisantina ristaura compiutamente,
sebbene in altro modo, la forma, e trova l'intona-
zione del colore entro l'oro. Da lei, per la sugge-
stione spirituale del cristianesimo e artistiche con-
L'Arte. XXI, 29.
225
Caratteristica dell'arte nuova è la ripresa (o la
continuazione) di quella coloritura pseudo-locale
cui accennammo per l'arte ellenica.
Posto che le carni devono essere bianche, gli
occhi oscuri e i capelli più oscuri, si attua diretta-
mente questa colorazione, meno inquietante e
adatta maravigliosamente allo schematismo for-
male.
Il travaglio plastico del colore1 è al suo termine.
Ai rapporti enarmonici subentrano intervalli
larghi: il contrasto simultaneo cede al successivo.
Le armonie tornano semplici e sentimentali.
Ricondotto alla sua vera funzione di superficie,
il colore si fa più redditivo. Una zona sola breve
opera nella vastità come nota gocciolante fra l'im-
provviso silenzio dei metalli in una sinfonia
beethoweniana. Espansa, diventa di per sè una
massa, cioè un peso che vuol essere equilibrato:
e a grandi stesure cromatiche s'accompagnano ge-
neralmente la ripetizione e il ritmo.
E come l'ellenista subordinava la cromia alla
chiarezza, il bisantino accorda i suoi prati vasti
al diapason luminoso dell'oro: solò a quest'effetto
frange il colore e interpone tessere auree nel verde
e nel viola.
È un vero principio d'intonazione nel senso mo-
derno della parola.
Il fascino novissimo che ne deriva mi sembra
simboleggiato in un frammento di coppa araba che
mi fu mostrato a Faenza.
Era a vedersi di colore verdiccio, poroso e
stinto; ma lasciato al sole alquanti minuti e di poi
riportato in ombra, rendeva uno splendore vaghis-
simo d'oro volgente alla porpora.
Il mosaico bisantino è diverso a vedere col va-
riare delle luci; nè conosco altro esempio d'arte
che resista senza nuocimento allo sfavillio del sole
e alle finezze della penombra per il pregio non
dubbio di una perfetta intonazione.
La fastosa cromia romana aveva bisogno di
luce diffusa e bianca: e le prime basiliche spalan-
cano le finestre al sole, quasi a riconfortare i timo-
rosi pagani che il trionfo della croce non portava
la tristezza nel mondo. Ma la chiesa bisantina può
restringere le sue finestre e schiuderle come le
piaccia al sole filtrante, sicura di non scemare nè
offendere la poesia elaborata del colore.
Quando l'instaurazione dei nuovi modi non.
è compiuta da artefici orientali o educati . in
Oriente (come ne l'abside di S. Vitale a Ravenna),,
è lunga e avversa a fiorire in clima occiduo.
Nel presbiterio diS. Vitale la forma è stenta per
un residuo gusto di colore romano: a S. Stefano
Rotondo e a S. Venanzio il colore cede a una
parvenza di forma. '
Intercorsero reciproci sacrifici e scambi e quel
fecondo malinteso artistico che testimonia il per-
manere del gusto indigeno.
Il fiore di questo marzo combattuto s'apre in
Roma nel secolo IX a S. Maria in Domnica.
Inobliabile soave luogo e degno di chiudere
un'escursione coloristica traverso il mondo antico.
La sovranità di questo mosaico sui contempo-
ranei in Roma è riposta nella sua unità compositiva.
Pare concepito come gli entre-lacs irlandesi o
come un labirinto classico a viluppi serrati.
. La Madonna lunga lunga tocca col nimbo il
fregio della conca e porge il piede al tocco di Pa-
squale che con la punta dei càmpagi preme la cor-
nice di sotto.
Il nimbo del Cristo rasenta i margini della fascia
superiore: le figure dei santi assestati simmetrica-
mente invadono tre zone: il prato verde fiorito;
il cielo azzurro; la verde cornice. ,
Il circuito chiuso è percorso dal fluido colore che
serpeggia, straripa, s'adagia, ristagna (persino gli
occhi diventano laghi cromatici), traendo seco lo
sguardo con fascino sempre rinnovellato.
Le forme hanno la rigidità delle adolescenti
silenziose, spirante delicatezza e forza ad un tempo.
Il contorno sottile e persistente individua frutti
'e fiori negli encarpi e solve le toppe del colore. Le
ali sembrano cetre segnate a nero su oro: e che sa-
rebbero dunque divenute nelle mani di un musai-
cista romano del iv secolo?
L'improvvisazione si sfoga ancora nel fron-
deggio dei rossi anemoni: quali s'inerpicano erti e
vin poco stenti con esili peduncoli sfioriti, quali
s'espandono grassi e ricchi, o piegano alle contin-
genze dello spazio.
Linea e colore, novità e tradizione, si compon-
gono in modo al tutto originale e melodioso. E se
bene siano piccolette le figure e parco il cobalto,
si vien via con l'impressione d'un che di grande e
di azzurro: il paradiso del colore.
*
La policromia del grande ciclo antico è carat-
terizzata da astrattezza e da studio dei rapporti
lirici e plastici fra i colori. .
Nel mondo greco questa tendenza è tenuta a
freno da criteri ideali e, anzi che nuocere, aiuta a
creare il mondo delle imagini in cui si esprime in-
tero lo spirito della razza.
Nella civiltà romana la cromia spezza i freni e
per lungo travaglio giunge a consumare l'imagine
classica. L'arte bisantina ristaura compiutamente,
sebbene in altro modo, la forma, e trova l'intona-
zione del colore entro l'oro. Da lei, per la sugge-
stione spirituale del cristianesimo e artistiche con-
L'Arte. XXI, 29.