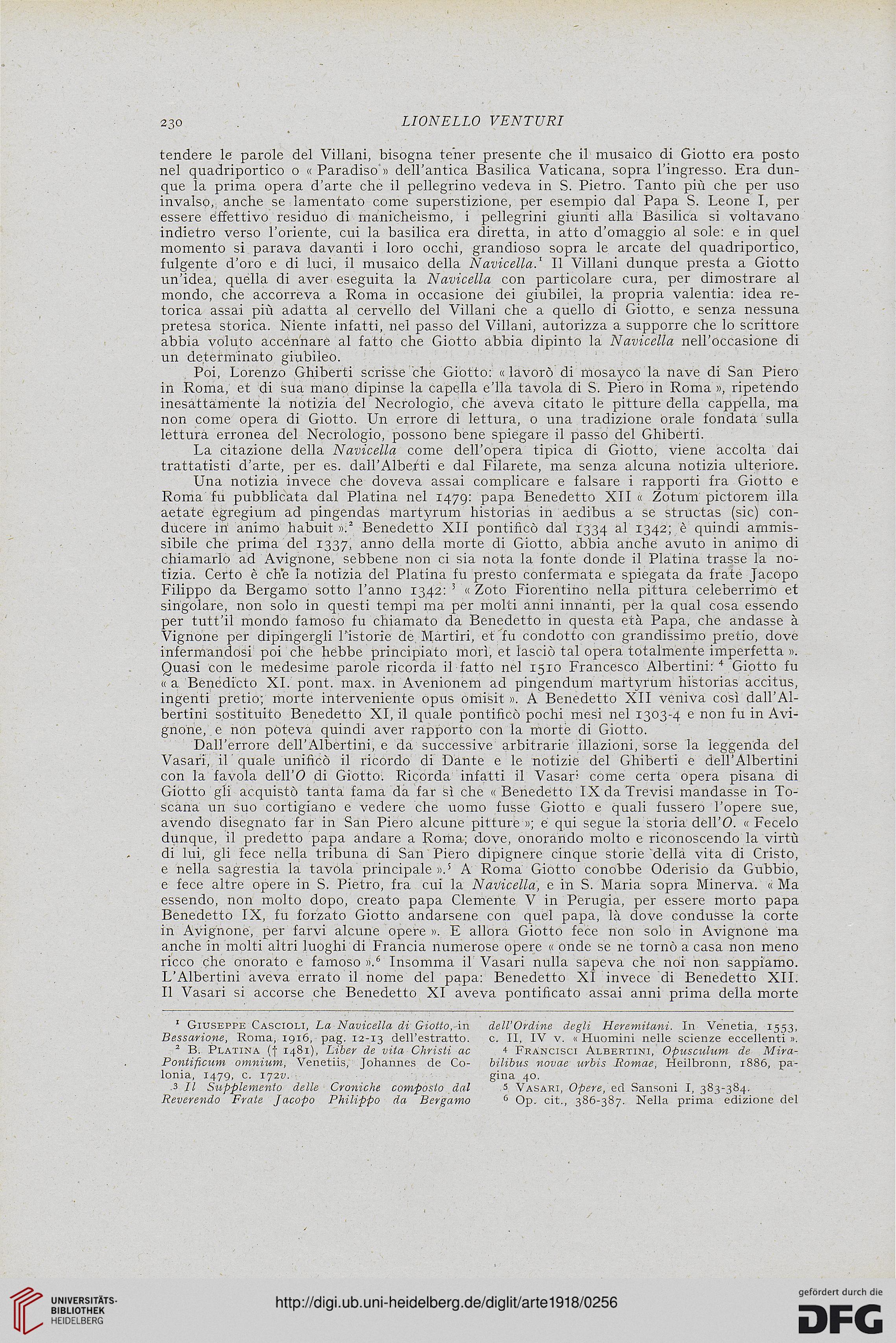230
LIONELLO VENTURI
tendere le parole del Villani, bisogna tener presente che il musaico di Giotto era posto
nel quadriportico o « Paradiso » dell'antica Basilica Vaticana, sopra l'ingresso. Era dun-
que la prima opera d'arte che il pellegrino vedeva in S. Pietro. Tanto più che per uso
invalso, anche se lamentato come superstizione, per esempio dal Papa S. Leone I, per
essere effettivo residuo di manicheismo, i pellegrini giunti alla Basilica si voltavano
indietro verso l'oriente, cui la basilica era diretta, in atto d'omaggio al sole: e in quel
momento si parava davanti i loro occhi, grandioso sopra le arcate del quadriportico,
fulgente d'oro e di luci, il musaico della Navicella.1 Il Villani dunque presta a Giotto
un'idea, quella di aver eseguita la Navicella con particolare cura, per dimostrare al
mondo, che accorreva a Roma in occasione dei giubilei, la propria valentia: idea re-
torica assai più adatta al cervello del Villani che a quello di Giotto, e senza nessuna
pretesa storica. Niente infatti, nel passo del Villani, autorizza a supporre che lo scrittore
abbia voluto accennare al fatto che Giotto abbia dipinto la Navicella nell'occasione di
un determinato giubileo.
Poi, Lorenzo Ghiberti scrisse che Giotto: «lavorò di mosayco la nave di San Piero
in Roma, et di sua mano dipinse la capella e'ila tavola di S. Piero in Roma », ripetendo
inesattamente la notizia del Necrologio, che aveva citato le pitture della cappella, ma
non come opera di Giotto. Un errore di lettura, o una tradizione orale fondata sulla
lettura erronea del Necrologio, possono bene spiegare il passo del Ghiberti.
La citazione della Navicella come dell'opera tipica di Giotto, viene accolta dai
trattatisti d'arte, per es. dall'Alberti e dal Filarete, ma senza alcuna notizia ulteriore.
Una notizia invece che doveva assai complicare e falsare i rapporti fra Giotto e
Roma fu pubblicata dal Platina nel 1479: papa Benedetto XII « Zotum pictorem illa
aetate egregium ad pingendas martyrum historias in aedibus a se structas (sic) con-
ducere in animo habuìt ».2 Benedetto XII pontificò dal 1334 al 1342; è quindi ammis-
sibile che prima del 1337, anno della morte di Giotto, abbia anche avuto in animo di
chiamarlo ad Avignone, sebbene non ci sia nota la fonte donde il Platina trasse la no-
tizia. Certo è che la notizia del Platina fu presto confermata e spiegata da frate Jacopo
Filippo da Bergamo sotto l'anno 1342: 3 « Zoto Fiorentino nella pittura celeberrimo et
singolare, non solo in questi tempi ma per molti anni innanti, per la qual cosa essendo
per tuffil mondo famoso fu chiamato da Benedetto in questa età Papa, che andasse à
Vignone per dipingergli l'istorie de Martiri, et fu condotto con grandissimo pretio, dove
infermandosi poi che hebbe principiato morì, et lasciò tal opera totalmente imperfetta ».
Quasi con le medesime parole ricorda il fatto nel 1510 Francesco Albertini: 4 Giotto fu
« a. Benédicto XI. pont. max. in Avenionem ad pingendum martyrum historias accitus,
ingenti pretio; morte interveniente opus omisit ». A Benedetto XII veniva così dall'Al-
bertini sostituito Benedetto XI, il quale pontificò pochi mesi nel 1303-4 e non fu in Avi-
gnone,, e non poteva quindi aver rapporto con la morte di Giotto.
Dall'errore dell'Albertini, e da successive arbitrarie illazioni, sorse la leggenda del
Vasari, il 'quale unificò il ricordo di Dante e le notizie del Ghiberti e dell'Albertini
con la favola dell'O di Giotto. Ricorda infatti il Vasari come certa opera pisana di
Giotto gli acquistò tanta fama da far sì che « Benedetto IX daTrevisi mandasse in To-
scana un suo cortigiano e vedere che uomo fusse Giotto e quali lusserò l'opere sue,
avendo disegnato far in San Piero alcune pitture »; e qui segue la storia dell'O. « Fecelo
dunque, il predetto papa andare a Roma; dove, onorando molto e riconoscendo la virtù
di lui, gli fece nella tribuna di San Piero dipignere cinque storie della vita di Cristo,
e nella sagrestia la tavola principale ».s A Roma Giotto conobbe Oderisio da Gubbio,
e fece altre opere in S. Pietro, fra cui la Navicella, e in S. Maria sopra Minerva. « Ma
essendo, non molto dopo, creato papa Clemente V in Perugia, per essere morto papa
Benedetto IX, fu forzato Giotto andarsene con quel papa, là dove condusse la corte
in Avignone, per farvi alcune opere ». E allora Giotto fece non solo in Avignone ma
anche in molti altri luoghi di Francia numerose opere « onde se ne tornò a casa non meno
ricco che onorato e famoso ».6 Insomma il Vasari nulla sapeva che noi non sappiamo.
L'Albertini aveva errato il nome del papa: Benedetto XI invece "di Benedetto XII.
Il Vasari si accorse che Benedetto XI aveva pontificato assai anni prima della morte
1 Giuseppe Cascioli, La Navicella di Giotto, -in
Bessavione, Roma, 1916, pag. 12-13 dell'estratto.
2 B. Platina (f 1481), Liber de vita Christi ac
Pontificum omnium, Venetiis, Johannes de Co-
lonia, 1479, c. IJ2V. ■
3 II Supplemento delle Croniche composto dal
Reverendo Frate Jacopo Philippo da Bergamo
dell'Ordine degli Heremitani. In Venetia, 1553,
c. II, IV v. « Huomini nelle scienze eccellenti ».
■* Francisci Albertini, Opusculum de Mìra-
bilibus novae urbis Romae, Heilbronn, 1886, pa-
gina 40.
5 Vasari, Opere, ed Sansoni I, 383-384.
6 Op. cit., 386-387. Nella prima edizione del
LIONELLO VENTURI
tendere le parole del Villani, bisogna tener presente che il musaico di Giotto era posto
nel quadriportico o « Paradiso » dell'antica Basilica Vaticana, sopra l'ingresso. Era dun-
que la prima opera d'arte che il pellegrino vedeva in S. Pietro. Tanto più che per uso
invalso, anche se lamentato come superstizione, per esempio dal Papa S. Leone I, per
essere effettivo residuo di manicheismo, i pellegrini giunti alla Basilica si voltavano
indietro verso l'oriente, cui la basilica era diretta, in atto d'omaggio al sole: e in quel
momento si parava davanti i loro occhi, grandioso sopra le arcate del quadriportico,
fulgente d'oro e di luci, il musaico della Navicella.1 Il Villani dunque presta a Giotto
un'idea, quella di aver eseguita la Navicella con particolare cura, per dimostrare al
mondo, che accorreva a Roma in occasione dei giubilei, la propria valentia: idea re-
torica assai più adatta al cervello del Villani che a quello di Giotto, e senza nessuna
pretesa storica. Niente infatti, nel passo del Villani, autorizza a supporre che lo scrittore
abbia voluto accennare al fatto che Giotto abbia dipinto la Navicella nell'occasione di
un determinato giubileo.
Poi, Lorenzo Ghiberti scrisse che Giotto: «lavorò di mosayco la nave di San Piero
in Roma, et di sua mano dipinse la capella e'ila tavola di S. Piero in Roma », ripetendo
inesattamente la notizia del Necrologio, che aveva citato le pitture della cappella, ma
non come opera di Giotto. Un errore di lettura, o una tradizione orale fondata sulla
lettura erronea del Necrologio, possono bene spiegare il passo del Ghiberti.
La citazione della Navicella come dell'opera tipica di Giotto, viene accolta dai
trattatisti d'arte, per es. dall'Alberti e dal Filarete, ma senza alcuna notizia ulteriore.
Una notizia invece che doveva assai complicare e falsare i rapporti fra Giotto e
Roma fu pubblicata dal Platina nel 1479: papa Benedetto XII « Zotum pictorem illa
aetate egregium ad pingendas martyrum historias in aedibus a se structas (sic) con-
ducere in animo habuìt ».2 Benedetto XII pontificò dal 1334 al 1342; è quindi ammis-
sibile che prima del 1337, anno della morte di Giotto, abbia anche avuto in animo di
chiamarlo ad Avignone, sebbene non ci sia nota la fonte donde il Platina trasse la no-
tizia. Certo è che la notizia del Platina fu presto confermata e spiegata da frate Jacopo
Filippo da Bergamo sotto l'anno 1342: 3 « Zoto Fiorentino nella pittura celeberrimo et
singolare, non solo in questi tempi ma per molti anni innanti, per la qual cosa essendo
per tuffil mondo famoso fu chiamato da Benedetto in questa età Papa, che andasse à
Vignone per dipingergli l'istorie de Martiri, et fu condotto con grandissimo pretio, dove
infermandosi poi che hebbe principiato morì, et lasciò tal opera totalmente imperfetta ».
Quasi con le medesime parole ricorda il fatto nel 1510 Francesco Albertini: 4 Giotto fu
« a. Benédicto XI. pont. max. in Avenionem ad pingendum martyrum historias accitus,
ingenti pretio; morte interveniente opus omisit ». A Benedetto XII veniva così dall'Al-
bertini sostituito Benedetto XI, il quale pontificò pochi mesi nel 1303-4 e non fu in Avi-
gnone,, e non poteva quindi aver rapporto con la morte di Giotto.
Dall'errore dell'Albertini, e da successive arbitrarie illazioni, sorse la leggenda del
Vasari, il 'quale unificò il ricordo di Dante e le notizie del Ghiberti e dell'Albertini
con la favola dell'O di Giotto. Ricorda infatti il Vasari come certa opera pisana di
Giotto gli acquistò tanta fama da far sì che « Benedetto IX daTrevisi mandasse in To-
scana un suo cortigiano e vedere che uomo fusse Giotto e quali lusserò l'opere sue,
avendo disegnato far in San Piero alcune pitture »; e qui segue la storia dell'O. « Fecelo
dunque, il predetto papa andare a Roma; dove, onorando molto e riconoscendo la virtù
di lui, gli fece nella tribuna di San Piero dipignere cinque storie della vita di Cristo,
e nella sagrestia la tavola principale ».s A Roma Giotto conobbe Oderisio da Gubbio,
e fece altre opere in S. Pietro, fra cui la Navicella, e in S. Maria sopra Minerva. « Ma
essendo, non molto dopo, creato papa Clemente V in Perugia, per essere morto papa
Benedetto IX, fu forzato Giotto andarsene con quel papa, là dove condusse la corte
in Avignone, per farvi alcune opere ». E allora Giotto fece non solo in Avignone ma
anche in molti altri luoghi di Francia numerose opere « onde se ne tornò a casa non meno
ricco che onorato e famoso ».6 Insomma il Vasari nulla sapeva che noi non sappiamo.
L'Albertini aveva errato il nome del papa: Benedetto XI invece "di Benedetto XII.
Il Vasari si accorse che Benedetto XI aveva pontificato assai anni prima della morte
1 Giuseppe Cascioli, La Navicella di Giotto, -in
Bessavione, Roma, 1916, pag. 12-13 dell'estratto.
2 B. Platina (f 1481), Liber de vita Christi ac
Pontificum omnium, Venetiis, Johannes de Co-
lonia, 1479, c. IJ2V. ■
3 II Supplemento delle Croniche composto dal
Reverendo Frate Jacopo Philippo da Bergamo
dell'Ordine degli Heremitani. In Venetia, 1553,
c. II, IV v. « Huomini nelle scienze eccellenti ».
■* Francisci Albertini, Opusculum de Mìra-
bilibus novae urbis Romae, Heilbronn, 1886, pa-
gina 40.
5 Vasari, Opere, ed Sansoni I, 383-384.
6 Op. cit., 386-387. Nella prima edizione del