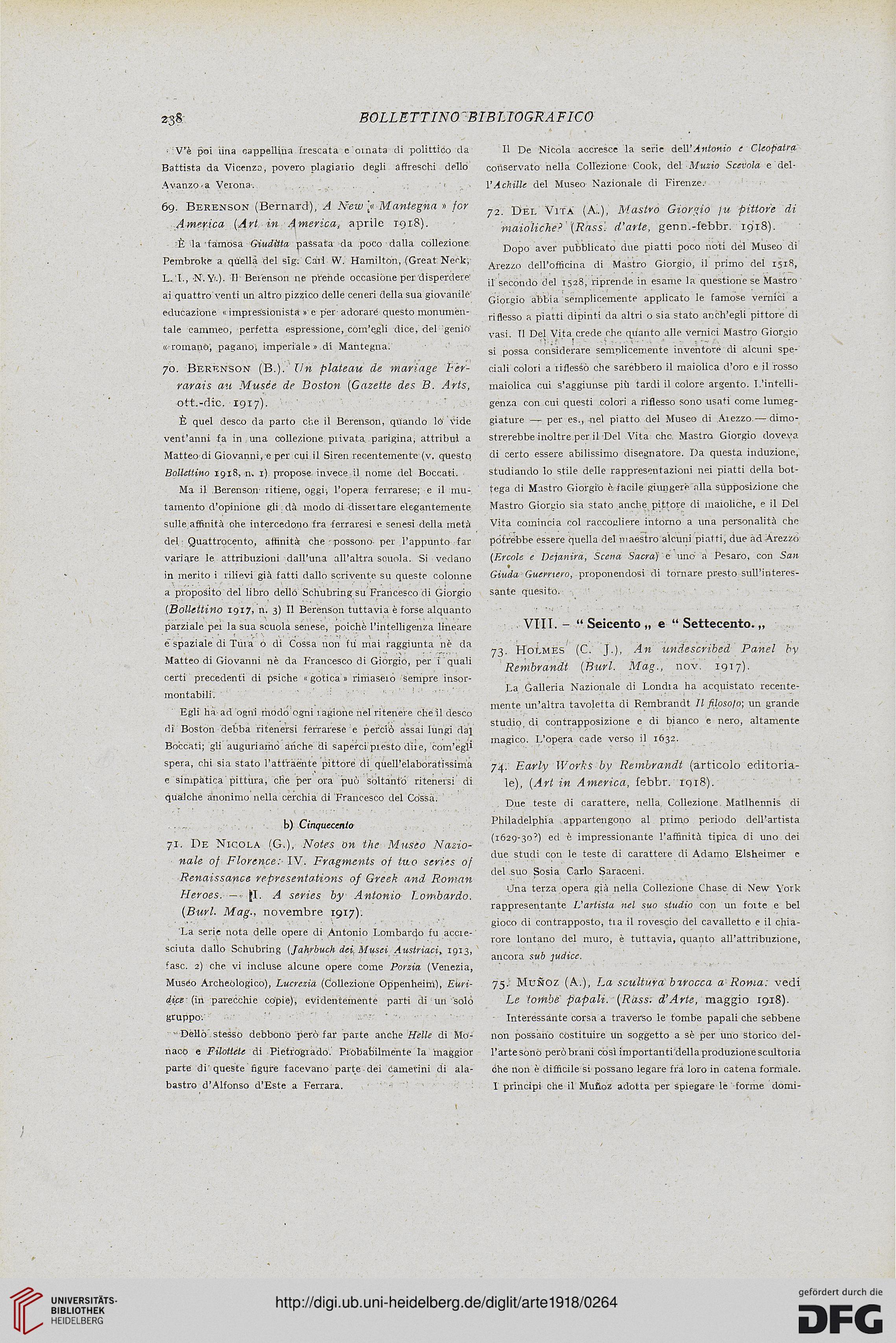23§
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
■ :V'è poi una cappellina trescata e ornata di polittico da
Battista da Vicenza, povero plagiario degli affreschi dello
Avanzo•* Verona-., . ■• :,; ... -.; .-..">.
69. Berenson (Bernard), A New [« Mantegna » far
America (Art in America, aprile 1918).
È la famosa Giuditta passata da poco dalla collezione
Pembroke a quella del Big:' Cali-W. Hamilton, (Great Nerk,
L.. L, -N. Y'.)- Il-Berenson ne prende occasione per disperdere'
ai quattro venti un altro pizzico delle ceneri della sua giovanile'
educazione « impressionista »' e per adoraré qiresto monumen-
tale cammeo, perfetta espressione, com'egli dice, del genio
« romano, pagano; imperiale » di Mantegnal
70. Berenson (B.). Un plateau de mariane Fèr-
rarais aie Musée de Boston (Gazette des B. Aris,
ott.-dic. 1917).
È quel desco da parto che il Berenson, quando lo Vide
vent'anni fa in una collezione privata .parigina, attribuì a
Matteo di Giovanni, e per cui il Siren recentemente (v. questo
Bollettino 1918, n, 1) propose invece il nome del Boccali.
Ma il Berenson' ritiene, oggi, l'opera ferrarese; e il mu-
tamento d'opinione gli dà modo di dissertare elegantemente
sulle affinità che intercedono fra ferraresi e senesi della metà
del. : Quattrocento, affinità che - possono- per .l'appunto far
variare le attribuzioni dall'una all'altra scuola. Si vedano
in merito i rilievi già fatti dallo scrivente su queste colonne
a proposito del libro dello Schubring su Francesco di Giorgio
(Bollettino 1917, n. 3) Il Berenson tuttavia è forse alquanto
parziale per la sua scuola senese, poiché l'intelligenza lineare
e" spaziale di Tura o di Cossa non fu mai raggiunta ne da
Matteo di Giovanni né da Francesco di Giorgio, per 1"quali
certi precedenti di psiche «gotica» rimasero sempre insor-
montabili.
Egli ha ad ogni modo ogni ragione nel ritenere che il desco
di Boston debba ritenersi ferrarese e perciò assai lungi dal
Beccati; gli auguriamo anche di saperci piesto due, com'egli
spera, chi sia stato l'attraènte pittore eli quell'elaboratissima
e simpàtica pittura, che per ora può soltanto ritenersi' di
qualche anonimo nella cerchia di Francesco del Còssa.
b) Cinquecento
71. De Nicola (G.), Notes bn the Museo Nazio-
nale of Florence:- IV. Fragments of tuo series oj
Renaissance representations of Greek and Roman
Heroes. — - |I, A series by Antonio lombardo.
(Buri. Mag., novembre 1917).
'La serie nota delle opere di Antonio Lombardo fu accre-
sciuta dallo Schubring (Jahrbuch dei, Musei Austriaci, 1913,
fase. 2) che vi incluse alcune opere come Porzia (Venezia,
Musèo Archeologico), Lucrezia (Collezione Oppenheim), Euri-
dice- (in parecchie copie), evidentemente parti di un solò
gruppo.
~ Dello stesso debbono però far parte anche Helle di Mo-
naco e Filottete di Pietrogrado. Probabilmente la maggior
parte di'queste figure facevano parte, dei camerini di ala-
bastro d'Alfonso d'Este a Ferrara.
Il De Nicola accresce la serie dell' Antonio e Cleopatra
conservato nella Collezione Cook, del Muzio Scevola e del-
l'Achille del Museo Nazionale di Firenze.'
72. Del Vita (A,.), Mastro Giorgio ju pittore di
maioliche? "{Rass', d'arte, genn.-febbr. 1918).
Dopo aver pubblicato due piatti poco noti del Museo di
Arezzo dell'officina di Mastro Giorgio, il primo del 1518,
il secondo del 1528, riprende, in esame la questione se Mastro '
Giorgio abbia semplicemente applicato le famose vernici a
riflesso a piatti dipinti da altri o sia stato anch'egli pittore di
vasi. Il Del Vita crede che quanto alle vernici Mastro Giorgio
si possa considerare semplicemente inventore di alcuni spe-
ciali colori a riflesso che sarebbero il maiolica d'oro e il rosso
maiolica cui s'aggiunse più tardi il colore argento. L'intelli-
genza con cui questi colori a riflesso sono usati come lumeg-
giature — per es., nel piatto del Museo di Arezzo.— dimo-
strerebbe inoltre per il-Del Vita che Mastro Giorgio doveva
di certo essere abilissimo disegnatore. Da questa induzione,
studiando lo stile delle rappresentazioni nei piatti della bot-
tega di Mastro Giorgio è facile giungere alla supposizione che
Mastro Giorgio sia stato anche pittore di maioliche, e il Del
Vita comincia col raccogliere intorno a una personalità che
potrebbe essere quella del maèstro alcuni piatti, due ad Arezzo
(Ercole e Dejanira, Scena Sacra)'■'e uno a Pesaro, con So»
Giuda Guerriero, proponendosi di tornare presto sull'interes-
sante quesito. "
Vili. - " Seicento „ e " Settecento.,,
73. Holmes (C. J.), An undescribed Panel by
Rembrandt (Buri. Mag., nov. 1917)-
La Galleria Nazionale di Londra ha acquistato recente-
mente un'altra tavoletta di Rembrandt II filoso/o; un grande
studio, di contrapposizione e di bianco e nero, altamente
magico. L'opera cade verso il 1632.
74. F.arly Works by Rembrandt (articolo editoria-
le), (Art in America, febbr. 1918).
. Due teste di carattere, nella, Collezione Matlhennis di
Philadelphia appartengono al primo periodo dell'artista
(1629-30?) ed è impressionante l'affinità tipica di uno dei
due studi con le teste di carattere di Adamo Elsheimer e
del suo Sosia Carlo Saraceni.
Lina terza opera già nella Collezione Chase di New York
rappresentante L'artista nel suo studio con un forte e bel
gioco di contrapposto, tra il rovescio del cavalletto e il chia-
rore lontano del muro, è tutravia, quanto all'attribuzione,
ancora sub judice.
75. MuSoz (A.), La scultura birocca a Roma: vedi
Le tombe' papali. (Rass. d'Arte, maggio 1918).
Interessante corsa a traverso le tombe papali che sebbene
non possano costituire un soggetto a sè per uno storico del-
l'arte sono però brani così importanti della produzione scultoria
che non è difficile si possano legare fra loro in catena formale.
I principi che il Mufioz adotta per spiegare le forme domi-
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
■ :V'è poi una cappellina trescata e ornata di polittico da
Battista da Vicenza, povero plagiario degli affreschi dello
Avanzo•* Verona-., . ■• :,; ... -.; .-..">.
69. Berenson (Bernard), A New [« Mantegna » far
America (Art in America, aprile 1918).
È la famosa Giuditta passata da poco dalla collezione
Pembroke a quella del Big:' Cali-W. Hamilton, (Great Nerk,
L.. L, -N. Y'.)- Il-Berenson ne prende occasione per disperdere'
ai quattro venti un altro pizzico delle ceneri della sua giovanile'
educazione « impressionista »' e per adoraré qiresto monumen-
tale cammeo, perfetta espressione, com'egli dice, del genio
« romano, pagano; imperiale » di Mantegnal
70. Berenson (B.). Un plateau de mariane Fèr-
rarais aie Musée de Boston (Gazette des B. Aris,
ott.-dic. 1917).
È quel desco da parto che il Berenson, quando lo Vide
vent'anni fa in una collezione privata .parigina, attribuì a
Matteo di Giovanni, e per cui il Siren recentemente (v. questo
Bollettino 1918, n, 1) propose invece il nome del Boccali.
Ma il Berenson' ritiene, oggi, l'opera ferrarese; e il mu-
tamento d'opinione gli dà modo di dissertare elegantemente
sulle affinità che intercedono fra ferraresi e senesi della metà
del. : Quattrocento, affinità che - possono- per .l'appunto far
variare le attribuzioni dall'una all'altra scuola. Si vedano
in merito i rilievi già fatti dallo scrivente su queste colonne
a proposito del libro dello Schubring su Francesco di Giorgio
(Bollettino 1917, n. 3) Il Berenson tuttavia è forse alquanto
parziale per la sua scuola senese, poiché l'intelligenza lineare
e" spaziale di Tura o di Cossa non fu mai raggiunta ne da
Matteo di Giovanni né da Francesco di Giorgio, per 1"quali
certi precedenti di psiche «gotica» rimasero sempre insor-
montabili.
Egli ha ad ogni modo ogni ragione nel ritenere che il desco
di Boston debba ritenersi ferrarese e perciò assai lungi dal
Beccati; gli auguriamo anche di saperci piesto due, com'egli
spera, chi sia stato l'attraènte pittore eli quell'elaboratissima
e simpàtica pittura, che per ora può soltanto ritenersi' di
qualche anonimo nella cerchia di Francesco del Còssa.
b) Cinquecento
71. De Nicola (G.), Notes bn the Museo Nazio-
nale of Florence:- IV. Fragments of tuo series oj
Renaissance representations of Greek and Roman
Heroes. — - |I, A series by Antonio lombardo.
(Buri. Mag., novembre 1917).
'La serie nota delle opere di Antonio Lombardo fu accre-
sciuta dallo Schubring (Jahrbuch dei, Musei Austriaci, 1913,
fase. 2) che vi incluse alcune opere come Porzia (Venezia,
Musèo Archeologico), Lucrezia (Collezione Oppenheim), Euri-
dice- (in parecchie copie), evidentemente parti di un solò
gruppo.
~ Dello stesso debbono però far parte anche Helle di Mo-
naco e Filottete di Pietrogrado. Probabilmente la maggior
parte di'queste figure facevano parte, dei camerini di ala-
bastro d'Alfonso d'Este a Ferrara.
Il De Nicola accresce la serie dell' Antonio e Cleopatra
conservato nella Collezione Cook, del Muzio Scevola e del-
l'Achille del Museo Nazionale di Firenze.'
72. Del Vita (A,.), Mastro Giorgio ju pittore di
maioliche? "{Rass', d'arte, genn.-febbr. 1918).
Dopo aver pubblicato due piatti poco noti del Museo di
Arezzo dell'officina di Mastro Giorgio, il primo del 1518,
il secondo del 1528, riprende, in esame la questione se Mastro '
Giorgio abbia semplicemente applicato le famose vernici a
riflesso a piatti dipinti da altri o sia stato anch'egli pittore di
vasi. Il Del Vita crede che quanto alle vernici Mastro Giorgio
si possa considerare semplicemente inventore di alcuni spe-
ciali colori a riflesso che sarebbero il maiolica d'oro e il rosso
maiolica cui s'aggiunse più tardi il colore argento. L'intelli-
genza con cui questi colori a riflesso sono usati come lumeg-
giature — per es., nel piatto del Museo di Arezzo.— dimo-
strerebbe inoltre per il-Del Vita che Mastro Giorgio doveva
di certo essere abilissimo disegnatore. Da questa induzione,
studiando lo stile delle rappresentazioni nei piatti della bot-
tega di Mastro Giorgio è facile giungere alla supposizione che
Mastro Giorgio sia stato anche pittore di maioliche, e il Del
Vita comincia col raccogliere intorno a una personalità che
potrebbe essere quella del maèstro alcuni piatti, due ad Arezzo
(Ercole e Dejanira, Scena Sacra)'■'e uno a Pesaro, con So»
Giuda Guerriero, proponendosi di tornare presto sull'interes-
sante quesito. "
Vili. - " Seicento „ e " Settecento.,,
73. Holmes (C. J.), An undescribed Panel by
Rembrandt (Buri. Mag., nov. 1917)-
La Galleria Nazionale di Londra ha acquistato recente-
mente un'altra tavoletta di Rembrandt II filoso/o; un grande
studio, di contrapposizione e di bianco e nero, altamente
magico. L'opera cade verso il 1632.
74. F.arly Works by Rembrandt (articolo editoria-
le), (Art in America, febbr. 1918).
. Due teste di carattere, nella, Collezione Matlhennis di
Philadelphia appartengono al primo periodo dell'artista
(1629-30?) ed è impressionante l'affinità tipica di uno dei
due studi con le teste di carattere di Adamo Elsheimer e
del suo Sosia Carlo Saraceni.
Lina terza opera già nella Collezione Chase di New York
rappresentante L'artista nel suo studio con un forte e bel
gioco di contrapposto, tra il rovescio del cavalletto e il chia-
rore lontano del muro, è tutravia, quanto all'attribuzione,
ancora sub judice.
75. MuSoz (A.), La scultura birocca a Roma: vedi
Le tombe' papali. (Rass. d'Arte, maggio 1918).
Interessante corsa a traverso le tombe papali che sebbene
non possano costituire un soggetto a sè per uno storico del-
l'arte sono però brani così importanti della produzione scultoria
che non è difficile si possano legare fra loro in catena formale.
I principi che il Mufioz adotta per spiegare le forme domi-