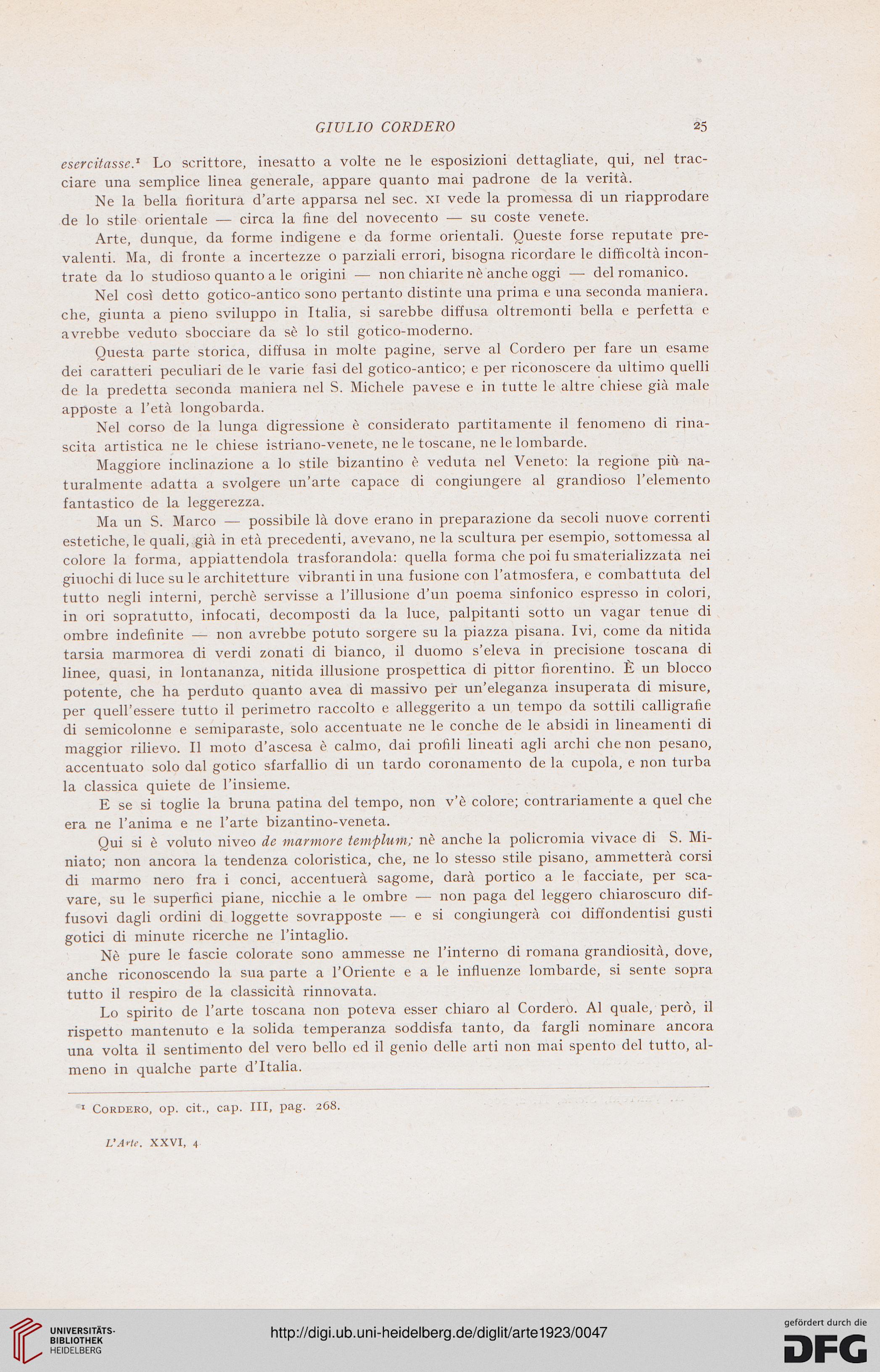GIULIO CORDERÒ
25
esercitasse.1 Lo scrittore, inesatto a volte ne le esposizioni dettagliate, qui, nel trac-
ciare una semplice linea generale, appare quanto mai padrone de la verità.
Ne la bella fioritura d'arte apparsa nel sec. xi vede la promessa di un riapprodare
de lo stile orientale — circa la fine del novecento — su coste venete.
Arte, dunque, da forme indigene e da forme orientali. Queste forse reputate pre-
valenti. Ma, di fronte a incertezze o parziali errori, bisogna ricordare le difficoltà incon-
trate da lo studioso quanto a le origini — non chiarite nè anche oggi — del romanico.
Nel così detto gotico-antico sono pertanto distinte una prima e una seconda maniera,
che, giunta a pieno sviluppo in Italia, si sarebbe diffusa oltremonti bella e perfetta e
avrebbe veduto sbocciare da sè lo stil gotico-moderno.
Questa parte storica, diffusa in molte pagine, serve al Corderò per fare un esame
dei caratteri peculiari de le varie fasi del gotico-antico; e per riconoscere da ultimo quelli
de la predetta seconda maniera nel S. Michele pavese e in tutte le altre chiese già male
apposte a l'età longobarda.
Nel corso de la lunga digressione è considerato partitamente il fenomeno di rina-
scita artistica ne le chiese istriano-venete, ne le toscane, ne le lombarde.
Maggiore inclinazione a lo stile bizantino è veduta nel Veneto: la regione più na-
turalmente adatta a svolgere un'arte capace di congiungere al grandioso l'elemento
fantastico de la leggerezza.
Ma un S. Marco — possibile là dove erano in preparazione da secoli nuove correnti
estetiche, le quali, già in età precedenti, avevano, ne la scultura per esempio, sottomessa al
colore la forma, appiattendola trasforandola: quella forma che poi fu smaterializzata nei
giuochi di luce su le architetture vibranti in una fusione con l'atmosfera, e combattuta del
tutto negli interni, perchè servisse a l'illusione d'un poema sinfonico espresso in colori,
in ori sopratutto, infocati, decomposti da la luce, palpitanti sotto un vagar tenue di
ombre indefinite — non avrebbe potuto sorgere su la piazza pisana. Ivi, come da nitida
tarsia marmorea di verdi zonati di bianco, il duomo s'eleva in precisione toscana di
linee, quasi, in lontananza, nitida illusione prospettica di pittor fiorentino. È un blocco
potente, che ha perduto quanto avea di massivo per un'eleganza insuperata di misure,
per quell'essere tutto il perimetro raccolto e alleggerito a un tempo da sottili calligrafie
di semicolonne e semiparaste, solo accentuate ne le conche de le absidi in lineamenti di
maggior rilievo. Il moto d'ascesa è calmo, dai profili lineati agli archi che non pesano,
accentuato solo dal gotico sfarfallio di un tardo coronamento de la cupola, e non turba
la classica quiete de l'insieme.
E se si toglie la bruna patina del tempo, non v'è colore; contrariamente a quel che
era ne l'anima e ne l'arte bizantino-veneta.
Qui si è voluto niveo de marmore templum; nè anche la policromia vivace di S. Mi-
niato; non ancora la tendenza coloristica, che, ne lo stesso stile pisano, ammetterà corsi
di marmo nero fra i conci, accentuerà sagome, darà portico a le facciate, per sca-
vare, su le superfici piane, nicchie a le ombre — non paga del leggero chiaroscuro dif-
fusovi dagli ordini di loggette sovrapposte — e si congiungerà coi diffondentisi gusti
gotici di minute ricerche ne l'intaglio.
Nè pure le fascie colorate sono ammesse ne l'interno di romana grandiosità, dove,
anche riconoscendo la sua parte a l'Oriente e a le influenze lombarde, si sente sopra
tutto il respiro de la classicità rinnovata.
Lo spirito de l'arte toscana non poteva esser chiaro al Corderò. Al quale, però, il
rispetto mantenuto e la solida temperanza soddisfa tanto, da fargli nominare ancora
una volta il sentimento del vero bello ed il genio delle arti non mai spento del tutto, al-
meno in qualche parte d'Italia.
1 Corderò, op. cit., cap. Ili, pag. 268.
L'Art,-. XXVI, 4
25
esercitasse.1 Lo scrittore, inesatto a volte ne le esposizioni dettagliate, qui, nel trac-
ciare una semplice linea generale, appare quanto mai padrone de la verità.
Ne la bella fioritura d'arte apparsa nel sec. xi vede la promessa di un riapprodare
de lo stile orientale — circa la fine del novecento — su coste venete.
Arte, dunque, da forme indigene e da forme orientali. Queste forse reputate pre-
valenti. Ma, di fronte a incertezze o parziali errori, bisogna ricordare le difficoltà incon-
trate da lo studioso quanto a le origini — non chiarite nè anche oggi — del romanico.
Nel così detto gotico-antico sono pertanto distinte una prima e una seconda maniera,
che, giunta a pieno sviluppo in Italia, si sarebbe diffusa oltremonti bella e perfetta e
avrebbe veduto sbocciare da sè lo stil gotico-moderno.
Questa parte storica, diffusa in molte pagine, serve al Corderò per fare un esame
dei caratteri peculiari de le varie fasi del gotico-antico; e per riconoscere da ultimo quelli
de la predetta seconda maniera nel S. Michele pavese e in tutte le altre chiese già male
apposte a l'età longobarda.
Nel corso de la lunga digressione è considerato partitamente il fenomeno di rina-
scita artistica ne le chiese istriano-venete, ne le toscane, ne le lombarde.
Maggiore inclinazione a lo stile bizantino è veduta nel Veneto: la regione più na-
turalmente adatta a svolgere un'arte capace di congiungere al grandioso l'elemento
fantastico de la leggerezza.
Ma un S. Marco — possibile là dove erano in preparazione da secoli nuove correnti
estetiche, le quali, già in età precedenti, avevano, ne la scultura per esempio, sottomessa al
colore la forma, appiattendola trasforandola: quella forma che poi fu smaterializzata nei
giuochi di luce su le architetture vibranti in una fusione con l'atmosfera, e combattuta del
tutto negli interni, perchè servisse a l'illusione d'un poema sinfonico espresso in colori,
in ori sopratutto, infocati, decomposti da la luce, palpitanti sotto un vagar tenue di
ombre indefinite — non avrebbe potuto sorgere su la piazza pisana. Ivi, come da nitida
tarsia marmorea di verdi zonati di bianco, il duomo s'eleva in precisione toscana di
linee, quasi, in lontananza, nitida illusione prospettica di pittor fiorentino. È un blocco
potente, che ha perduto quanto avea di massivo per un'eleganza insuperata di misure,
per quell'essere tutto il perimetro raccolto e alleggerito a un tempo da sottili calligrafie
di semicolonne e semiparaste, solo accentuate ne le conche de le absidi in lineamenti di
maggior rilievo. Il moto d'ascesa è calmo, dai profili lineati agli archi che non pesano,
accentuato solo dal gotico sfarfallio di un tardo coronamento de la cupola, e non turba
la classica quiete de l'insieme.
E se si toglie la bruna patina del tempo, non v'è colore; contrariamente a quel che
era ne l'anima e ne l'arte bizantino-veneta.
Qui si è voluto niveo de marmore templum; nè anche la policromia vivace di S. Mi-
niato; non ancora la tendenza coloristica, che, ne lo stesso stile pisano, ammetterà corsi
di marmo nero fra i conci, accentuerà sagome, darà portico a le facciate, per sca-
vare, su le superfici piane, nicchie a le ombre — non paga del leggero chiaroscuro dif-
fusovi dagli ordini di loggette sovrapposte — e si congiungerà coi diffondentisi gusti
gotici di minute ricerche ne l'intaglio.
Nè pure le fascie colorate sono ammesse ne l'interno di romana grandiosità, dove,
anche riconoscendo la sua parte a l'Oriente e a le influenze lombarde, si sente sopra
tutto il respiro de la classicità rinnovata.
Lo spirito de l'arte toscana non poteva esser chiaro al Corderò. Al quale, però, il
rispetto mantenuto e la solida temperanza soddisfa tanto, da fargli nominare ancora
una volta il sentimento del vero bello ed il genio delle arti non mai spento del tutto, al-
meno in qualche parte d'Italia.
1 Corderò, op. cit., cap. Ili, pag. 268.
L'Art,-. XXVI, 4