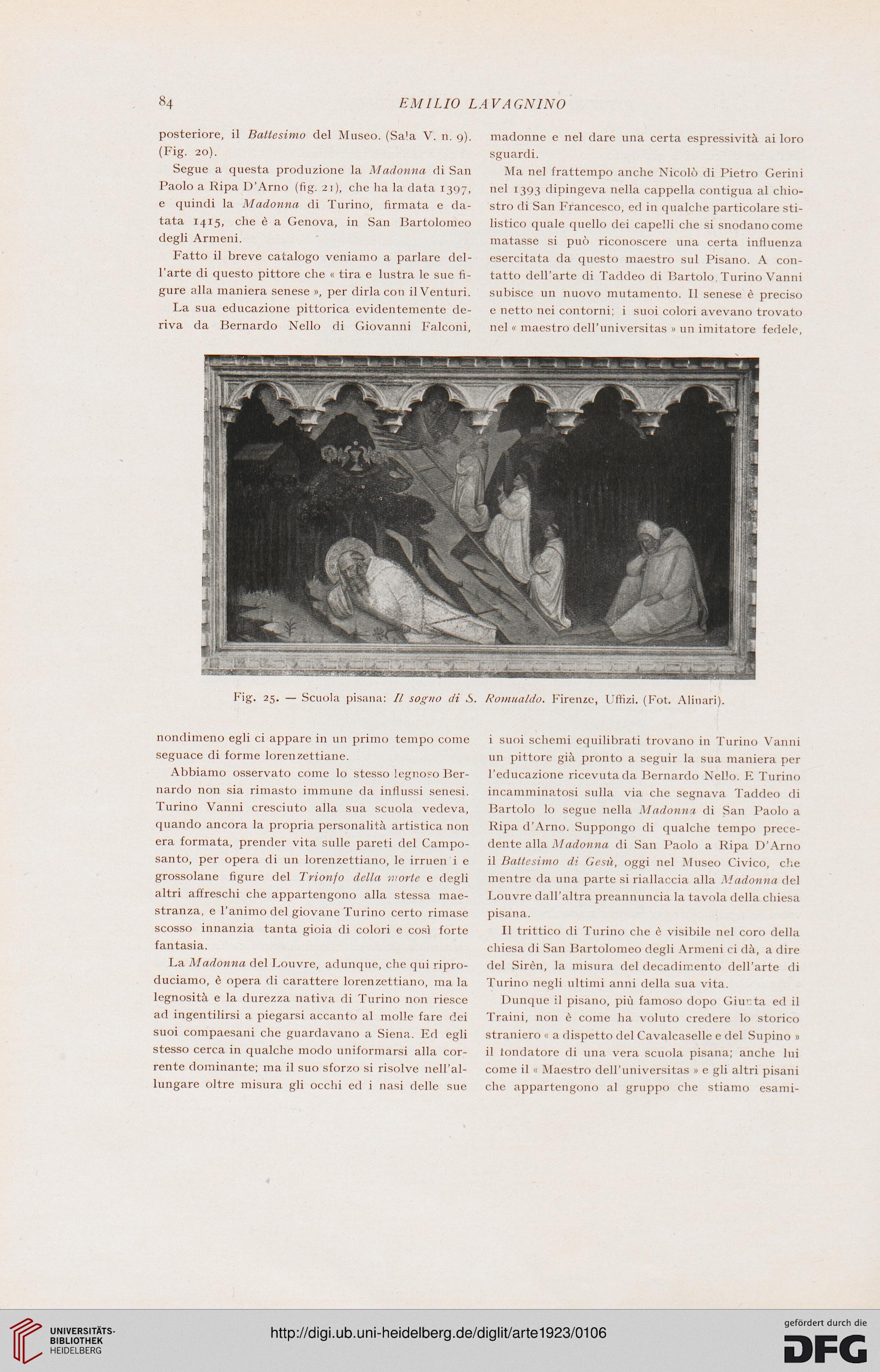»4
EMILIO LAVAGNINO
posteriore, il Battesimo del Museo. (Sa'a V. n. 9). madonne e nel dare una certa espressività ai loro
(Fig. 20). sguardi.
Segue a questa produzione la Madonna di San Ma nel frattempo anche Nicolò di Pietro Cerini
Paolo a Ripa D'Arno (fig. 21), che ha la data 1307, nel 1393 dipingeva nella cappella contigua al chio-
e quindi la Madonna di Turino, firmata e da- stro di San Francesco, ed in qualche particolare sti-
tata 1415, che è a Genova, in San Bartolomeo listico quale quello dei capelli che si snodanocome
degli Armeni. matasse si può riconoscere una certa influenza
Fatto il breve catalogo veniamo a parlare del- esercitata da questo maestro sul Pisano. A con-
l'arte di questo pittore che « tira e lustra le sue ri- tatto dell'arte di Taddeo di Bartolo Turino Vanni
gure alla maniera senese », per dirla con il Venturi. subisce un nuovo mutamento. Il senese è preciso
La sua educazione pittorica evidentemente de- e netto nei contorni; i suoi colori avevano trovato
riva da Bernardo Nello di Giovanni Falconi, nel « maestro dell'uni versi tas » un imitatore fedele,
Fig. 25. —Scuola pisana: // solito di S. Romualdo. Firenze, Uffizi, (Fot. AlinariJ
nondimeno egli ci appare in un primo tempo come
seguace di forme lorenzettianc.
Abbiamo osservato come lo stesso legnoso Ber-
nardo non sia rimasto immune da influssi senesi.
Turino Vanni cresciuto alla sua scuola vedeva,
quando ancora la propria personalità artistica non
era formata, prender vita sulle pareti del Campo-
santo, per opera di un lorenzettiano, le irruen i e
grossolane figure del Trionfo della morte e degli
altri affreschi che appartengono alla stessa mae-
stranza, e l'animo del giovane Turino certo rimase
scosso innanzia tanta gioia di colori e così forte
fantasia.
La Madonna del Louvre, adunque, che qui ripro-
duciamo, è opera di carattere lorenzettiano, mala
legnosità e la durezza nativa di Turino non riesce
ad ingentilirsi a piegarsi accanto al molle fare dei
suoi compaesani che guardavano a Siena. Ed egli
stesso cerca in qualche modo uniformarsi alla cor-
rente dominante; ma il suo sforzo si risolve nell'al-
lungare oltre misura gli occhi ed i nasi delle sue
i suoi schemi equilibrati trovano in Turino Vanni
un pittore già pronto a seguir la sua maniera per
l'educazione ricevuta da Bernardo Nello, E Turino
incamminatosi sulla via che segnava Taddeo di
Bartolo lo segue nella Madonna di San Paolo a
Ripa d'Arno. Suppongo di qualche tempo prece-
dente alla Madonna di San Paolo a Ripa D'Arno
il Battesimo di Gesù, oggi nel Museo Civico, che
mentre da una parte si riallaccia alla Madonna del
Louvre dall'altra preannuncia la tavola della chiesa
pisana.
Il trittico (li Turino che è visibile nel coro della
chiesa di San Bartolomeo degli Armeni ci dà, adire
del Sirèn, la misura del decadimento dell'arte di
Turino negli ultimi anni della sua vita.
Dunque il pisano, più famoso dopo Giui ta ed il
Traini, non è come ha voluto credere lo storico
straniero « a dispetto del Cavalcasene e del Supino »
il fondatore di una vera scuola pisana; anche lui
come il « Maestro dell'universitas » e gli altri pisani
che appartengono al gruppo che stiamo esami-
EMILIO LAVAGNINO
posteriore, il Battesimo del Museo. (Sa'a V. n. 9). madonne e nel dare una certa espressività ai loro
(Fig. 20). sguardi.
Segue a questa produzione la Madonna di San Ma nel frattempo anche Nicolò di Pietro Cerini
Paolo a Ripa D'Arno (fig. 21), che ha la data 1307, nel 1393 dipingeva nella cappella contigua al chio-
e quindi la Madonna di Turino, firmata e da- stro di San Francesco, ed in qualche particolare sti-
tata 1415, che è a Genova, in San Bartolomeo listico quale quello dei capelli che si snodanocome
degli Armeni. matasse si può riconoscere una certa influenza
Fatto il breve catalogo veniamo a parlare del- esercitata da questo maestro sul Pisano. A con-
l'arte di questo pittore che « tira e lustra le sue ri- tatto dell'arte di Taddeo di Bartolo Turino Vanni
gure alla maniera senese », per dirla con il Venturi. subisce un nuovo mutamento. Il senese è preciso
La sua educazione pittorica evidentemente de- e netto nei contorni; i suoi colori avevano trovato
riva da Bernardo Nello di Giovanni Falconi, nel « maestro dell'uni versi tas » un imitatore fedele,
Fig. 25. —Scuola pisana: // solito di S. Romualdo. Firenze, Uffizi, (Fot. AlinariJ
nondimeno egli ci appare in un primo tempo come
seguace di forme lorenzettianc.
Abbiamo osservato come lo stesso legnoso Ber-
nardo non sia rimasto immune da influssi senesi.
Turino Vanni cresciuto alla sua scuola vedeva,
quando ancora la propria personalità artistica non
era formata, prender vita sulle pareti del Campo-
santo, per opera di un lorenzettiano, le irruen i e
grossolane figure del Trionfo della morte e degli
altri affreschi che appartengono alla stessa mae-
stranza, e l'animo del giovane Turino certo rimase
scosso innanzia tanta gioia di colori e così forte
fantasia.
La Madonna del Louvre, adunque, che qui ripro-
duciamo, è opera di carattere lorenzettiano, mala
legnosità e la durezza nativa di Turino non riesce
ad ingentilirsi a piegarsi accanto al molle fare dei
suoi compaesani che guardavano a Siena. Ed egli
stesso cerca in qualche modo uniformarsi alla cor-
rente dominante; ma il suo sforzo si risolve nell'al-
lungare oltre misura gli occhi ed i nasi delle sue
i suoi schemi equilibrati trovano in Turino Vanni
un pittore già pronto a seguir la sua maniera per
l'educazione ricevuta da Bernardo Nello, E Turino
incamminatosi sulla via che segnava Taddeo di
Bartolo lo segue nella Madonna di San Paolo a
Ripa d'Arno. Suppongo di qualche tempo prece-
dente alla Madonna di San Paolo a Ripa D'Arno
il Battesimo di Gesù, oggi nel Museo Civico, che
mentre da una parte si riallaccia alla Madonna del
Louvre dall'altra preannuncia la tavola della chiesa
pisana.
Il trittico (li Turino che è visibile nel coro della
chiesa di San Bartolomeo degli Armeni ci dà, adire
del Sirèn, la misura del decadimento dell'arte di
Turino negli ultimi anni della sua vita.
Dunque il pisano, più famoso dopo Giui ta ed il
Traini, non è come ha voluto credere lo storico
straniero « a dispetto del Cavalcasene e del Supino »
il fondatore di una vera scuola pisana; anche lui
come il « Maestro dell'universitas » e gli altri pisani
che appartengono al gruppo che stiamo esami-