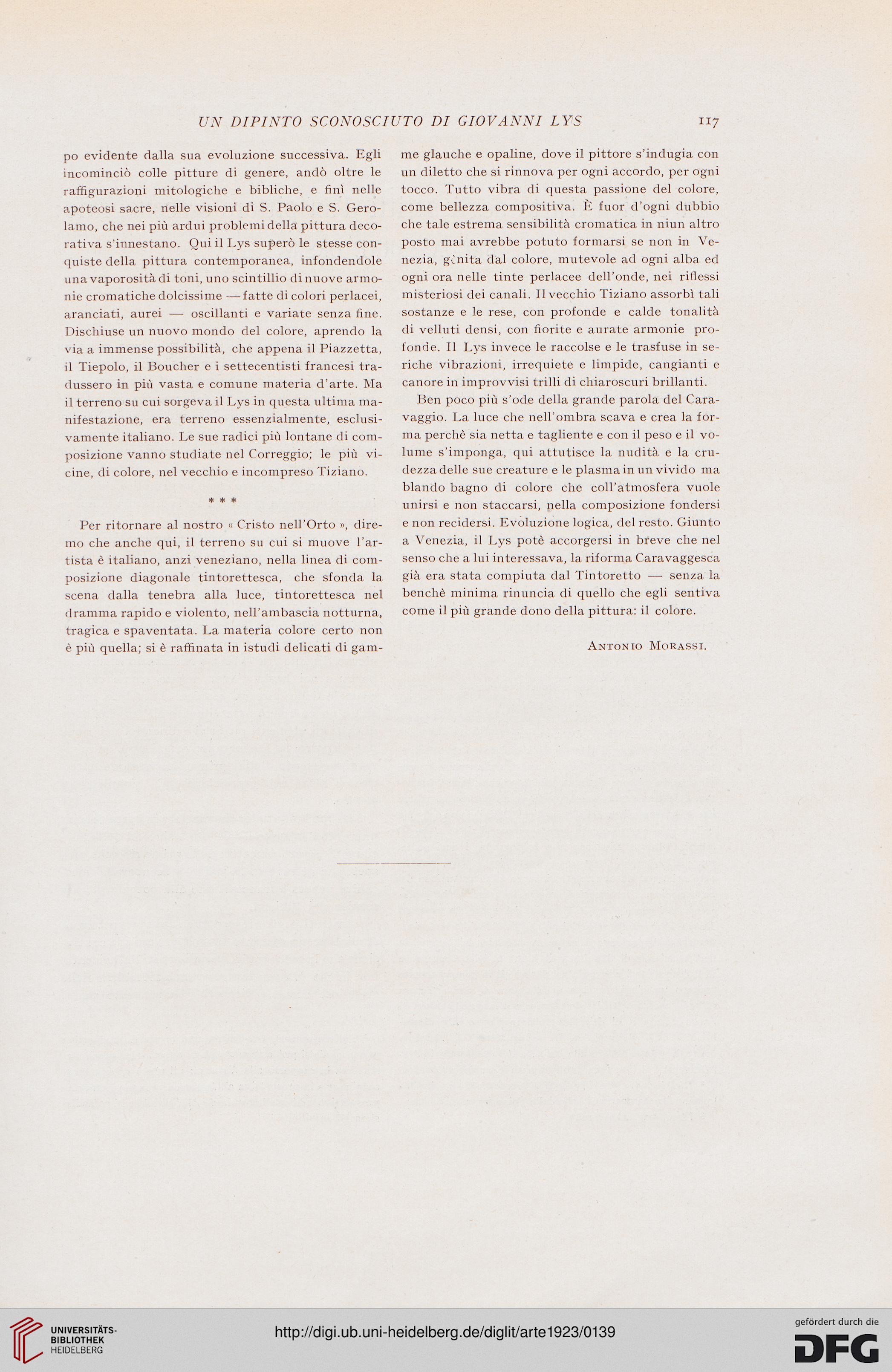UN DIPINTO SCONOSCIUTO DI GIOVANNI LYS
117
po evidente dalla sua evoluzione successiva. Egli
incominciò colle pitture di genere, andò oltre le
raffigurazioni mitologiche e bibliche, e finì nelle
apoteosi sacre, nelle visioni dì S. Paolo e S. Gero-
lamo, che nei più ardui problemi della pittura deco-
rativa s'innestano. Qui il Lys superò le stesse con-
quiste della pittura contemporanea, infondendole
una vaporosità di toni, uno scintillio di nuove armo-
nie cromatiche dolcissime — fatte di colori perlacei,
aranciati, aurei — oscillanti e variate senza fine.
Dischiuse un nuovo mondo del colore, aprendo la
via a immense possibilità, che appena il Piazzetta,
il Tiepolo, il Boucher e i settecentisti francesi tra-
dussero in più vasta e comune materia d'arte. Ma
il terreno su cui sorgeva il Lj's in questa ultima ma-
nifestazione, era terreno essenzialmente, esclusi-
vamente italiano. Le sue radici più lontane di com-
posizione vanno studiate nel Correggio; le più vi-
cine, di colore, nel vecchio e incompreso Tiziano.
* * *
Per ritornare al nostro « Cristo nell'Orto », dire-
mo che anche qui, il terreno su cui si muove l'ar-
tista è italiano, anzi veneziano, nella linea di com-
posizione diagonale tintorettesca, che sfonda la
scena dalla tenebra alla luce, tintorettesca nel
dramma rapido e violento, nell'ambascia notturna,
tragica e spaventata. La materia colore certo non
è più quella; si è raffinata in istudi delicati di gam-
me glauche e opaline, dove il pittore s'indugia con
un diletto che si rinnova per ogni accordo, per ogni
tocco. Tutto vibra di questa passione del colore,
come bellezza compositiva. È fuor d'ogni dubbio
che tale estrema sensibilità cromatica in niun altro
posto mai avrebbe potuto formarsi se non in Ve-
nezia, gCnita dal colore, mutevole ad ogni alba ed
ogni ora nelle tinte perlacee dell'onde, nei ritiessi
misteriosi dei canali. Il vecchio Tiziano assorbì tali
sostanze e le rese, con profonde e calde tonalità
di velluti densi, con fiorite e aurate armonie pro-
fonde. Il Lys invece le raccolse e le trasfuse in se-
riche vibrazioni, irrequiete e limpide, cangianti e
canore in improvvisi trilli di chiaroscuri brillanti.
Ben poco più s'ode della grande parola del Cara-
vaggio. La luce che nell'ombra scava e crea la for-
ma perchè sia netta e tagliente e con il peso e il vo-
lume s'imponga, qui attutisce la nudità e la cru-
dezza delle sue creature e le plasma in un vivido ma
blando bagno di colore che coll'atmosfera vuole
unirsi e non staccarsi, nella composizione fondersi
e non recidersi. Evoluzione logica, del resto. Giunto
a Venezia, il Lys potè accorgersi in breve che nel
senso che a lui interessava, la riforma Caravaggesca
già era stata compiuta dal Tintoretto — senza la
benché minima rinuncia di quello che egli sentiva
come il più grande dono della pittura: il colore.
Antonio Morassi.
117
po evidente dalla sua evoluzione successiva. Egli
incominciò colle pitture di genere, andò oltre le
raffigurazioni mitologiche e bibliche, e finì nelle
apoteosi sacre, nelle visioni dì S. Paolo e S. Gero-
lamo, che nei più ardui problemi della pittura deco-
rativa s'innestano. Qui il Lys superò le stesse con-
quiste della pittura contemporanea, infondendole
una vaporosità di toni, uno scintillio di nuove armo-
nie cromatiche dolcissime — fatte di colori perlacei,
aranciati, aurei — oscillanti e variate senza fine.
Dischiuse un nuovo mondo del colore, aprendo la
via a immense possibilità, che appena il Piazzetta,
il Tiepolo, il Boucher e i settecentisti francesi tra-
dussero in più vasta e comune materia d'arte. Ma
il terreno su cui sorgeva il Lj's in questa ultima ma-
nifestazione, era terreno essenzialmente, esclusi-
vamente italiano. Le sue radici più lontane di com-
posizione vanno studiate nel Correggio; le più vi-
cine, di colore, nel vecchio e incompreso Tiziano.
* * *
Per ritornare al nostro « Cristo nell'Orto », dire-
mo che anche qui, il terreno su cui si muove l'ar-
tista è italiano, anzi veneziano, nella linea di com-
posizione diagonale tintorettesca, che sfonda la
scena dalla tenebra alla luce, tintorettesca nel
dramma rapido e violento, nell'ambascia notturna,
tragica e spaventata. La materia colore certo non
è più quella; si è raffinata in istudi delicati di gam-
me glauche e opaline, dove il pittore s'indugia con
un diletto che si rinnova per ogni accordo, per ogni
tocco. Tutto vibra di questa passione del colore,
come bellezza compositiva. È fuor d'ogni dubbio
che tale estrema sensibilità cromatica in niun altro
posto mai avrebbe potuto formarsi se non in Ve-
nezia, gCnita dal colore, mutevole ad ogni alba ed
ogni ora nelle tinte perlacee dell'onde, nei ritiessi
misteriosi dei canali. Il vecchio Tiziano assorbì tali
sostanze e le rese, con profonde e calde tonalità
di velluti densi, con fiorite e aurate armonie pro-
fonde. Il Lys invece le raccolse e le trasfuse in se-
riche vibrazioni, irrequiete e limpide, cangianti e
canore in improvvisi trilli di chiaroscuri brillanti.
Ben poco più s'ode della grande parola del Cara-
vaggio. La luce che nell'ombra scava e crea la for-
ma perchè sia netta e tagliente e con il peso e il vo-
lume s'imponga, qui attutisce la nudità e la cru-
dezza delle sue creature e le plasma in un vivido ma
blando bagno di colore che coll'atmosfera vuole
unirsi e non staccarsi, nella composizione fondersi
e non recidersi. Evoluzione logica, del resto. Giunto
a Venezia, il Lys potè accorgersi in breve che nel
senso che a lui interessava, la riforma Caravaggesca
già era stata compiuta dal Tintoretto — senza la
benché minima rinuncia di quello che egli sentiva
come il più grande dono della pittura: il colore.
Antonio Morassi.