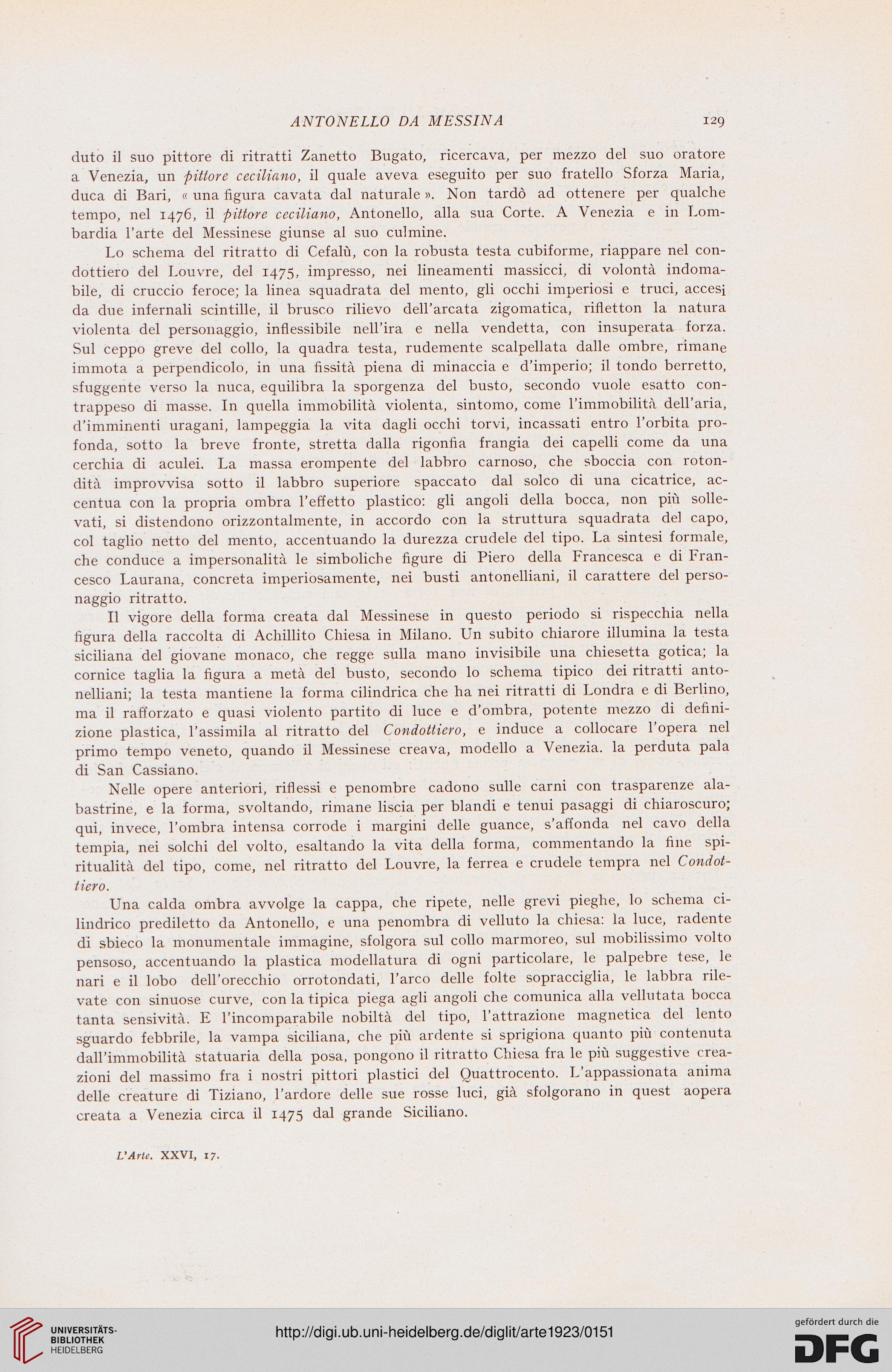ANTONELLO DA MESSINA
129
duto il suo pittore di ritratti Zanetto Bugato, ricercava, per mezzo del suo oratore
a Venezia, un pittore ceciliano, il quale aveva eseguito per suo fratello Sforza Maria,
duca di Bari, « una figura cavata dal naturale ». Non tardò ad ottenere per qualche
tempo, nel 1476, il pittore ceciliano, Antonello, alla sua Corte. A Venezia e in Lom-
bardia l'arte del Messinese giunse al suo culmine.
Lo schema del ritratto di Cefalù, con la robusta testa cubiforme, riappare nel con-
dottiero del Louvre, del 1475, impresso, nei lineamenti massicci, di volontà indoma-
bile, di cruccio feroce; la linea squadrata del mento, gli occhi imperiosi e truci, accesi
da due infernali scintille, il brusco rilievo dell'arcata zigomatica, rifletton la natura
violenta del personaggio, inflessibile nell'ira e nella vendetta, con insuperata forza.
Sul ceppo greve del collo, la quadra testa, rudemente scalpellata dalle ombre, rimane
immota a perpendicolo, in una fissità piena di minaccia e d'imperio; il tondo berretto,
sfuggente verso la nuca, equilibra la sporgenza del busto, secondo vuole esatto con-
trappeso di masse. In quella immobilità violenta, sintomo, come l'immobilità dell'aria,
d'imminenti uragani, lampeggia la vita dagli occhi torvi, incassati entro l'orbita pro-
fonda, sotto la breve fronte, stretta dalla rigonfia frangia dei capelli come da una
cerchia di aculei. La massa erompente del labbro carnoso, che sboccia con roton-
dità improvvisa sotto il labbro superiore spaccato dal solco di una cicatrice, ac-
centua con la propria ombra l'effetto plastico: gli angoli della bocca, non più solle-
vati, si distendono orizzontalmente, in accordo con la struttura squadrata del capo,
col taglio netto del mento, accentuando la durezza crudele del tipo. La sintesi formale,
che conduce a impersonalità le simboliche figure di Piero della Francesca e di Fran-
cesco Laurana, concreta imperiosamente, nei busti antonelliani, il carattere del perso-
naggio ritratto.
Il vigore della forma creata dal Messinese in questo periodo si rispecchia nella
figura della raccolta di Achillito Chiesa in Milano. Un subito chiarore illumina la testa
siciliana del giovane monaco, che regge sulla mano invisibile una chiesetta gotica; la
cornice taglia la figura a metà del busto, secondo lo schema tipico dei ritratti anto-
nelliani; la testa mantiene la forma cilindrica che ha nei ritratti di Londra e di Berlino,
ma il rafforzato e quasi violento partito di luce e d'ombra, potente mezzo di defini-
zione plastica, l'assimila al ritratto del Condottiero, e induce a collocare l'opera nel
primo tempo veneto, quando il Messinese creava, modello a Venezia, la perduta pala
di San Cassiano.
Nelle opere anteriori, riflessi e penombre cadono sulle carni con trasparenze ala-
bastrine, e la forma, svoltando, rimane liscia per blandi e tenui pasaggi di chiaroscuro;
qui, invece, l'ombra intensa corrode i margini delle guance, s'affonda nel cavo della
tempia, nei solchi del volto, esaltando la vita della forma, commentando la fine spi-
ritualità del tipo, come, nel ritratto del Louvre, la ferrea e crudele tempra nel Condot-
tiero.
Una calda ombra avvolge la cappa, che ripete, nelle grevi pieghe, lo schema ci-
lindrico prediletto da Antonello, e una penombra di velluto la chiesa: la luce, radente
di sbieco la monumentale immagine, sfolgora sul collo marmoreo, sul mobilissimo volto
pensoso, accentuando la plastica modellatura di ogni particolare, le palpebre tese, le
nari e il lobo dell'orecchio orrotondati, l'arco delle folte sopracciglia, le labbra rile-
vate con sinuose curve, con la tipica piega agli angoli che comunica alla vellutata bocca
tanta sensività. E l'incomparabile nobiltà del tipo, l'attrazione magnetica del lento
sguardo febbrile, la vampa siciliana, che più ardente si sprigiona quanto più contenuta
dall'immobilità statuaria della posa, pongono il ritratto Chiesa fra le più suggestive crea-
zioni del massimo fra i nostri pittori plastici del Quattrocento. L'appassionata anima
delle creature di Tiziano, l'ardore delle sue rosse luci, già sfolgorano in quest aopera
creata a Venezia circa il 1475 dal grande Siciliano.
L'Arte. XXVI, 17.
129
duto il suo pittore di ritratti Zanetto Bugato, ricercava, per mezzo del suo oratore
a Venezia, un pittore ceciliano, il quale aveva eseguito per suo fratello Sforza Maria,
duca di Bari, « una figura cavata dal naturale ». Non tardò ad ottenere per qualche
tempo, nel 1476, il pittore ceciliano, Antonello, alla sua Corte. A Venezia e in Lom-
bardia l'arte del Messinese giunse al suo culmine.
Lo schema del ritratto di Cefalù, con la robusta testa cubiforme, riappare nel con-
dottiero del Louvre, del 1475, impresso, nei lineamenti massicci, di volontà indoma-
bile, di cruccio feroce; la linea squadrata del mento, gli occhi imperiosi e truci, accesi
da due infernali scintille, il brusco rilievo dell'arcata zigomatica, rifletton la natura
violenta del personaggio, inflessibile nell'ira e nella vendetta, con insuperata forza.
Sul ceppo greve del collo, la quadra testa, rudemente scalpellata dalle ombre, rimane
immota a perpendicolo, in una fissità piena di minaccia e d'imperio; il tondo berretto,
sfuggente verso la nuca, equilibra la sporgenza del busto, secondo vuole esatto con-
trappeso di masse. In quella immobilità violenta, sintomo, come l'immobilità dell'aria,
d'imminenti uragani, lampeggia la vita dagli occhi torvi, incassati entro l'orbita pro-
fonda, sotto la breve fronte, stretta dalla rigonfia frangia dei capelli come da una
cerchia di aculei. La massa erompente del labbro carnoso, che sboccia con roton-
dità improvvisa sotto il labbro superiore spaccato dal solco di una cicatrice, ac-
centua con la propria ombra l'effetto plastico: gli angoli della bocca, non più solle-
vati, si distendono orizzontalmente, in accordo con la struttura squadrata del capo,
col taglio netto del mento, accentuando la durezza crudele del tipo. La sintesi formale,
che conduce a impersonalità le simboliche figure di Piero della Francesca e di Fran-
cesco Laurana, concreta imperiosamente, nei busti antonelliani, il carattere del perso-
naggio ritratto.
Il vigore della forma creata dal Messinese in questo periodo si rispecchia nella
figura della raccolta di Achillito Chiesa in Milano. Un subito chiarore illumina la testa
siciliana del giovane monaco, che regge sulla mano invisibile una chiesetta gotica; la
cornice taglia la figura a metà del busto, secondo lo schema tipico dei ritratti anto-
nelliani; la testa mantiene la forma cilindrica che ha nei ritratti di Londra e di Berlino,
ma il rafforzato e quasi violento partito di luce e d'ombra, potente mezzo di defini-
zione plastica, l'assimila al ritratto del Condottiero, e induce a collocare l'opera nel
primo tempo veneto, quando il Messinese creava, modello a Venezia, la perduta pala
di San Cassiano.
Nelle opere anteriori, riflessi e penombre cadono sulle carni con trasparenze ala-
bastrine, e la forma, svoltando, rimane liscia per blandi e tenui pasaggi di chiaroscuro;
qui, invece, l'ombra intensa corrode i margini delle guance, s'affonda nel cavo della
tempia, nei solchi del volto, esaltando la vita della forma, commentando la fine spi-
ritualità del tipo, come, nel ritratto del Louvre, la ferrea e crudele tempra nel Condot-
tiero.
Una calda ombra avvolge la cappa, che ripete, nelle grevi pieghe, lo schema ci-
lindrico prediletto da Antonello, e una penombra di velluto la chiesa: la luce, radente
di sbieco la monumentale immagine, sfolgora sul collo marmoreo, sul mobilissimo volto
pensoso, accentuando la plastica modellatura di ogni particolare, le palpebre tese, le
nari e il lobo dell'orecchio orrotondati, l'arco delle folte sopracciglia, le labbra rile-
vate con sinuose curve, con la tipica piega agli angoli che comunica alla vellutata bocca
tanta sensività. E l'incomparabile nobiltà del tipo, l'attrazione magnetica del lento
sguardo febbrile, la vampa siciliana, che più ardente si sprigiona quanto più contenuta
dall'immobilità statuaria della posa, pongono il ritratto Chiesa fra le più suggestive crea-
zioni del massimo fra i nostri pittori plastici del Quattrocento. L'appassionata anima
delle creature di Tiziano, l'ardore delle sue rosse luci, già sfolgorano in quest aopera
creata a Venezia circa il 1475 dal grande Siciliano.
L'Arte. XXVI, 17.