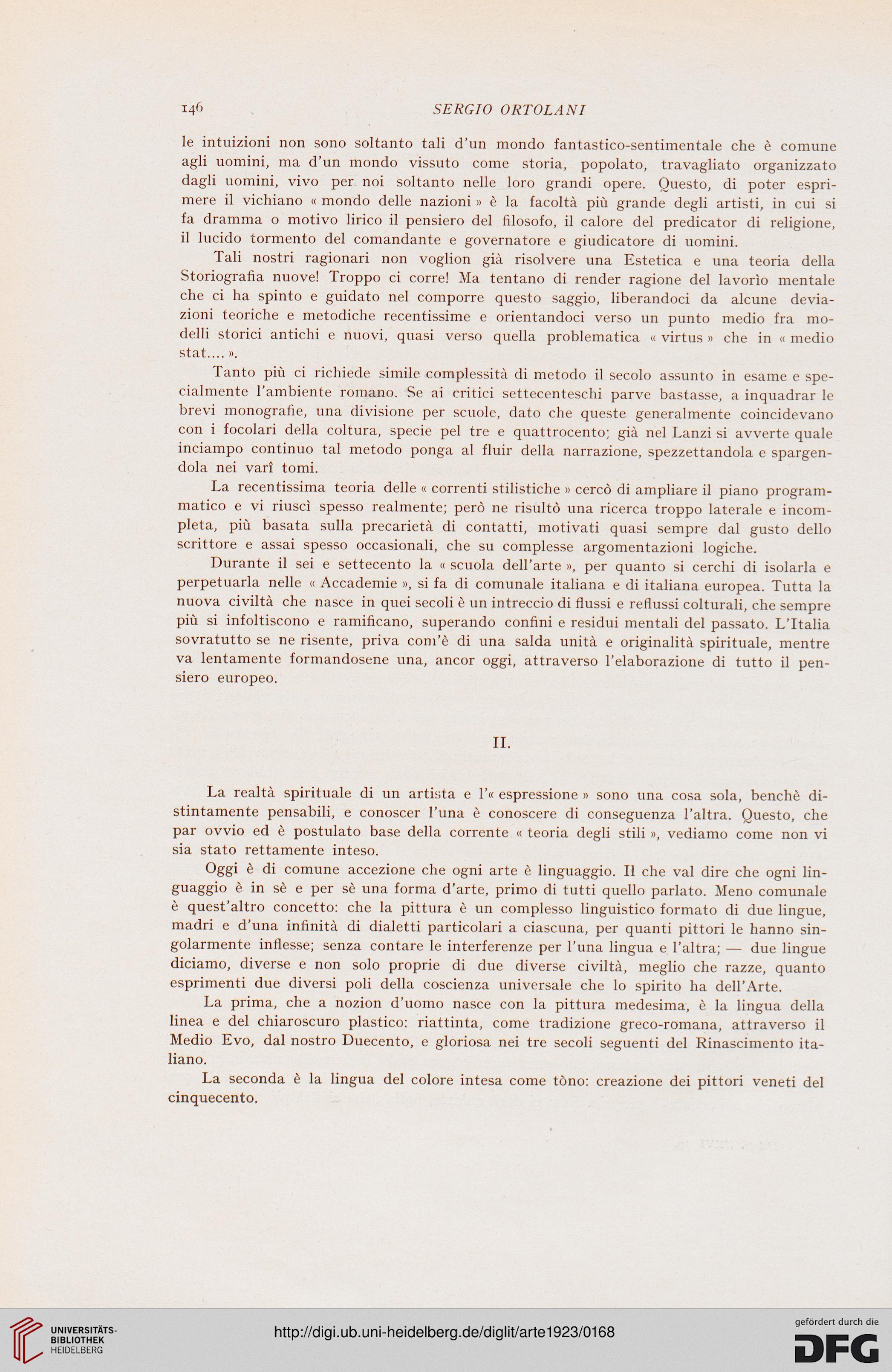SERGIO ORTOLANI
le intuizioni non sono soltanto tali d'un mondo fantastico-sentimentale che è comune
agli uomini, ma d'un mondo vissuto come storia, popolato, travagliato organizzato
dagli uomini, vivo per noi soltanto nelle loro grandi opere. Questo, di poter espri-
mere il vichiano « mondo delle nazioni » è la facoltà più grande degli artisti, in cui si
fa dramma o motivo lirico il pensiero del filosofo, il calore del predicator di religione,
il lucido tormento del comandante e governatore e giudicatore di uomini.
Tali nostri ragionari non voglion già risolvere una Estetica e una teoria della
Storiografia nuove! Troppo ci corre! Ma tentano di render ragione del lavorìo mentale
che ci ha spinto e guidato nel comporre questo saggio, liberandoci da alcune devia-
zioni teoriche e metodiche recentissime e orientandoci verso un punto medio fra mo-
delli storici antichi e nuovi, quasi verso quella problematica «< virtus » che in « medio
stat.... ».
Tanto più ci richiede simile complessità di metodo il secolo assunto in esame e spe-
cialmente l'ambiente romano. Se ai critici settecenteschi parve bastasse, a inquadrar le
brevi monografie, una divisione per scuole, dato che queste generalmente coincidevano
con i focolari della coltura, specie pel tre e quattrocento; già nel Lanzi si avverte quale
inciampo continuo tal metodo ponga al fluir della narrazione, spezzettandola e spargen-
dola nei vari tomi.
La recentissima teoria delle « correnti stilistiche » cercò di ampliare il piano program-
matico e vi riuscì spesso realmente; però ne risultò una ricerca troppo laterale e incom-
pleta, più basata sulla precarietà di contatti, motivati quasi sempre dal gusto dello
scrittore e assai spesso occasionali, che su complesse argomentazioni logiche.
Durante il sei e settecento la « scuola dell'arte », per quanto si cerchi di isolarla e
perpetuarla nelle « Accademie », si fa di comunale italiana e di italiana europea. Tutta la
nuova civiltà che nasce in quei secoli è un intreccio di flussi e reflussi colturali, che sempre
più si infoltiscono e ramificano, superando confini e residui mentali del passato. L'Italia
sovratutto se ne risente, priva com'è di una salda unità e originalità spirituale, mentre
va lentamente formandosene una, ancor oggi, attraverso l'elaborazione di tutto il pen-
siero europeo.
IL
La realtà spirituale di un artista e l'« espressione » sono una cosa sola, benché di-
stintamente pensabili, e conoscer l'una è conoscere di conseguenza l'altra. Questo, che
par ovvio ed è postulato base della corrente « teoria degli stili », vediamo come non vi
sia stato rettamente inteso.
Oggi è di comune accezione che ogni arte è linguaggio. Il che vai dire che ogni lin-
guaggio è in sè e per sè una forma d'arte, primo di tutti quello parlato. Meno comunale
è quest'altro concetto: che la pittura è un complesso linguistico formato di due lingue,
madri e d'una infinità di dialetti particolari a ciascuna, per quanti pittori le hanno sin-
golarmente inflesse; senza contare le interferenze per l'una lingua e l'altra; — due lingue
diciamo, diverse e non solo proprie di due diverse civiltà, meglio che razze, quanto
esprimenti due diversi poli della coscienza universale che lo spirito ha dell'Arte.
La prima, che a nozion d'uomo nasce con la pittura medesima, è la lingua della
linea e del chiaroscuro plastico: riattinta, come tradizione greco-romana, attraverso il
Medio Evo, dal nostro Duecento, e gloriosa nei tre secoli seguenti del Rinascimento ita-
liano.
La seconda è la lingua del colore intesa come tòno: creazione dei pittori veneti del
cinquecento.
le intuizioni non sono soltanto tali d'un mondo fantastico-sentimentale che è comune
agli uomini, ma d'un mondo vissuto come storia, popolato, travagliato organizzato
dagli uomini, vivo per noi soltanto nelle loro grandi opere. Questo, di poter espri-
mere il vichiano « mondo delle nazioni » è la facoltà più grande degli artisti, in cui si
fa dramma o motivo lirico il pensiero del filosofo, il calore del predicator di religione,
il lucido tormento del comandante e governatore e giudicatore di uomini.
Tali nostri ragionari non voglion già risolvere una Estetica e una teoria della
Storiografia nuove! Troppo ci corre! Ma tentano di render ragione del lavorìo mentale
che ci ha spinto e guidato nel comporre questo saggio, liberandoci da alcune devia-
zioni teoriche e metodiche recentissime e orientandoci verso un punto medio fra mo-
delli storici antichi e nuovi, quasi verso quella problematica «< virtus » che in « medio
stat.... ».
Tanto più ci richiede simile complessità di metodo il secolo assunto in esame e spe-
cialmente l'ambiente romano. Se ai critici settecenteschi parve bastasse, a inquadrar le
brevi monografie, una divisione per scuole, dato che queste generalmente coincidevano
con i focolari della coltura, specie pel tre e quattrocento; già nel Lanzi si avverte quale
inciampo continuo tal metodo ponga al fluir della narrazione, spezzettandola e spargen-
dola nei vari tomi.
La recentissima teoria delle « correnti stilistiche » cercò di ampliare il piano program-
matico e vi riuscì spesso realmente; però ne risultò una ricerca troppo laterale e incom-
pleta, più basata sulla precarietà di contatti, motivati quasi sempre dal gusto dello
scrittore e assai spesso occasionali, che su complesse argomentazioni logiche.
Durante il sei e settecento la « scuola dell'arte », per quanto si cerchi di isolarla e
perpetuarla nelle « Accademie », si fa di comunale italiana e di italiana europea. Tutta la
nuova civiltà che nasce in quei secoli è un intreccio di flussi e reflussi colturali, che sempre
più si infoltiscono e ramificano, superando confini e residui mentali del passato. L'Italia
sovratutto se ne risente, priva com'è di una salda unità e originalità spirituale, mentre
va lentamente formandosene una, ancor oggi, attraverso l'elaborazione di tutto il pen-
siero europeo.
IL
La realtà spirituale di un artista e l'« espressione » sono una cosa sola, benché di-
stintamente pensabili, e conoscer l'una è conoscere di conseguenza l'altra. Questo, che
par ovvio ed è postulato base della corrente « teoria degli stili », vediamo come non vi
sia stato rettamente inteso.
Oggi è di comune accezione che ogni arte è linguaggio. Il che vai dire che ogni lin-
guaggio è in sè e per sè una forma d'arte, primo di tutti quello parlato. Meno comunale
è quest'altro concetto: che la pittura è un complesso linguistico formato di due lingue,
madri e d'una infinità di dialetti particolari a ciascuna, per quanti pittori le hanno sin-
golarmente inflesse; senza contare le interferenze per l'una lingua e l'altra; — due lingue
diciamo, diverse e non solo proprie di due diverse civiltà, meglio che razze, quanto
esprimenti due diversi poli della coscienza universale che lo spirito ha dell'Arte.
La prima, che a nozion d'uomo nasce con la pittura medesima, è la lingua della
linea e del chiaroscuro plastico: riattinta, come tradizione greco-romana, attraverso il
Medio Evo, dal nostro Duecento, e gloriosa nei tre secoli seguenti del Rinascimento ita-
liano.
La seconda è la lingua del colore intesa come tòno: creazione dei pittori veneti del
cinquecento.