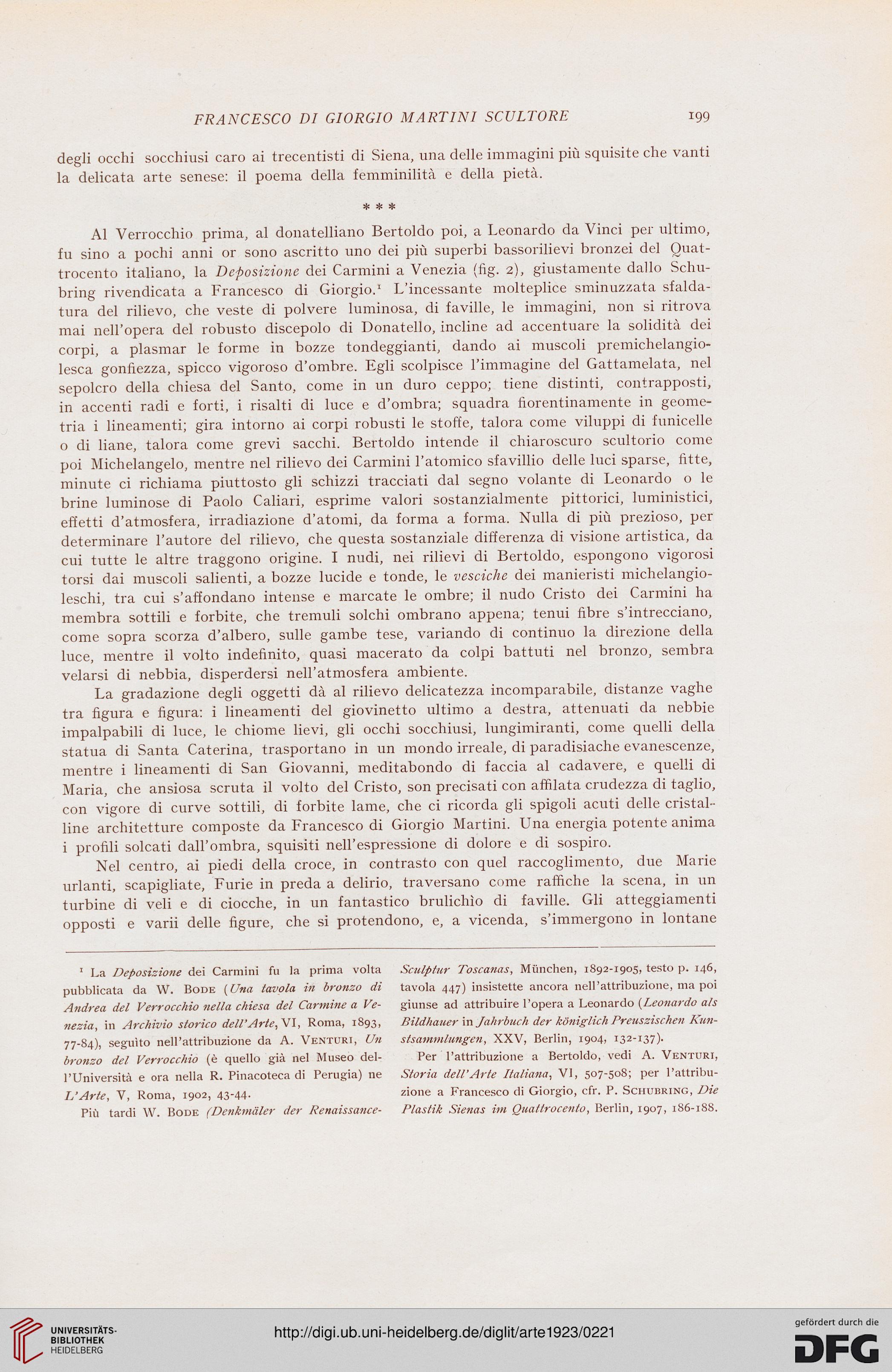FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI SCULTORE
199
degli occhi socchiusi caro ai trecentisti di Siena, una delle immagini più squisite che vanti
la delicata arte senese: il poema della femminilità e della pietà.
* * *
Al Verrocchio prima, al donatelliano Bertoldo poi, a Leonardo da Vinci per ultimo,
fu sino a pochi anni or sono ascritto uno dei più superbi bassorilievi bronzei del Quat-
trocento italiano, la Deposizione dei Carmini a Venezia (fig. 2), giustamente dallo Schu-
bring rivendicata a Francesco di Giorgio.1 L'incessante molteplice sminuzzata sfalda-
tura del rilievo, che veste di polvere luminosa, di faville, le immagini, non si ritrova
mai nell'opera del robusto discepolo di Donatello, incline ad accentuare la solidità dei
corpi, a plasmar le forme in bozze tondeggianti, dando ai muscoli premichelangio-
lesca gonfiezza, spicco vigoroso d'ombre. Egli scolpisce l'immagine del Gattamelata, nel
sepolcro della chiesa del Santo, come in un duro ceppo; tiene distinti, contrapposti,
in accenti radi e forti, i risalti di luce e d'ombra; squadra fiorentinamente in geome-
tria i lineamenti; gira intorno ai corpi robusti le stoffe, talora come viluppi di funicelle
0 di liane, talora come grevi sacchi. Bertoldo intende il chiaroscuro scultorio come
poi Michelangelo, mentre nel rilievo dei Carmini l'atomico sfavillio delle luci sparse, fitte,
minute ci richiama piuttosto gli schizzi tracciati dal segno volante di Leonardo o le
brine luminose di Paolo Caliari, esprime valori sostanzialmente pittorici, luministici,
effetti d'atmosfera, irradiazione d'atomi, da forma a forma. Nulla di più prezioso, per
determinare l'autore del rilievo, che questa sostanziale differenza di visione artistica, da
cui tutte le altre traggono origine. I nudi, nei rilievi di Bertoldo, espongono vigorosi
torsi dai muscoli salienti, a bozze lucide e tonde, le vesciche dei manieristi michelangio-
leschi, tra cui s'affondano intense e marcate le ombre; il nudo Cristo dei Carmini ha
membra sottili e forbite, che tremuli solchi ombrano appena; tenui fibre s'intrecciano,
come sopra scorza d'albero, sulle gambe tese, variando di continuo la direzione della
luce, mentre il volto indefinito, quasi macerato da colpi battuti nel bronzo, sembra
velarsi di nebbia, disperdersi nell'atmosfera ambiente.
La gradazione degli oggetti dà al rilievo delicatezza incomparabile, distanze vaghe
tra figura e figura: i lineamenti del giovinetto ultimo a destra, attenuati da nebbie
impalpabili di luce, le chiome lievi, gli occhi socchiusi, lungimiranti, come quelli della
statua di Santa Caterina, trasportano in un mondo irreale, di paradisiache evanescenze,
mentre i lineamenti di San Giovanni, meditabondo di faccia al cadavere, e quelli di
Maria, che ansiosa scruta il volto del Cristo, son precisati con affilata crudezza di taglio,
con vigore di curve sottili, di forbite lame, che ci ricorda gli spigoli acuti delle cristal-
line architetture composte da Francesco di Giorgio Martini. Una energia potente anima
1 profili solcati dall'ombra, squisiti nell'espressione di dolore e di sospiro.
Nel centro, ai piedi della croce, in contrasto con quel raccoglimento, due Marie
urlanti, scapigliate, Furie in preda a delirio, traversano come raffiche la scena, in un
turbine di veli e di ciocche, in un fantastico brulichìo di faville. Gli atteggiamenti
opposti e varii delle figure, che si protendono, e, a vicenda, s'immergono in lontane
1 La Deposizione dei Carmini fu la prima volta
pubblicata da W. Bode (Una tavola in bronzo di
Andrea del Verrocchio nella chiesa del Carmine a Ve-
nezia, in Archivio storico dell'Arte,XI, Roma, 1893,
77-84), seguito nell'attribuzione da A. Venturi, Un
bronzo del Verrocchio (è quello già nel Museo del-
l'Università e ora nella R. Pinacoteca di Perugia) ne
L'Arte, V, Roma, 1902, 43-44.
Più tardi W. Bode (Denkmàler der Renaissance-
Sculptur Toscanas, Miinchen, 1892-1905, testo p. 146,
tavola 447) insistette ancora nell'attribuzione, ma poi
giunse ad attribuire l'opera a Leonardo (Leonardo als
lìildhauer in Jahrbuch der kóniglich Preuszischen Kun-
stsammlungen, XXV, Berlin, 1904, 132-137).
Per l'attribuzione a Bertoldo, vedi A. Venturi,
Storia dell'Arte Italiana, VI, 507-508; per l'attribu-
zione a Francesco di Giorgio, cfr. P. Schubring, Die
Plastik Sienas im Quattrocento, Berlin, 1907, 186-188.
199
degli occhi socchiusi caro ai trecentisti di Siena, una delle immagini più squisite che vanti
la delicata arte senese: il poema della femminilità e della pietà.
* * *
Al Verrocchio prima, al donatelliano Bertoldo poi, a Leonardo da Vinci per ultimo,
fu sino a pochi anni or sono ascritto uno dei più superbi bassorilievi bronzei del Quat-
trocento italiano, la Deposizione dei Carmini a Venezia (fig. 2), giustamente dallo Schu-
bring rivendicata a Francesco di Giorgio.1 L'incessante molteplice sminuzzata sfalda-
tura del rilievo, che veste di polvere luminosa, di faville, le immagini, non si ritrova
mai nell'opera del robusto discepolo di Donatello, incline ad accentuare la solidità dei
corpi, a plasmar le forme in bozze tondeggianti, dando ai muscoli premichelangio-
lesca gonfiezza, spicco vigoroso d'ombre. Egli scolpisce l'immagine del Gattamelata, nel
sepolcro della chiesa del Santo, come in un duro ceppo; tiene distinti, contrapposti,
in accenti radi e forti, i risalti di luce e d'ombra; squadra fiorentinamente in geome-
tria i lineamenti; gira intorno ai corpi robusti le stoffe, talora come viluppi di funicelle
0 di liane, talora come grevi sacchi. Bertoldo intende il chiaroscuro scultorio come
poi Michelangelo, mentre nel rilievo dei Carmini l'atomico sfavillio delle luci sparse, fitte,
minute ci richiama piuttosto gli schizzi tracciati dal segno volante di Leonardo o le
brine luminose di Paolo Caliari, esprime valori sostanzialmente pittorici, luministici,
effetti d'atmosfera, irradiazione d'atomi, da forma a forma. Nulla di più prezioso, per
determinare l'autore del rilievo, che questa sostanziale differenza di visione artistica, da
cui tutte le altre traggono origine. I nudi, nei rilievi di Bertoldo, espongono vigorosi
torsi dai muscoli salienti, a bozze lucide e tonde, le vesciche dei manieristi michelangio-
leschi, tra cui s'affondano intense e marcate le ombre; il nudo Cristo dei Carmini ha
membra sottili e forbite, che tremuli solchi ombrano appena; tenui fibre s'intrecciano,
come sopra scorza d'albero, sulle gambe tese, variando di continuo la direzione della
luce, mentre il volto indefinito, quasi macerato da colpi battuti nel bronzo, sembra
velarsi di nebbia, disperdersi nell'atmosfera ambiente.
La gradazione degli oggetti dà al rilievo delicatezza incomparabile, distanze vaghe
tra figura e figura: i lineamenti del giovinetto ultimo a destra, attenuati da nebbie
impalpabili di luce, le chiome lievi, gli occhi socchiusi, lungimiranti, come quelli della
statua di Santa Caterina, trasportano in un mondo irreale, di paradisiache evanescenze,
mentre i lineamenti di San Giovanni, meditabondo di faccia al cadavere, e quelli di
Maria, che ansiosa scruta il volto del Cristo, son precisati con affilata crudezza di taglio,
con vigore di curve sottili, di forbite lame, che ci ricorda gli spigoli acuti delle cristal-
line architetture composte da Francesco di Giorgio Martini. Una energia potente anima
1 profili solcati dall'ombra, squisiti nell'espressione di dolore e di sospiro.
Nel centro, ai piedi della croce, in contrasto con quel raccoglimento, due Marie
urlanti, scapigliate, Furie in preda a delirio, traversano come raffiche la scena, in un
turbine di veli e di ciocche, in un fantastico brulichìo di faville. Gli atteggiamenti
opposti e varii delle figure, che si protendono, e, a vicenda, s'immergono in lontane
1 La Deposizione dei Carmini fu la prima volta
pubblicata da W. Bode (Una tavola in bronzo di
Andrea del Verrocchio nella chiesa del Carmine a Ve-
nezia, in Archivio storico dell'Arte,XI, Roma, 1893,
77-84), seguito nell'attribuzione da A. Venturi, Un
bronzo del Verrocchio (è quello già nel Museo del-
l'Università e ora nella R. Pinacoteca di Perugia) ne
L'Arte, V, Roma, 1902, 43-44.
Più tardi W. Bode (Denkmàler der Renaissance-
Sculptur Toscanas, Miinchen, 1892-1905, testo p. 146,
tavola 447) insistette ancora nell'attribuzione, ma poi
giunse ad attribuire l'opera a Leonardo (Leonardo als
lìildhauer in Jahrbuch der kóniglich Preuszischen Kun-
stsammlungen, XXV, Berlin, 1904, 132-137).
Per l'attribuzione a Bertoldo, vedi A. Venturi,
Storia dell'Arte Italiana, VI, 507-508; per l'attribu-
zione a Francesco di Giorgio, cfr. P. Schubring, Die
Plastik Sienas im Quattrocento, Berlin, 1907, 186-188.