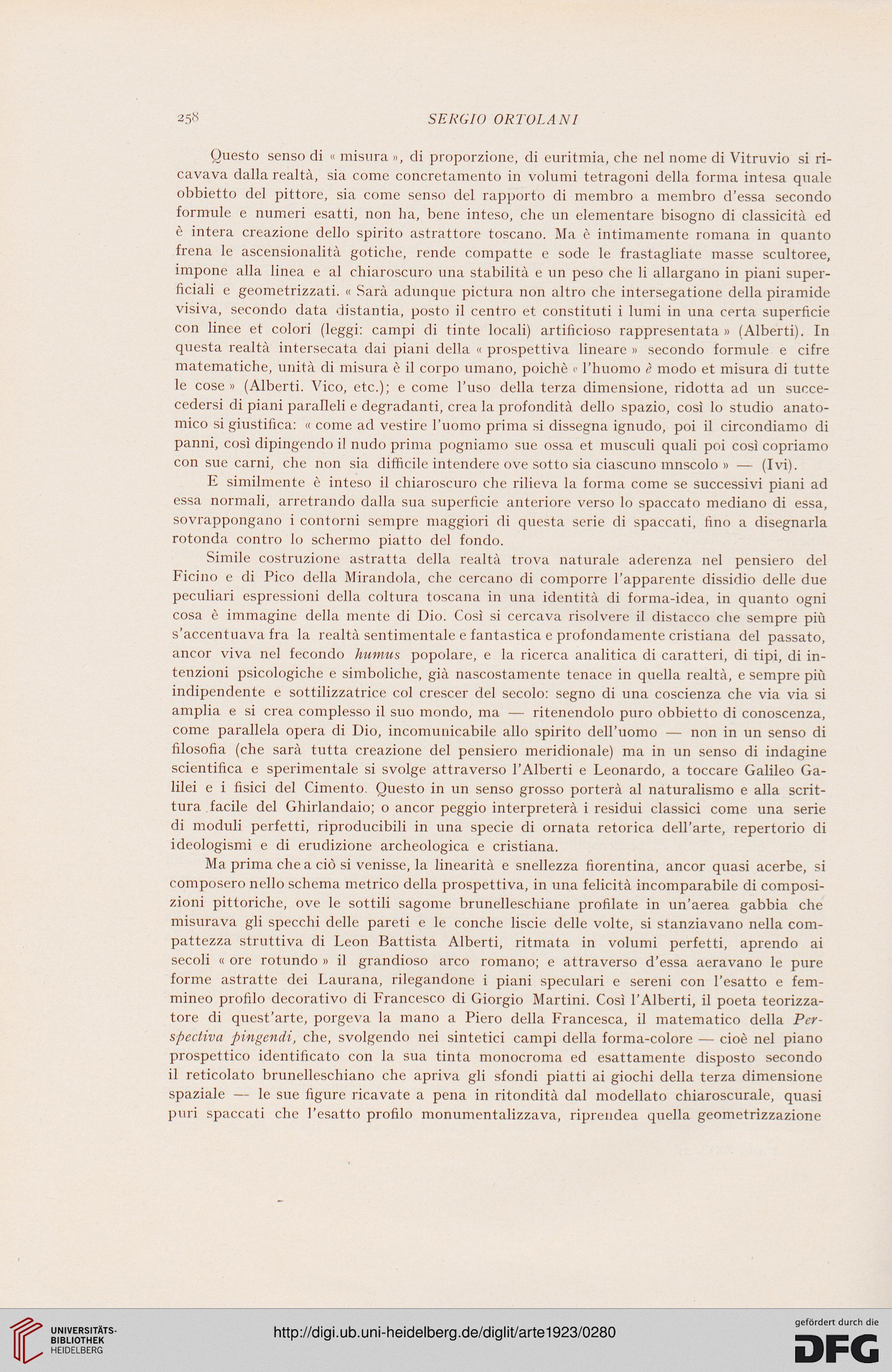258
SERGIO ORTOLANI
Questo senso di « misura », di proporzione, di euritmia, che nel nome di Vitruvio si ri-
cavava dalla realtà, sia come concretamento in volumi tetragoni della forma intesa quale
obbietto del pittore, sia come senso del rapporto di membro a membro d'essa secondo
formule e numeri esatti, non ha, bene inteso, che un elementare bisogno di classicità ed
è intera creazione dello spirito astrattore toscano. Ma è intimamente romana in quanto
frena le ascensionalità gotiche, rende compatte e sode le frastagliate masse scultoree,
impone alla linea e al chiaroscuro una stabilità e un peso che li allargano in piani super-
ficiali e geometrizzati. « Sarà adunque pit tura non altro che intersegatione della piramide
visiva, secondo data distantia, posto il centro et constituti i lumi in una certa superficie
con linee et colori (leggi: campi di tinte locali) artificioso rappresentata» (Alberti). In
questa realtà intersecata dai piani della « prospettiva lineare » secondo formule e cifre
matematiche, unità di misura è il corpo umano, poiché e l'huomo è modo et misura di tutte
le cose» (Alberti. Vico, etc); e come l'uso della terza dimensione, ridotta ad un succe-
cedersi di piani paralleli e degradanti, crea la profondità dello spazio, così lo studio anato-
mico si giustifica: « come ad vestire l'uomo prima si dissegna ignudo, poi il circondiamo di
panni, così dipingendo il nudo prima pogniamo sue ossa et musculi quali poi così copriamo
con sue carni, che non sia difficile intendere ove sotto sia ciascuno mnscolo » — (Ivi).
E similmente è inteso il chiaroscuro che rilieva la forma come se successivi piani ad
essa normali, arretrando dalla sua superficie anteriore verso lo spaccato mediano di essa,
sovrappongano i contorni sempre maggiori di questa serie di spaccati, fino a disegnarla
rotonda contro lo schermo piatto del fondo.
Simile costruzione astratta della realtà trova naturale aderenza nel pensiero del
Ficino e di Pico della Mirandola, che cercano di comporre l'apparente dissidio delle due
peculiari espressioni della coltura toscana in una identità di forma-idea, in quanto ogni
cosa è immagine della mente di Dio. Così si cercava risolvere il distacco che sempre più
s'accentuava fra la realtà sentimentale e fantastica e profondamente cristiana del passato,
ancor viva nel fecondo humus popolare, e la ricerca analitica di caratteri, di tipi, di in-
tenzioni psicologiche e simboliche, già nascostamente tenace in quella realtà, e sempre più
indipendente e sottilizzatrice col crescer del secolo: segno di una coscienza che via via si
amplia e si crea complesso il suo mondo, ma — ritenendolo puro obbietto di conoscenza,
come parallela opera di Dio, incomunicabile allo spirito dell'uomo — non in un senso di
filosofia (che sarà tutta creazione del pensiero meridionale) ma in un senso di indagine
scientifica e sperimentale si svolge attraverso l'Alberti e Leonardo, a toccare Galileo Ga-
lilei e i fisici del Cimento. Questo in un senso grosso porterà al naturalismo e alla scrit-
tura facile del Ghirlandaio; o ancor peggio interpreterà i residui classici come una serie
di moduli perfetti, riproducibili in una specie di ornata retorica dell'arte, repertorio di
ideologismi e di erudizione archeologica e cristiana.
Ma prima che a ciò si venisse, la linearità e snellezza fiorentina, ancor quasi acerbe, si
composero nello schema metrico della prospettiva, in una felicità incomparabile di composi-
zioni pittoriche, ove le sottili sagome brunelleschiane profilate in un'aerea gabbia che
misurava gli specchi delle pareti e le conche liscie delle volte, si stanziavano nella com-
pattezza struttiva di Leon Battista Alberti, ritmata in volumi perfetti, aprendo ai
secoli « ore rotundo » il grandioso arco romano; e attraverso d'essa aeravano le pure
forme astratte dei Laurana, rilegandone i piani speculari e sereni con l'esatto e fem-
mineo profilo decorativo di Francesco di Giorgio Martini. Così l'Alberti, il poeta teorizza-
tore di quest'arte, porgeva la mano a Piero della Francesca, il matematico della Per-
spectìva pingendi, che, svolgendo nei sintetici campi della forma-colore — cioè nel piano
prospettico identificato con la sua tinta monocroma ed esattamente disposto secondo
il reticolato brunelleschiano che apriva gli sfondi piatti ai giochi della terza dimensione
spaziale — le sue figure ricavate a pena in ritondità dal modellato chiaroscurale, quasi
puri spaccati che l'esatto profilo monumentalizzava, riprendea quella geometrizzazione
SERGIO ORTOLANI
Questo senso di « misura », di proporzione, di euritmia, che nel nome di Vitruvio si ri-
cavava dalla realtà, sia come concretamento in volumi tetragoni della forma intesa quale
obbietto del pittore, sia come senso del rapporto di membro a membro d'essa secondo
formule e numeri esatti, non ha, bene inteso, che un elementare bisogno di classicità ed
è intera creazione dello spirito astrattore toscano. Ma è intimamente romana in quanto
frena le ascensionalità gotiche, rende compatte e sode le frastagliate masse scultoree,
impone alla linea e al chiaroscuro una stabilità e un peso che li allargano in piani super-
ficiali e geometrizzati. « Sarà adunque pit tura non altro che intersegatione della piramide
visiva, secondo data distantia, posto il centro et constituti i lumi in una certa superficie
con linee et colori (leggi: campi di tinte locali) artificioso rappresentata» (Alberti). In
questa realtà intersecata dai piani della « prospettiva lineare » secondo formule e cifre
matematiche, unità di misura è il corpo umano, poiché e l'huomo è modo et misura di tutte
le cose» (Alberti. Vico, etc); e come l'uso della terza dimensione, ridotta ad un succe-
cedersi di piani paralleli e degradanti, crea la profondità dello spazio, così lo studio anato-
mico si giustifica: « come ad vestire l'uomo prima si dissegna ignudo, poi il circondiamo di
panni, così dipingendo il nudo prima pogniamo sue ossa et musculi quali poi così copriamo
con sue carni, che non sia difficile intendere ove sotto sia ciascuno mnscolo » — (Ivi).
E similmente è inteso il chiaroscuro che rilieva la forma come se successivi piani ad
essa normali, arretrando dalla sua superficie anteriore verso lo spaccato mediano di essa,
sovrappongano i contorni sempre maggiori di questa serie di spaccati, fino a disegnarla
rotonda contro lo schermo piatto del fondo.
Simile costruzione astratta della realtà trova naturale aderenza nel pensiero del
Ficino e di Pico della Mirandola, che cercano di comporre l'apparente dissidio delle due
peculiari espressioni della coltura toscana in una identità di forma-idea, in quanto ogni
cosa è immagine della mente di Dio. Così si cercava risolvere il distacco che sempre più
s'accentuava fra la realtà sentimentale e fantastica e profondamente cristiana del passato,
ancor viva nel fecondo humus popolare, e la ricerca analitica di caratteri, di tipi, di in-
tenzioni psicologiche e simboliche, già nascostamente tenace in quella realtà, e sempre più
indipendente e sottilizzatrice col crescer del secolo: segno di una coscienza che via via si
amplia e si crea complesso il suo mondo, ma — ritenendolo puro obbietto di conoscenza,
come parallela opera di Dio, incomunicabile allo spirito dell'uomo — non in un senso di
filosofia (che sarà tutta creazione del pensiero meridionale) ma in un senso di indagine
scientifica e sperimentale si svolge attraverso l'Alberti e Leonardo, a toccare Galileo Ga-
lilei e i fisici del Cimento. Questo in un senso grosso porterà al naturalismo e alla scrit-
tura facile del Ghirlandaio; o ancor peggio interpreterà i residui classici come una serie
di moduli perfetti, riproducibili in una specie di ornata retorica dell'arte, repertorio di
ideologismi e di erudizione archeologica e cristiana.
Ma prima che a ciò si venisse, la linearità e snellezza fiorentina, ancor quasi acerbe, si
composero nello schema metrico della prospettiva, in una felicità incomparabile di composi-
zioni pittoriche, ove le sottili sagome brunelleschiane profilate in un'aerea gabbia che
misurava gli specchi delle pareti e le conche liscie delle volte, si stanziavano nella com-
pattezza struttiva di Leon Battista Alberti, ritmata in volumi perfetti, aprendo ai
secoli « ore rotundo » il grandioso arco romano; e attraverso d'essa aeravano le pure
forme astratte dei Laurana, rilegandone i piani speculari e sereni con l'esatto e fem-
mineo profilo decorativo di Francesco di Giorgio Martini. Così l'Alberti, il poeta teorizza-
tore di quest'arte, porgeva la mano a Piero della Francesca, il matematico della Per-
spectìva pingendi, che, svolgendo nei sintetici campi della forma-colore — cioè nel piano
prospettico identificato con la sua tinta monocroma ed esattamente disposto secondo
il reticolato brunelleschiano che apriva gli sfondi piatti ai giochi della terza dimensione
spaziale — le sue figure ricavate a pena in ritondità dal modellato chiaroscurale, quasi
puri spaccati che l'esatto profilo monumentalizzava, riprendea quella geometrizzazione