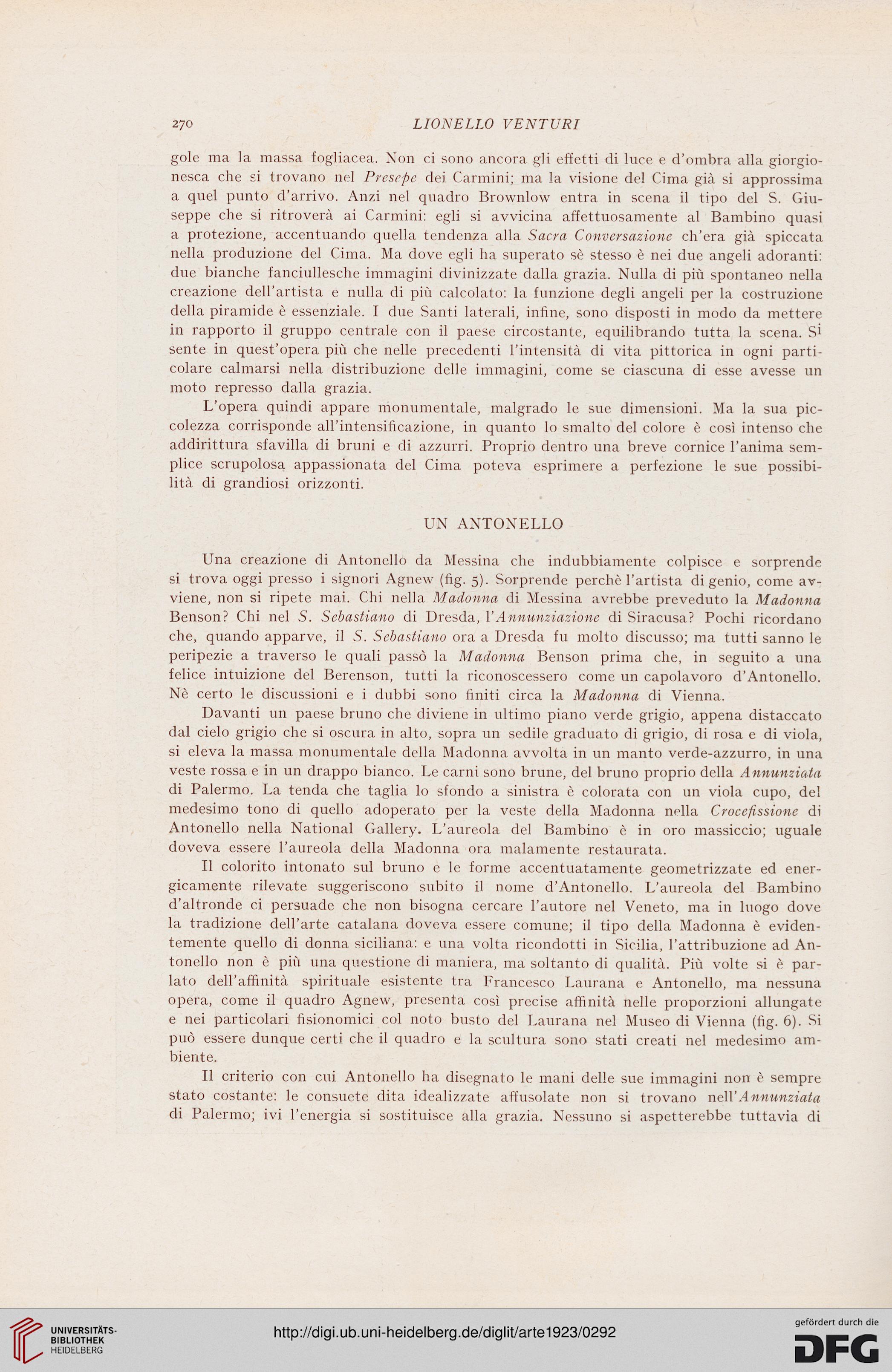270
LIONELLO VENTURI
gole ma la massa fogliacea. Non ci sono ancora gli effetti di luce e d'ombra alla giorgio-
nesca che si trovano nel Presepe dei Carmini; ma la visione del Cima già si approssima
a quel punto d'arrivo. Anzi nel quadro Brownlow entra in scena il tipo del S. Giu-
seppe che si ritroverà ai Carmini: egli si avvicina affettuosamente al Bambino quasi
a protezione, accentuando quella tendenza alla Sacra Conversazione ch'era già spiccata
nella produzione del Cima. Ma dove egli ha superato sè stesso è nei due angeli adoranti:
due bianche fanciullesche immagini divinizzate dalla grazia. Nulla di più spontaneo nella
creazione dell'artista e nulla di più calcolato: la funzione degli angeli per la costruzione
della piramide è essenziale. I due Santi laterali, infine, sono disposti in modo da mettere
in rapporto il gruppo centrale con il paese circostante, equilibrando tutta la scena. S1
sente in quest'opera più che nelle precedenti l'intensità di vita pittorica in ogni parti-
colare calmarsi nella distribuzione delle immagini, come se ciascuna di esse avesse un
moto represso dalla grazia.
L'opera quindi appare monumentale, malgrado le sue dimensioni. Ma la sua pic-
colezza corrisponde all'intensificazione, in quanto lo smalto del colore è così intenso che
addirittura sfavilla di bruni e di azzurri. Proprio dentro una breve cornice l'anima sem-
plice scrupolosa appassionata del Cima poteva esprimere a perfezione le sue possibi-
lità di grandiosi orizzonti.
UN ANTONELLO
Una creazione di Antonello da Messina che indubbiamente colpisce e sorprende
si trova oggi presso i signori Agnew (fig. 5). Sorprende perchè l'artista di genio, come av-
viene, non si ripete mai. Chi nella Madonna di Messina avrebbe preveduto la Madonna
Benson? Chi nel S. Sebastiano di Dresda, VAnnunziazionc di Siracusa? Pochi ricordano
che, quando apparve, il 5. Sebastiano ora a Dresda fu molto discusso; ma tutti sanno le
peripezie a traverso le quali passò la Madonna Benson prima che, in seguito a una
felice intuizione del Berenson, tutti la riconoscessero come un capolavoro d'Antonello.
Nè certo le discussioni e i dubbi sono finiti circa la Madonna di Vienna.
Davanti un paese bruno che diviene in ultimo piano verde grigio, appena distaccato
dal cielo grigio che si oscura in alto, sopra un sedile graduato di grigio, di rosa e di viola,
si eleva la massa monumentale della Madonna avvolta in un manto verde-azzurro, in una
veste rossa e in un drappo bianco. Le carni sono brune, del bruno proprio della Annunziata
di Palermo. La tenda che taglia lo sfondo a sinistra è colorata con un viola cupo, del
medesimo tono di quello adoperato per la veste della Madonna nella Crocefissione di
Antonello nella National Gallery. L'aureola del Bambino è in oro massiccio; uguale
doveva essere l'aureola della Madonna ora malamente restaurata.
Il colorito intonato sul bruno e le forme accentuatamente geometrizzate ed ener-
gicamente rilevate suggeriscono subito il nome d'Antonello. L'aureola del Bambino
d'altronde ci persuade che non bisogna cercare l'autore nel Veneto, ma in luogo dove
la tradizione dell'arte catalana doveva essere comune; il tipo della Madonna è eviden-
temente quello di donna siciliana: e una volta ricondotti in Sicilia, l'attribuzione ad An-
tonello non è più una questione di maniera, ma soltanto di qualità. Più volte si è par-
lato dell'affinità spirituale esistente tra Francesco Laurana e Antonello, ma nessuna
opera, come il quadro Agnew, presenta così precise affinità nelle proporzioni allungate
e nei particolari fisionomici col noto busto del Laurana nel Museo di Vienna (fig. 6). Si
può essere dunque certi che il quadro e la scultura sono stati creati nel medesimo am-
biente.
Il criterio con cui Antonello ha disegnato le mani delle sue immagini non è sempre
stato costante: le consuete dita idealizzate affusolate non si trovano ne\Y Annunziata
di Palermo; ivi l'energia si sostituisce alla grazia. Nessuno si aspetterebbe tuttavia di
LIONELLO VENTURI
gole ma la massa fogliacea. Non ci sono ancora gli effetti di luce e d'ombra alla giorgio-
nesca che si trovano nel Presepe dei Carmini; ma la visione del Cima già si approssima
a quel punto d'arrivo. Anzi nel quadro Brownlow entra in scena il tipo del S. Giu-
seppe che si ritroverà ai Carmini: egli si avvicina affettuosamente al Bambino quasi
a protezione, accentuando quella tendenza alla Sacra Conversazione ch'era già spiccata
nella produzione del Cima. Ma dove egli ha superato sè stesso è nei due angeli adoranti:
due bianche fanciullesche immagini divinizzate dalla grazia. Nulla di più spontaneo nella
creazione dell'artista e nulla di più calcolato: la funzione degli angeli per la costruzione
della piramide è essenziale. I due Santi laterali, infine, sono disposti in modo da mettere
in rapporto il gruppo centrale con il paese circostante, equilibrando tutta la scena. S1
sente in quest'opera più che nelle precedenti l'intensità di vita pittorica in ogni parti-
colare calmarsi nella distribuzione delle immagini, come se ciascuna di esse avesse un
moto represso dalla grazia.
L'opera quindi appare monumentale, malgrado le sue dimensioni. Ma la sua pic-
colezza corrisponde all'intensificazione, in quanto lo smalto del colore è così intenso che
addirittura sfavilla di bruni e di azzurri. Proprio dentro una breve cornice l'anima sem-
plice scrupolosa appassionata del Cima poteva esprimere a perfezione le sue possibi-
lità di grandiosi orizzonti.
UN ANTONELLO
Una creazione di Antonello da Messina che indubbiamente colpisce e sorprende
si trova oggi presso i signori Agnew (fig. 5). Sorprende perchè l'artista di genio, come av-
viene, non si ripete mai. Chi nella Madonna di Messina avrebbe preveduto la Madonna
Benson? Chi nel S. Sebastiano di Dresda, VAnnunziazionc di Siracusa? Pochi ricordano
che, quando apparve, il 5. Sebastiano ora a Dresda fu molto discusso; ma tutti sanno le
peripezie a traverso le quali passò la Madonna Benson prima che, in seguito a una
felice intuizione del Berenson, tutti la riconoscessero come un capolavoro d'Antonello.
Nè certo le discussioni e i dubbi sono finiti circa la Madonna di Vienna.
Davanti un paese bruno che diviene in ultimo piano verde grigio, appena distaccato
dal cielo grigio che si oscura in alto, sopra un sedile graduato di grigio, di rosa e di viola,
si eleva la massa monumentale della Madonna avvolta in un manto verde-azzurro, in una
veste rossa e in un drappo bianco. Le carni sono brune, del bruno proprio della Annunziata
di Palermo. La tenda che taglia lo sfondo a sinistra è colorata con un viola cupo, del
medesimo tono di quello adoperato per la veste della Madonna nella Crocefissione di
Antonello nella National Gallery. L'aureola del Bambino è in oro massiccio; uguale
doveva essere l'aureola della Madonna ora malamente restaurata.
Il colorito intonato sul bruno e le forme accentuatamente geometrizzate ed ener-
gicamente rilevate suggeriscono subito il nome d'Antonello. L'aureola del Bambino
d'altronde ci persuade che non bisogna cercare l'autore nel Veneto, ma in luogo dove
la tradizione dell'arte catalana doveva essere comune; il tipo della Madonna è eviden-
temente quello di donna siciliana: e una volta ricondotti in Sicilia, l'attribuzione ad An-
tonello non è più una questione di maniera, ma soltanto di qualità. Più volte si è par-
lato dell'affinità spirituale esistente tra Francesco Laurana e Antonello, ma nessuna
opera, come il quadro Agnew, presenta così precise affinità nelle proporzioni allungate
e nei particolari fisionomici col noto busto del Laurana nel Museo di Vienna (fig. 6). Si
può essere dunque certi che il quadro e la scultura sono stati creati nel medesimo am-
biente.
Il criterio con cui Antonello ha disegnato le mani delle sue immagini non è sempre
stato costante: le consuete dita idealizzate affusolate non si trovano ne\Y Annunziata
di Palermo; ivi l'energia si sostituisce alla grazia. Nessuno si aspetterebbe tuttavia di