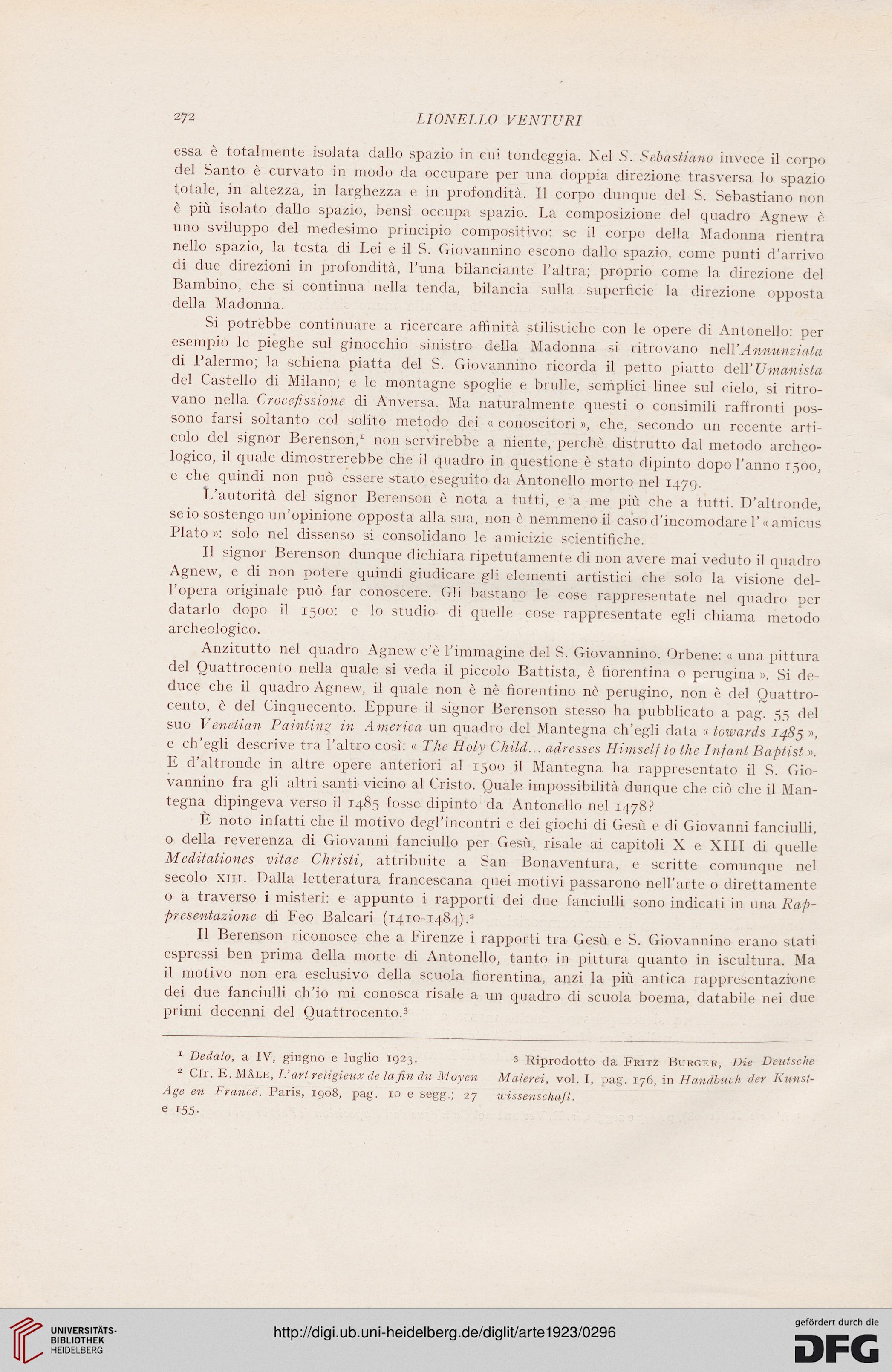272
LIONELLO VENTURI
essa è totalmente isolata dallo spazio in cui tondeggia. Nel S. Sebastiano invece il corpo
del Santo è curvato in modo da occupare per una doppia direzione trasversa lo spazio
totale, in altezza, in larghezza e in profondità. 11 corpo dunque del S. Sebastiano non
è più isolato dallo spazio, bensì occupa spazio. La composizione del quadro Agnew è
uno sviluppo del medesimo principio compositivo: se il corpo della Madonna rientra
nello spazio, la testa di Lei e il S. Giovannino escono dallo spazio, come punti d'arrivo
di due direzioni in profondità, l'una bilanciante l'altra; proprio come la direzione del
Bambino, che si continua nella tenda, bilancia sulla superficie la direzione opposta
della Madonna.
Si potrebbe continuare a ricercare affinità stilistiche con le opere di Antonello: per
esempio le pieghe sul ginocchio sinistro della Madonna si ritrovano nell''Annunziata
di Palermo; la schiena piatta del S. Giovannino ricorda il petto piatto dell'Umanista
del Castello di Milano; e le montagne spoglie e brulle, semplici linee sul cielo, si ritro-
vano nella Crocefissione di Anversa. Ma naturalmente questi o consimili raffronti pos-
sono farsi soltanto col solito metodo dei « conoscitori », che, secondo un recente arti-
colo del signor Berenson,1 non servirebbe a niente, perchè distrutto dal metodo archeo-
logico, il quale dimostrerebbe che il quadro in questione è stato dipinto dopo l'anno 1500,
e che quindi non può essere stato eseguito da Antonello morto nel 1479.
L'autorità del signor Berenson è nota a tutti, e a me più che a tutti. D'altronde,
se io sostengo un'opinione opposta alla sua, non è nemmeno il caso d'incomodare 1' « amicus
Plato »: solo nel dissenso si consolidano le amicizie scientifiche.
Il signor Berenson dunque dichiara ripetutamente di non avere mai veduto il quadro
Agnew, e di non potere quindi giudicale gli elementi artistici che solo la visione del-
l'opera originale può far conoscere. Gli bastano le cose rappresentate nel quadro per
datarlo dopo il 1500: e lo studio di quelle cose rappresentate egli chiama metodo
archeologico.
Anzitutto nel quadro Agnew c'è l'immagine del S, Giovannino. Orbene: « una pittura
del Quattrocento nella quale si veda il piccolo Battista, è fiorentina o perugina ». Si de-
duce che il quadro Agnew, il quale non è nè fiorentino nè perugino, non è del Quattro-
cento, è del Cinquecento. Eppure il signor Berenson stesso ha pubblicato a pag. 55 del
suo Venetian Painting in America un quadro del Mantegna ch'egli data « towards 1485 »,
e ch'egli descrive tra l'altro così: « The Holy Child... adresses Himsclf to the Infuni Baptist ».
E d'altronde in altre opere anteriori al 1500 il .Mantegna ha rappresentato il S. Gio-
vannino fra gli altri santi vicino al Cristo. Quale impossibilità dunque che ciò che il Man-
tegna dipingeva verso il 1485 fosse dipinto da Antonello nel 1478?
È noto infatti che il motivo degl'incontri e dei giochi di Gesù e di Giovanni fanciulli,
o della reverenza di Giovanni fanciullo per Gesù, risale ai capitoli X e XIII di quelle
Mcditationes vitae Christi, attribuite a San Bonaventura, e scritte comunque nel
secolo xiii. Dalla letteratura francescana quei motivi passarono nell'arte o direttamente
o a traverso i misteri: e appunto i rapporti dei due fanciulli sono indicati in una Rap-
presentazione di Feo Balcari (1410-1484).2
Il Berenson riconosce che a Firenze i rapporti tra Gesù e S. Giovannino erano stati
espressi ben prima della morte di Antonello, tanto in pittura quanto in iscultura. Ma
il motivo non era esclusivo della scuola fiorentina, anzi la più antica rappresentazione
dei due fanciulli ch'io mi conosca risale a un quadro di scuola boema, databile nei due
primi decenni del Quattrocento.3
1 Dedalo, a IV, giugno e luglio 1923. 3 Riprodotto da Fritz Hurgkr, Die Deutsche
2 Cfr. E. MAle, L'art re ligieux d'e la fin du Moyen Malerei, voi. i, pag. 176, in Handbuch der hunst-
Age en Franca. Paris, kjo8, pag. 10 e segg.; 27 wissenschafl.
e 155-
LIONELLO VENTURI
essa è totalmente isolata dallo spazio in cui tondeggia. Nel S. Sebastiano invece il corpo
del Santo è curvato in modo da occupare per una doppia direzione trasversa lo spazio
totale, in altezza, in larghezza e in profondità. 11 corpo dunque del S. Sebastiano non
è più isolato dallo spazio, bensì occupa spazio. La composizione del quadro Agnew è
uno sviluppo del medesimo principio compositivo: se il corpo della Madonna rientra
nello spazio, la testa di Lei e il S. Giovannino escono dallo spazio, come punti d'arrivo
di due direzioni in profondità, l'una bilanciante l'altra; proprio come la direzione del
Bambino, che si continua nella tenda, bilancia sulla superficie la direzione opposta
della Madonna.
Si potrebbe continuare a ricercare affinità stilistiche con le opere di Antonello: per
esempio le pieghe sul ginocchio sinistro della Madonna si ritrovano nell''Annunziata
di Palermo; la schiena piatta del S. Giovannino ricorda il petto piatto dell'Umanista
del Castello di Milano; e le montagne spoglie e brulle, semplici linee sul cielo, si ritro-
vano nella Crocefissione di Anversa. Ma naturalmente questi o consimili raffronti pos-
sono farsi soltanto col solito metodo dei « conoscitori », che, secondo un recente arti-
colo del signor Berenson,1 non servirebbe a niente, perchè distrutto dal metodo archeo-
logico, il quale dimostrerebbe che il quadro in questione è stato dipinto dopo l'anno 1500,
e che quindi non può essere stato eseguito da Antonello morto nel 1479.
L'autorità del signor Berenson è nota a tutti, e a me più che a tutti. D'altronde,
se io sostengo un'opinione opposta alla sua, non è nemmeno il caso d'incomodare 1' « amicus
Plato »: solo nel dissenso si consolidano le amicizie scientifiche.
Il signor Berenson dunque dichiara ripetutamente di non avere mai veduto il quadro
Agnew, e di non potere quindi giudicale gli elementi artistici che solo la visione del-
l'opera originale può far conoscere. Gli bastano le cose rappresentate nel quadro per
datarlo dopo il 1500: e lo studio di quelle cose rappresentate egli chiama metodo
archeologico.
Anzitutto nel quadro Agnew c'è l'immagine del S, Giovannino. Orbene: « una pittura
del Quattrocento nella quale si veda il piccolo Battista, è fiorentina o perugina ». Si de-
duce che il quadro Agnew, il quale non è nè fiorentino nè perugino, non è del Quattro-
cento, è del Cinquecento. Eppure il signor Berenson stesso ha pubblicato a pag. 55 del
suo Venetian Painting in America un quadro del Mantegna ch'egli data « towards 1485 »,
e ch'egli descrive tra l'altro così: « The Holy Child... adresses Himsclf to the Infuni Baptist ».
E d'altronde in altre opere anteriori al 1500 il .Mantegna ha rappresentato il S. Gio-
vannino fra gli altri santi vicino al Cristo. Quale impossibilità dunque che ciò che il Man-
tegna dipingeva verso il 1485 fosse dipinto da Antonello nel 1478?
È noto infatti che il motivo degl'incontri e dei giochi di Gesù e di Giovanni fanciulli,
o della reverenza di Giovanni fanciullo per Gesù, risale ai capitoli X e XIII di quelle
Mcditationes vitae Christi, attribuite a San Bonaventura, e scritte comunque nel
secolo xiii. Dalla letteratura francescana quei motivi passarono nell'arte o direttamente
o a traverso i misteri: e appunto i rapporti dei due fanciulli sono indicati in una Rap-
presentazione di Feo Balcari (1410-1484).2
Il Berenson riconosce che a Firenze i rapporti tra Gesù e S. Giovannino erano stati
espressi ben prima della morte di Antonello, tanto in pittura quanto in iscultura. Ma
il motivo non era esclusivo della scuola fiorentina, anzi la più antica rappresentazione
dei due fanciulli ch'io mi conosca risale a un quadro di scuola boema, databile nei due
primi decenni del Quattrocento.3
1 Dedalo, a IV, giugno e luglio 1923. 3 Riprodotto da Fritz Hurgkr, Die Deutsche
2 Cfr. E. MAle, L'art re ligieux d'e la fin du Moyen Malerei, voi. i, pag. 176, in Handbuch der hunst-
Age en Franca. Paris, kjo8, pag. 10 e segg.; 27 wissenschafl.
e 155-