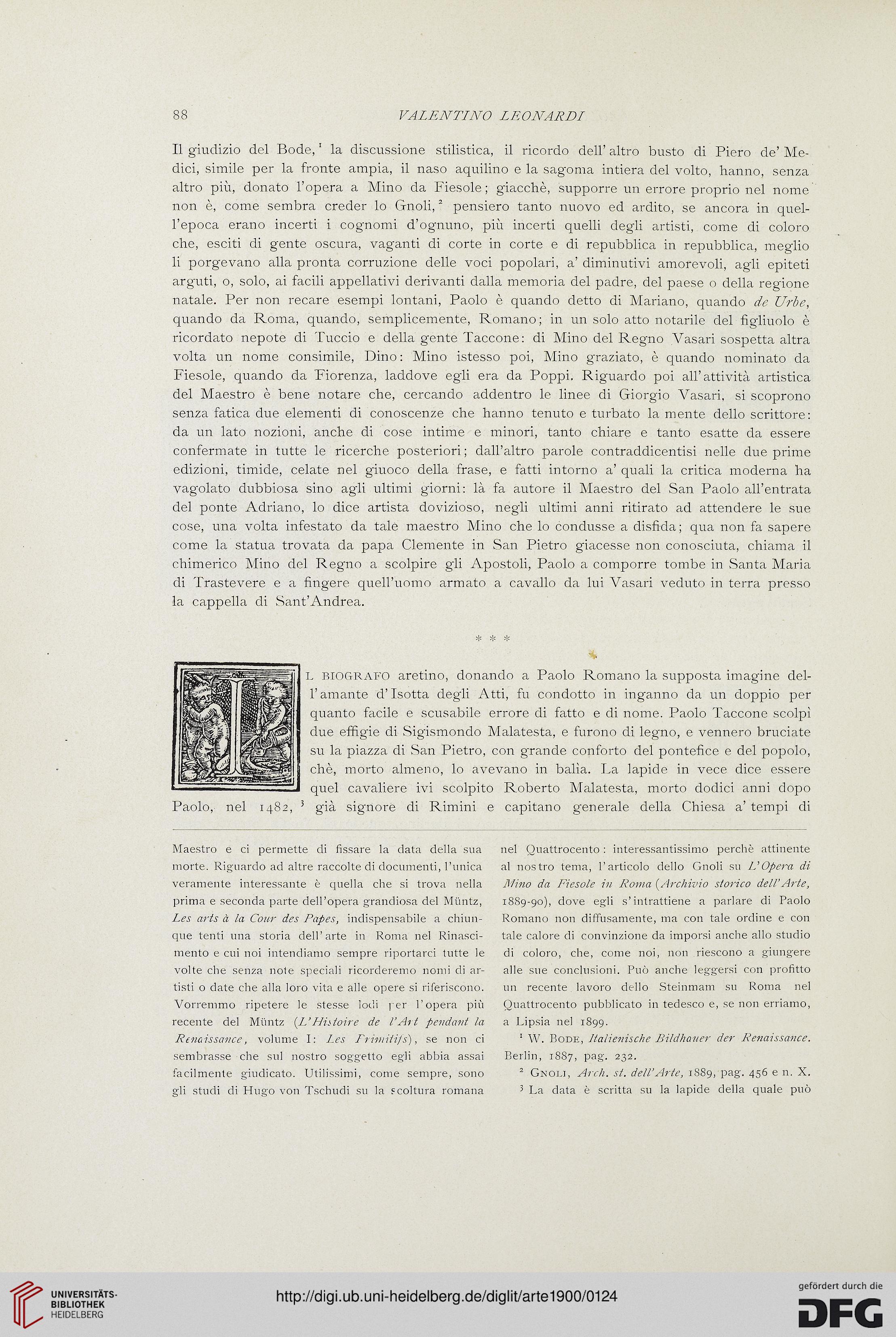88
VALENTINO LEONARDI
Il giudizio del Bode,1 la discussione stilistica, il ricordo dell' altro busto di Piero de' Me-
dici, simile per la fronte ampia, il naso aquilino e la sagoma intiera del volto, hanno, senza
altro più, donato l'opera a Mino da Presole; giacché, supporre un errore proprio nel nome
non è, come sembra creder lo Gnoli,2 pensiero tanto nuovo ed ardito, se ancora in quel-
l'epoca erano incerti i cognomi d'ognuno, più incerti quelli degli artisti, come di coloro
che, esciti di gente oscura, vaganti di corte in corte e di repubblica in repubblica, meglio
li porgevano alla pronta corruzione delle voci popolari, a' diminutivi amorevoli, agli epiteti
arguti, o, solo, ai facili appellativi derivanti dalla memoria del padre, del paese o della regione
natale. Per non recare esempi lontani, Paolo è quando detto di Mariano, quando de Urbe,
quando da Roma, quando, semplicemente, Romano; in un solo atto notarile del figliuolo è
ricordato nepote di Puccio e della gente Paccone: di Mino del Regno Vasari sospetta altra
volta un nome consimile, Dino : Mino istesso poi, Mino graziato, è quando nominato da
Fiesole, quando da Piorenza, laddove egli era da Poppi. Riguardo poi all'attività artistica
del Maestro è bene notare che, cercando addentro le linee di Giorgio Vasari, si scoprono
senza fatica due elementi di conoscenze che hanno tenuto e turbato la mente dello scrittore:
da un lato nozioni, anche di cose intime e minori, tanto chiare e tanto esatte da essere
confermate in tutte le ricerche posteriori ; dall'altro parole contraddicentisi nelle due prime
edizioni, timide, celate nel giuoco della frase, e fatti intorno a' quali la critica moderna ha
vagolato dubbiosa sino agli ultimi giorni: là fa autore il Maestro del San Paolo all'entrata
del ponte Adriano, lo dice artista dovizioso, negli ultimi anni ritirato ad attendere le sue
cose, una volta infestato da tale maestro Mino che lo condusse a disfida; qua non fa sapere
come la statua trovata da papa Clemente in San Pietro giacesse non conosciuta, chiama il
chimerico Mino del Regno a scolpire gli Apostoli, Paolo a comporre tombe in Santa Maria
di Prastevere e a fingere quell'uomo armato a cavallo da lui Vasari veduto in terra presso
la cappella di Sant'Andrea.
* * *
L biografo aretino, donando a Paolo Romano la supposta imagine del-
l'amante d'Isotta degli Atti, fu condotto in inganno da un doppio per
quanto facile e scusabile errore di fatto e di nome. Paolo Paccone scolpì
due effigie di Sigismondo Malatesta, e furono di legno, e vennero bruciate
su la piazza di San Pietro, con grande conforto del pontefice e del popolo,
chè, morto almeno, lo avevano in balìa. La lapide in vece dice essere
quel cavaliere ivi scolpito Roberto Malatesta, morto dodici anni dopo
Paolo, nel 1482, 3 già signore di Rimini e capitano generale della Chiesa a' tempi di
Maestro e ci permette di fissare la data della sua
morte. Riguardo ad altre raccolte di documenti, l'unica
veramente interessante è quella che si trova nella
prima e seconda parte dell'opera grandiosa del Muntz,
Les arts à la Cour des Papes, indispensabile a chiun-
que tenti una storia dell'arte in Roma nel Rinasci-
mento e cui noi intendiamo sempre riportarci tutte le
volte che senza note speciali ricorderemo nomi di ar-
tisti o date che alla loro vita e alle opere si riferiscono.
Vorremmo ripetere le stesse lodi ] er l'opera più
recente del Muntz {L'Hùtoire de l'Art pendant la
Renaissance, volume I: Les FrìrfriU/s), se non ci
sembrasse che sul nostro soggetto egli abbia assai
facilmente giudicato. Utilissimi, come sempre, sono
gli studi di Hugo von Tschudi su la ? coltura romana
nel Quattrocento : interessantissimo perchè attinente
al nostro tema, l'articolo dello Gnoli su L'Opera di
Mino da Fiesole in Roma {Archivio storico dell' Arte,
1889-90), dove egli s'intrattiene a parlare di Paolo
Romano non diffusamente, ma con tale ordine e con
tale calore di convinzione da imporsi anche allo studio
di coloro, che, come noi, non riescono a giungere
alle sue conclusioni. Può anche leggersi con profitto
un recente lavoro dello Stein-mani su Roma nel
Quattrocento pubblicato in tedesco e, se non erriamo,
a Lipsia nel 1899.
1 W. Bode, lt alieniseli e Bildhaner der Renaissance.
Berlin, 1887, pag. 232.
2 Gnoli, Ardi. st. dell'Arte, 1889, pag. 456 e n. X.
3 La data è scritta su la lapide della quale può
VALENTINO LEONARDI
Il giudizio del Bode,1 la discussione stilistica, il ricordo dell' altro busto di Piero de' Me-
dici, simile per la fronte ampia, il naso aquilino e la sagoma intiera del volto, hanno, senza
altro più, donato l'opera a Mino da Presole; giacché, supporre un errore proprio nel nome
non è, come sembra creder lo Gnoli,2 pensiero tanto nuovo ed ardito, se ancora in quel-
l'epoca erano incerti i cognomi d'ognuno, più incerti quelli degli artisti, come di coloro
che, esciti di gente oscura, vaganti di corte in corte e di repubblica in repubblica, meglio
li porgevano alla pronta corruzione delle voci popolari, a' diminutivi amorevoli, agli epiteti
arguti, o, solo, ai facili appellativi derivanti dalla memoria del padre, del paese o della regione
natale. Per non recare esempi lontani, Paolo è quando detto di Mariano, quando de Urbe,
quando da Roma, quando, semplicemente, Romano; in un solo atto notarile del figliuolo è
ricordato nepote di Puccio e della gente Paccone: di Mino del Regno Vasari sospetta altra
volta un nome consimile, Dino : Mino istesso poi, Mino graziato, è quando nominato da
Fiesole, quando da Piorenza, laddove egli era da Poppi. Riguardo poi all'attività artistica
del Maestro è bene notare che, cercando addentro le linee di Giorgio Vasari, si scoprono
senza fatica due elementi di conoscenze che hanno tenuto e turbato la mente dello scrittore:
da un lato nozioni, anche di cose intime e minori, tanto chiare e tanto esatte da essere
confermate in tutte le ricerche posteriori ; dall'altro parole contraddicentisi nelle due prime
edizioni, timide, celate nel giuoco della frase, e fatti intorno a' quali la critica moderna ha
vagolato dubbiosa sino agli ultimi giorni: là fa autore il Maestro del San Paolo all'entrata
del ponte Adriano, lo dice artista dovizioso, negli ultimi anni ritirato ad attendere le sue
cose, una volta infestato da tale maestro Mino che lo condusse a disfida; qua non fa sapere
come la statua trovata da papa Clemente in San Pietro giacesse non conosciuta, chiama il
chimerico Mino del Regno a scolpire gli Apostoli, Paolo a comporre tombe in Santa Maria
di Prastevere e a fingere quell'uomo armato a cavallo da lui Vasari veduto in terra presso
la cappella di Sant'Andrea.
* * *
L biografo aretino, donando a Paolo Romano la supposta imagine del-
l'amante d'Isotta degli Atti, fu condotto in inganno da un doppio per
quanto facile e scusabile errore di fatto e di nome. Paolo Paccone scolpì
due effigie di Sigismondo Malatesta, e furono di legno, e vennero bruciate
su la piazza di San Pietro, con grande conforto del pontefice e del popolo,
chè, morto almeno, lo avevano in balìa. La lapide in vece dice essere
quel cavaliere ivi scolpito Roberto Malatesta, morto dodici anni dopo
Paolo, nel 1482, 3 già signore di Rimini e capitano generale della Chiesa a' tempi di
Maestro e ci permette di fissare la data della sua
morte. Riguardo ad altre raccolte di documenti, l'unica
veramente interessante è quella che si trova nella
prima e seconda parte dell'opera grandiosa del Muntz,
Les arts à la Cour des Papes, indispensabile a chiun-
que tenti una storia dell'arte in Roma nel Rinasci-
mento e cui noi intendiamo sempre riportarci tutte le
volte che senza note speciali ricorderemo nomi di ar-
tisti o date che alla loro vita e alle opere si riferiscono.
Vorremmo ripetere le stesse lodi ] er l'opera più
recente del Muntz {L'Hùtoire de l'Art pendant la
Renaissance, volume I: Les FrìrfriU/s), se non ci
sembrasse che sul nostro soggetto egli abbia assai
facilmente giudicato. Utilissimi, come sempre, sono
gli studi di Hugo von Tschudi su la ? coltura romana
nel Quattrocento : interessantissimo perchè attinente
al nostro tema, l'articolo dello Gnoli su L'Opera di
Mino da Fiesole in Roma {Archivio storico dell' Arte,
1889-90), dove egli s'intrattiene a parlare di Paolo
Romano non diffusamente, ma con tale ordine e con
tale calore di convinzione da imporsi anche allo studio
di coloro, che, come noi, non riescono a giungere
alle sue conclusioni. Può anche leggersi con profitto
un recente lavoro dello Stein-mani su Roma nel
Quattrocento pubblicato in tedesco e, se non erriamo,
a Lipsia nel 1899.
1 W. Bode, lt alieniseli e Bildhaner der Renaissance.
Berlin, 1887, pag. 232.
2 Gnoli, Ardi. st. dell'Arte, 1889, pag. 456 e n. X.
3 La data è scritta su la lapide della quale può