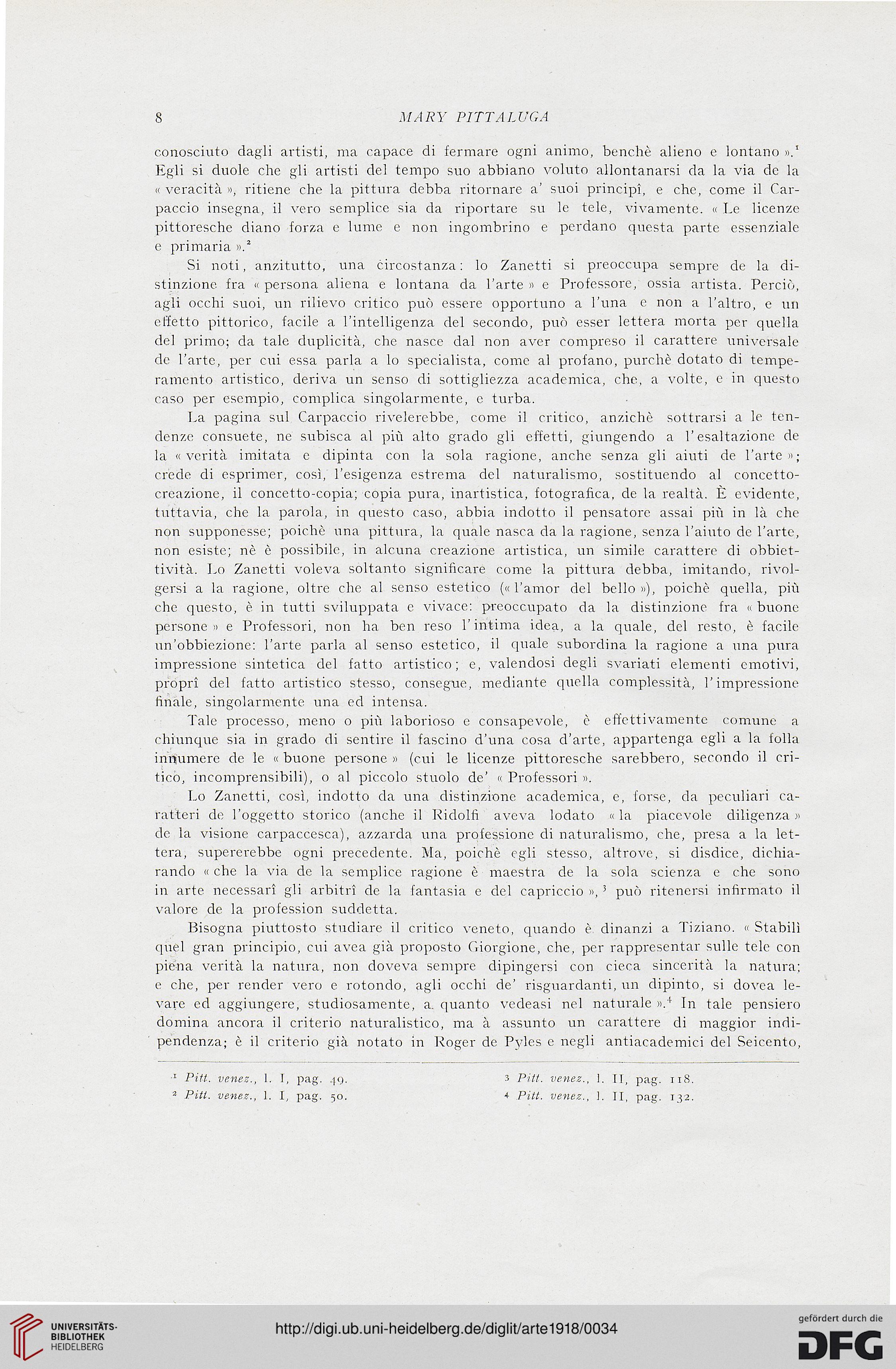8
MARY PITTA LUCA.
conosciuto dagli artisti, ma capace di fermare ogni animo, benché alieno e lontano >>.'
Egli si duole clic gli artisti del tempo suo abbiano voluto allontanarsi da la via de la
« veracità », ritiene che la pittura debba ritornare a' suoi principi, e che, come il Car-
paccio insegna, il vero semplice sia da riportare su le tele, vivamente. « Le licenze
pittoresche diano forza e lume e non ingombrino e perdano questa parte essenziale
e primaria ».2
Si noti, anzitutto, una circostanza: lo Zanetti si preoccupa sempre de la di-
stinzione fra « persona aliena e lontana da l'arte » e Professore, ossia artista. Perciò,
agli occhi suoi, un rilievo critico può essere opportuno a l'ima e non a l'altro, e un
effetto pittorico, facile a l'intelligenza del secondo, può esser lettera morta per quella
del primo; da tale, duplicità, che nasce dal non aver compreso il carattere universale
de l'arte, per cui essa parla a lo specialista, come al profano, purché dotato di tempe-
ramento artistico, deriva un senso di sottigliezza academica, che, a volte, e in questo
caso per esempio, complica singolarmente, e turba.
La pagina sul Carpaccio rivelerebbe, come il critico, anziché sottrarsi a le ten-
denze consuete, ne subisca al più alto grado gli effetti, giungendo a l'esaltazione de
la «verità imitata e dipinta con la sola ragione, anche senza gli aiuti de l'arte»;
crede di esprimer, così, l'esigenza estrema del naturalismo, sostituendo al concetto-
creazione, il concetto-copia; copia pura, inartistica, fotografica, de la realtà. E evidente,
tuttavia, che la parola, in questo caso, abbia indotto il pensatore assai più in là che
non supponesse; poiché una pittura, la quale nasca da la ragione, senza l'aiuto de l'arte,
non esiste; né è possibile, in alcuna creazione artistica, un simile carattere di obbiet-
tività. Lo Zanetti voleva soltanto significare come la pittura debba, imitando, rivol-
gersi a la ragione, oltre che al senso estetico («l'amor del bello»), poiché quella, più
che questo, è in tutti sviluppata e vivace: preoccupato da la distinzione fra « buone
persone » e Professori, non ha ben reso l'intima idea, a la quale, del resto, è facile
un'obbiezione: l'arte parla al senso estetico, il quale subordina la ragione a una pura
impressione sintetica del fatto artistico; e, valendosi degli svariati elementi emotivi,
propri del fatto artistico stesso, consegue, mediante quella complessità, l'impressione
finale, singolarmente una ed intensa.
Tale processo, meno o più laborioso e consapevole, è effettivamente comune a
chiunque sia in grado di sentire il fascino d'una cosa d'arte, appartenga egli a la folla
innumere de le « buone persone » (cui le licenze pittoresche sarebbero, secondo il cri-
tico, incomprensibili), o al piccolo stuolo de' « Professori ».
Lo Zanetti, così, indotto da una distinzione academica, e, forse, da peculiari ca-
ratteri de l'oggetto storico (anche il Ridolfi aveva lodato «la piacevole diligenza»
de la visione carpaccesca), azzarda una professione di naturalismo, che, presa a la let-
tera, supererebbe ogni precedente. Ma, poiché egli stesso, altrove, si disdice, dichia-
rando « che la via de la semplice ragione è maestra de la sola scienza e che sono
in arte necessari gli arbitri de la fantasia e del capriccio », ' può ritenersi infirmato il
valore de la profession suddetta.
Bisogna piuttosto studiare il critico veneto, quando è dinanzi a Tiziano. « Stabilì
quel gran principio, cui avea già proposto Giorgione, che, per rappresentar sulle tele con
piena verità la natura, non doveva sempre dipingersi con cieca sincerità la natura;
e che, per render vero e rotondo, agli occhi de' risguardanti, un dipinto, si dovea le-
vare ed aggiungere, studiosamente, a. (pianto vedeasi nel naturale ».+ In tale pensiero
domina ancora il criterio naturalistico, ma à assunto un carattere di maggior indi-
pendenza; è il criterio già notato in Roger de Pyles e negli antiacademici del Seicento,
-1 Pitt. venez., 1. I, pag. 49. 3 Piti, venez., ì. II, pag. 118.
3 Piti, venez., 1. I, pag. 50. 4 Pitt. venez., ì. II, pag. 132.
MARY PITTA LUCA.
conosciuto dagli artisti, ma capace di fermare ogni animo, benché alieno e lontano >>.'
Egli si duole clic gli artisti del tempo suo abbiano voluto allontanarsi da la via de la
« veracità », ritiene che la pittura debba ritornare a' suoi principi, e che, come il Car-
paccio insegna, il vero semplice sia da riportare su le tele, vivamente. « Le licenze
pittoresche diano forza e lume e non ingombrino e perdano questa parte essenziale
e primaria ».2
Si noti, anzitutto, una circostanza: lo Zanetti si preoccupa sempre de la di-
stinzione fra « persona aliena e lontana da l'arte » e Professore, ossia artista. Perciò,
agli occhi suoi, un rilievo critico può essere opportuno a l'ima e non a l'altro, e un
effetto pittorico, facile a l'intelligenza del secondo, può esser lettera morta per quella
del primo; da tale, duplicità, che nasce dal non aver compreso il carattere universale
de l'arte, per cui essa parla a lo specialista, come al profano, purché dotato di tempe-
ramento artistico, deriva un senso di sottigliezza academica, che, a volte, e in questo
caso per esempio, complica singolarmente, e turba.
La pagina sul Carpaccio rivelerebbe, come il critico, anziché sottrarsi a le ten-
denze consuete, ne subisca al più alto grado gli effetti, giungendo a l'esaltazione de
la «verità imitata e dipinta con la sola ragione, anche senza gli aiuti de l'arte»;
crede di esprimer, così, l'esigenza estrema del naturalismo, sostituendo al concetto-
creazione, il concetto-copia; copia pura, inartistica, fotografica, de la realtà. E evidente,
tuttavia, che la parola, in questo caso, abbia indotto il pensatore assai più in là che
non supponesse; poiché una pittura, la quale nasca da la ragione, senza l'aiuto de l'arte,
non esiste; né è possibile, in alcuna creazione artistica, un simile carattere di obbiet-
tività. Lo Zanetti voleva soltanto significare come la pittura debba, imitando, rivol-
gersi a la ragione, oltre che al senso estetico («l'amor del bello»), poiché quella, più
che questo, è in tutti sviluppata e vivace: preoccupato da la distinzione fra « buone
persone » e Professori, non ha ben reso l'intima idea, a la quale, del resto, è facile
un'obbiezione: l'arte parla al senso estetico, il quale subordina la ragione a una pura
impressione sintetica del fatto artistico; e, valendosi degli svariati elementi emotivi,
propri del fatto artistico stesso, consegue, mediante quella complessità, l'impressione
finale, singolarmente una ed intensa.
Tale processo, meno o più laborioso e consapevole, è effettivamente comune a
chiunque sia in grado di sentire il fascino d'una cosa d'arte, appartenga egli a la folla
innumere de le « buone persone » (cui le licenze pittoresche sarebbero, secondo il cri-
tico, incomprensibili), o al piccolo stuolo de' « Professori ».
Lo Zanetti, così, indotto da una distinzione academica, e, forse, da peculiari ca-
ratteri de l'oggetto storico (anche il Ridolfi aveva lodato «la piacevole diligenza»
de la visione carpaccesca), azzarda una professione di naturalismo, che, presa a la let-
tera, supererebbe ogni precedente. Ma, poiché egli stesso, altrove, si disdice, dichia-
rando « che la via de la semplice ragione è maestra de la sola scienza e che sono
in arte necessari gli arbitri de la fantasia e del capriccio », ' può ritenersi infirmato il
valore de la profession suddetta.
Bisogna piuttosto studiare il critico veneto, quando è dinanzi a Tiziano. « Stabilì
quel gran principio, cui avea già proposto Giorgione, che, per rappresentar sulle tele con
piena verità la natura, non doveva sempre dipingersi con cieca sincerità la natura;
e che, per render vero e rotondo, agli occhi de' risguardanti, un dipinto, si dovea le-
vare ed aggiungere, studiosamente, a. (pianto vedeasi nel naturale ».+ In tale pensiero
domina ancora il criterio naturalistico, ma à assunto un carattere di maggior indi-
pendenza; è il criterio già notato in Roger de Pyles e negli antiacademici del Seicento,
-1 Pitt. venez., 1. I, pag. 49. 3 Piti, venez., ì. II, pag. 118.
3 Piti, venez., 1. I, pag. 50. 4 Pitt. venez., ì. II, pag. 132.