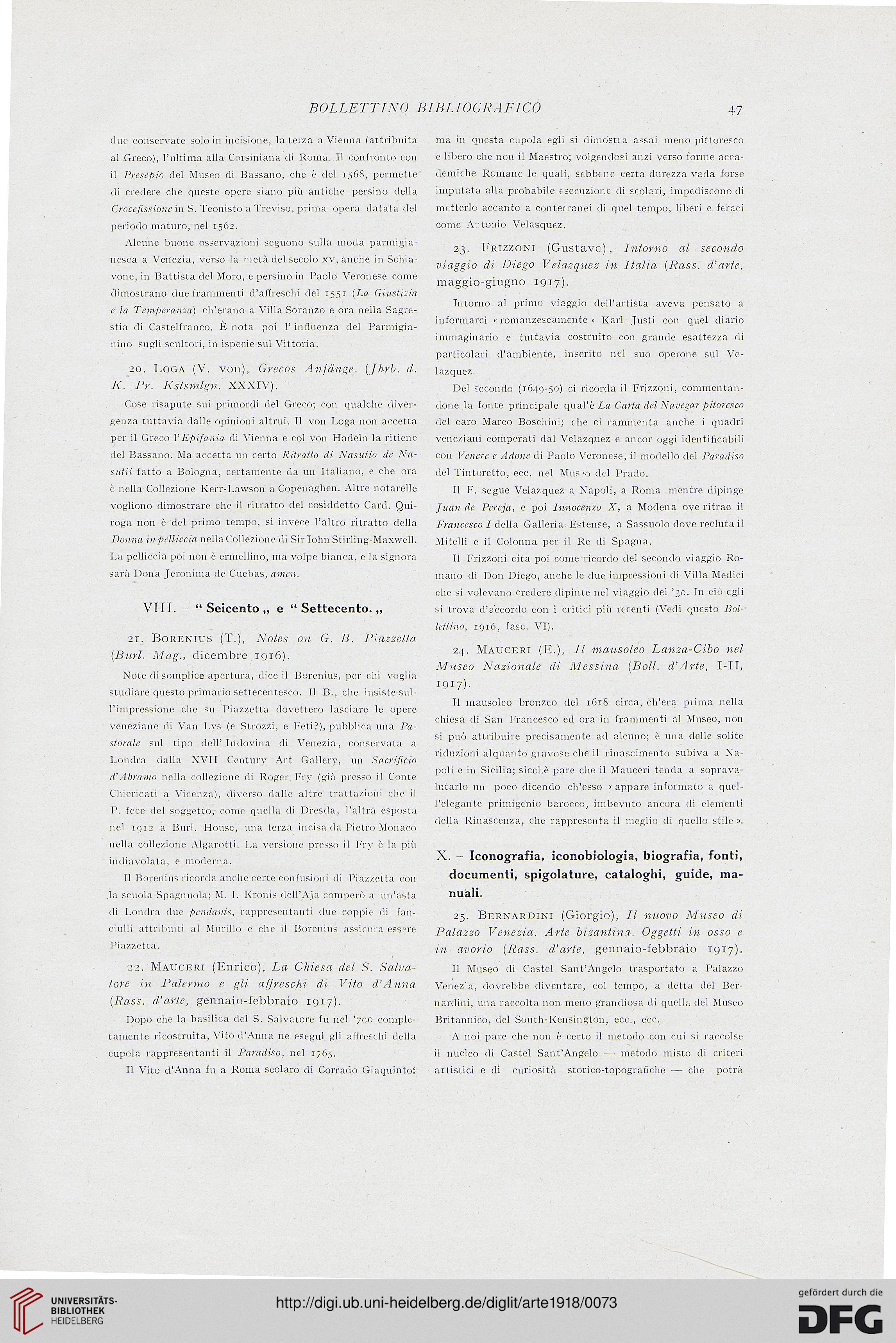BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
47
due conservate solo in incisione, la terza a Vienna (attribuita
al Greco), l'ultima alla Corsiniana eli Roma. Il confronto con
il Presepio del Museo di Bassano, che è del 156S, permette
di credere che queste opere siano più antiche persino della
Crocefissionein S. Teonisto a Treviso, prima opera datata del
periodo maturo, nel 1562.
Alcune buone osservazioni seguono sulla moda parmigia-
nesca a Venezia, verso là metà del secolo xv, anche in Schia-
vone, in Battista del Moro, e persino in Paolo Veronese come
dimostrano due frammenti d'affreschi del 1551 {La Giustizia
e la Temperanza) ch'erano a Villa Soranzo e ora nella Sagre-
stia di Castelfranco. È nota poi V influènza del Parmigta-
nino sugli scultori, in ispecie sul Vittoria.
20. Loga (V. von), Grecos Anfdnge. (Jhrb. d.
K. Pr. Kstsmlgn.' XXXIV).
Cose risapute sui primordi del Greco; con qualche diver-
genza tuttavia dalle opinioni altrui. TI von Loga non accetta
per il Greco VEpifania di Vienna e col von Hadeln la ritiene
del Bassano. Ma accetta un certo Ritratta di Nasutio de Na-
suta fatto a Bologna, certamente da un Italiano, e che ora
è nella Collezione Kerr-Lawson a Copenaghen. Altre notarellc
vogliono dimostrare che il ritratto del cosiddetto Card. Qui-
roga non è del primo tempo, sì invece l'altro ritratto della
Donna inpelliccia nella Collezione dì Sirlohn Stirling-Maxwéll.
La pelliccia poi non è ermellino, ma volpe bianca, e la signora
sarà Dona Jeronima de Cuebas, amen,
VTIT. - "Seicento,, e "Settecento.,,
21. Borenius (T.), Notes on G. B. Piazzetta
(Buri. Mag., dicembre 1916).
Note di somplice apertura, dice il Borenius, per chi voglia
studiare questo primario settecentesco. Il B.. clic insiste sul-
l'impressione che su Piazzetta dovettero lasciare le opere
veneziane di Van Lys (e Strozzi, e Feti?)) pubblica una Pa-
storale sul tipo dell' Indovina di Venezia, conservata a
Londra dalla XVII Century Art Gallery, un Sa cri fi eia
d% Àbramo nella collezione di Roger, Fry (già presso il Conte
Chiericati a Vicenza), diverso dalle altre trattazioni che il
P. fece del soggetto,- come quella di Dresda, l'altra esposta
nel 1912 a Buri. House, una terza incisa da Pietro Monaco
nella collezione Algarntti. La versione presso il Frv è la più
indiavolata, e moderna.
Il Borenius ricorda anche certe confusioni di Piazzetta con
.la scuola Spaglinola; M. 1. Kronis dell'Ajà comperò a un'asta
di Londra due pendant*, rappresentanti due coppie di fan-
ciulli attribuiti al Murillo e che il Borenius assicura ess'*re
Piazzetta.
22. Mauceri (Enrico), La Chiesa del S. Salva-
tore in Palermo e gli affreschi di Vito d'Anna
(Rass. d'arte, gennaio-febbraio 1917).
Dopo che la basilica del S. Salvatore fu nel '700 comple-
tamente ricostruita, Vito d'Anna ne eseguì gli affreschi della
cupola rappresentanti il Paradiso, nel 1765.
Il Vite d'Anna fu a Roma scolaro di Corrado Gi a quinto.
ma in questa cupola egli si dimostra assai meno pittoresco
e libero che non il Maestro; volgendosi anzi verso forme acca-
demiche Remane le quali, sebbene certa durezza vada forse
imputata alla probabile esecuzione di scolari, impediscono di
metterlo accanto a conterranei di quel tempo, liberi e feraci
Come Antonio Velasquez.
23. Frizzoni (Gustave), Intorno al secondo
viaggio di Diego Velazquez in Italia (Rass. d'arte,
maggio-giugno 1917).
Intorno al primo viaggio dell'artista aveva pensato a
infermarci «romanzescamente)) Karl Justi con quel diario
immaginario e tuttavia costruito con grande esattezza di
particolari d'ambiente, inserito nel svio operane sul Ve-
lazquez,
Del secondo (1649-50) ci ricorda il Frizzoni, commentan-
done la fonte principale qual'è La Carta del Navegar pitoresco
del caro Marco Boschini; che ci rammenta anche i quadri
veneziani comperati dal Velazqnez e ancor oggi identificabili
con Venere e Adone di Paolo Veronese, il modello del Paradiso
del Tintoretto, ecc. nel Mus?o del Prado.
Il F. segue Velazquez a Napoli, a Roma mentre dipinge
Juan de Percja, e poi Innocenzo X, a Modena ove ritrae il
Francesco I della Galleria Estense, a Sassuolo dove recluta il
Mitelli e il Colonna per il Re di Spagna.
Il Frizzoni cita poi come ricordo del secondo viaggio Ro-
mano di Don Diego, anche le due impressioni di Villa Medici
che si volevano credere dipinte nel viaggio del '30. In ciò egli
si trova d'accordo con i critici più recenti (Vedi questo Bol-
lettino, 1916, fase. VI).
24. Mauceri (E.), Il mausoleo Lanza-Cibo nel
Museo Nazionale di Messina (Boll. d'Arte, I-IT,
Il mausoleo bronzeo del 1618 circa, ch'era prima nella
chiesa di San Francesco ed ora in frammenti al Museo, non
si può attribuire precisamente ad alcuno; è una delle solite
riduzioni alquanto gì avose che il rinascimento subiva a Na-
poli e in Sicilia; sicché pare che il Mauceri tenda a soprava-
lutarlo un poco dicendo ch'esso «appare informato a quel-
l'elegante primigenio barocco, imbevuto ancora di elementi
della Rinascenza, che rappresenta il meglio di quello stile ».
X. - Iconografia, iconobiologia, biografia, fonti,
documenti, spigolature, cataloghi, guide, ma-
nuali.
25. Bernardini (Giorgio), Il nuovo Museo di
Palazzo Venezia. Arte bizantina. Oggetti in osso e
in avorio (Rass. d'arte, gennaio-febbraio 1917).
11 Museo di Castel Sant'Angelo trasportato a Palazzo
Venez'a, dovrebbe diventare, col tempo, a detta de] Ber-
nardini, una raccolta non meno grandiosa di quella del Museo
Britannico, del South-Kcnsington, ecc., ecc.
A noi pare che non è certo il metodo con cui si raccolse
il nucleo di Castel Sant'Angelo —■ metodo misto di criteri
artistici e di curiosità storico-topografiche — che potrà
47
due conservate solo in incisione, la terza a Vienna (attribuita
al Greco), l'ultima alla Corsiniana eli Roma. Il confronto con
il Presepio del Museo di Bassano, che è del 156S, permette
di credere che queste opere siano più antiche persino della
Crocefissionein S. Teonisto a Treviso, prima opera datata del
periodo maturo, nel 1562.
Alcune buone osservazioni seguono sulla moda parmigia-
nesca a Venezia, verso là metà del secolo xv, anche in Schia-
vone, in Battista del Moro, e persino in Paolo Veronese come
dimostrano due frammenti d'affreschi del 1551 {La Giustizia
e la Temperanza) ch'erano a Villa Soranzo e ora nella Sagre-
stia di Castelfranco. È nota poi V influènza del Parmigta-
nino sugli scultori, in ispecie sul Vittoria.
20. Loga (V. von), Grecos Anfdnge. (Jhrb. d.
K. Pr. Kstsmlgn.' XXXIV).
Cose risapute sui primordi del Greco; con qualche diver-
genza tuttavia dalle opinioni altrui. TI von Loga non accetta
per il Greco VEpifania di Vienna e col von Hadeln la ritiene
del Bassano. Ma accetta un certo Ritratta di Nasutio de Na-
suta fatto a Bologna, certamente da un Italiano, e che ora
è nella Collezione Kerr-Lawson a Copenaghen. Altre notarellc
vogliono dimostrare che il ritratto del cosiddetto Card. Qui-
roga non è del primo tempo, sì invece l'altro ritratto della
Donna inpelliccia nella Collezione dì Sirlohn Stirling-Maxwéll.
La pelliccia poi non è ermellino, ma volpe bianca, e la signora
sarà Dona Jeronima de Cuebas, amen,
VTIT. - "Seicento,, e "Settecento.,,
21. Borenius (T.), Notes on G. B. Piazzetta
(Buri. Mag., dicembre 1916).
Note di somplice apertura, dice il Borenius, per chi voglia
studiare questo primario settecentesco. Il B.. clic insiste sul-
l'impressione che su Piazzetta dovettero lasciare le opere
veneziane di Van Lys (e Strozzi, e Feti?)) pubblica una Pa-
storale sul tipo dell' Indovina di Venezia, conservata a
Londra dalla XVII Century Art Gallery, un Sa cri fi eia
d% Àbramo nella collezione di Roger, Fry (già presso il Conte
Chiericati a Vicenza), diverso dalle altre trattazioni che il
P. fece del soggetto,- come quella di Dresda, l'altra esposta
nel 1912 a Buri. House, una terza incisa da Pietro Monaco
nella collezione Algarntti. La versione presso il Frv è la più
indiavolata, e moderna.
Il Borenius ricorda anche certe confusioni di Piazzetta con
.la scuola Spaglinola; M. 1. Kronis dell'Ajà comperò a un'asta
di Londra due pendant*, rappresentanti due coppie di fan-
ciulli attribuiti al Murillo e che il Borenius assicura ess'*re
Piazzetta.
22. Mauceri (Enrico), La Chiesa del S. Salva-
tore in Palermo e gli affreschi di Vito d'Anna
(Rass. d'arte, gennaio-febbraio 1917).
Dopo che la basilica del S. Salvatore fu nel '700 comple-
tamente ricostruita, Vito d'Anna ne eseguì gli affreschi della
cupola rappresentanti il Paradiso, nel 1765.
Il Vite d'Anna fu a Roma scolaro di Corrado Gi a quinto.
ma in questa cupola egli si dimostra assai meno pittoresco
e libero che non il Maestro; volgendosi anzi verso forme acca-
demiche Remane le quali, sebbene certa durezza vada forse
imputata alla probabile esecuzione di scolari, impediscono di
metterlo accanto a conterranei di quel tempo, liberi e feraci
Come Antonio Velasquez.
23. Frizzoni (Gustave), Intorno al secondo
viaggio di Diego Velazquez in Italia (Rass. d'arte,
maggio-giugno 1917).
Intorno al primo viaggio dell'artista aveva pensato a
infermarci «romanzescamente)) Karl Justi con quel diario
immaginario e tuttavia costruito con grande esattezza di
particolari d'ambiente, inserito nel svio operane sul Ve-
lazquez,
Del secondo (1649-50) ci ricorda il Frizzoni, commentan-
done la fonte principale qual'è La Carta del Navegar pitoresco
del caro Marco Boschini; che ci rammenta anche i quadri
veneziani comperati dal Velazqnez e ancor oggi identificabili
con Venere e Adone di Paolo Veronese, il modello del Paradiso
del Tintoretto, ecc. nel Mus?o del Prado.
Il F. segue Velazquez a Napoli, a Roma mentre dipinge
Juan de Percja, e poi Innocenzo X, a Modena ove ritrae il
Francesco I della Galleria Estense, a Sassuolo dove recluta il
Mitelli e il Colonna per il Re di Spagna.
Il Frizzoni cita poi come ricordo del secondo viaggio Ro-
mano di Don Diego, anche le due impressioni di Villa Medici
che si volevano credere dipinte nel viaggio del '30. In ciò egli
si trova d'accordo con i critici più recenti (Vedi questo Bol-
lettino, 1916, fase. VI).
24. Mauceri (E.), Il mausoleo Lanza-Cibo nel
Museo Nazionale di Messina (Boll. d'Arte, I-IT,
Il mausoleo bronzeo del 1618 circa, ch'era prima nella
chiesa di San Francesco ed ora in frammenti al Museo, non
si può attribuire precisamente ad alcuno; è una delle solite
riduzioni alquanto gì avose che il rinascimento subiva a Na-
poli e in Sicilia; sicché pare che il Mauceri tenda a soprava-
lutarlo un poco dicendo ch'esso «appare informato a quel-
l'elegante primigenio barocco, imbevuto ancora di elementi
della Rinascenza, che rappresenta il meglio di quello stile ».
X. - Iconografia, iconobiologia, biografia, fonti,
documenti, spigolature, cataloghi, guide, ma-
nuali.
25. Bernardini (Giorgio), Il nuovo Museo di
Palazzo Venezia. Arte bizantina. Oggetti in osso e
in avorio (Rass. d'arte, gennaio-febbraio 1917).
11 Museo di Castel Sant'Angelo trasportato a Palazzo
Venez'a, dovrebbe diventare, col tempo, a detta de] Ber-
nardini, una raccolta non meno grandiosa di quella del Museo
Britannico, del South-Kcnsington, ecc., ecc.
A noi pare che non è certo il metodo con cui si raccolse
il nucleo di Castel Sant'Angelo —■ metodo misto di criteri
artistici e di curiosità storico-topografiche — che potrà