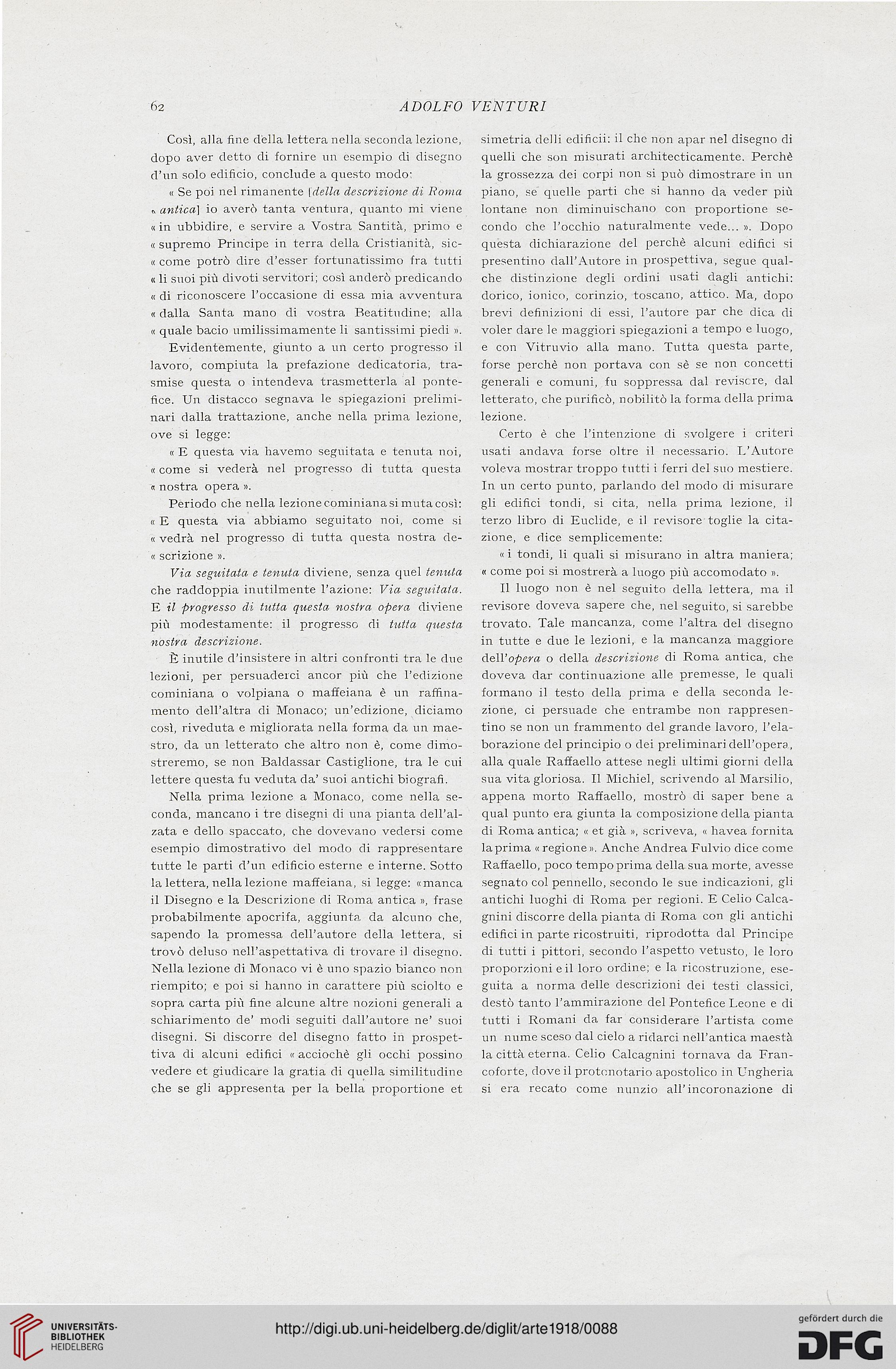62
ADOLFO VENTURI
Così, alla fine d'ella lettera nella seconda lezione,
dopo aver detto di fornire uri esempio di disegno
d'un solo edificio, conclude a questo modo:
« Se poi nel rimanente {della descrizione di Poma
« antica] io averò tanta ventura, quanto mi viene
« in ubbidire, e servire a Vostra Santità, primo e
« supremo Principe in terra della Cristianità, sie-
te come potrò dire d'esser fortunatissimo fra tutti
« li suoi più di voti servitori; così anelerò predicando
« di riconoscere l'occasione di essa mia avventura
« dalla Santa mano di vostra Beatitudine; alla
« quale bacio umilissimamente li santissimi piedi ».
Evidentemente, giunto a un certo progresso il
lavoro, compiuta la prefazione dedicatoria, tra-
smise questa o intendeva trasmetterla al ponte-
fice. Un distacco segnava le spiegazioni prelimi-
nari dalla trattazione, anche nella prima lezione,
ove si legge:
« E questa via havemo seguitata e tenuta noi,
« come si vederà nel progresso di tutta questa
« nostra opera ».
Periodo che nella lezione cominiana si muta così:
« E questa via abbiamo seguitato noi, come si
« vedrà nel progresso di tutta questa nostra de-
« scrizione ».
Via seguitata e tenuta diviene, senza quel tenuta
che raddoppia inutilmente l'azione: Via seguitata.
E il progresso di tutta questa nostra opera diviene
più modestamente: il progresso di tutta questa
nostra descrizione.
È inutile d'insistere in altri confronti tra le due
lezioni, per persuaderci ancor più che l'edizione
cominiana o volpiana o maffeiana è un raffina-
mento dell'altra di Monaco; un'edizione, diciamo
così, riveduta e migliorata nella forma da un mae-
stro, da un letterato che altro non è, come dimo-
streremo, se non Baldassar Castiglione, tra le cui
lettere questa fu veduta da' suoi antichi biografi.
Nella prima lezione a Monaco, come nella se-
conda, mancano i tre disegni di una, pianta dell'al-
zata e dello spaccato, che dovevano vedersi come
esempio dimostrativo del modo di rappresentare
tutte le parti d'un edificio esterne e interne. Sotto
la lettera, nella lezione maffeiana, si legge: «manca
il Disegno e la Descrizione di Roma antica », frase
probabilmente apocrifa, aggiunta da alcuno che,
sapendo la promessa dell'autore della lettera, si
trovò deluso nell'aspettativa di trovare il disegno.
Nella lezione di Monaco vi è uno spazio bianco non
riempito; e poi si hanno in carattere più sciolto e
sopra carta più fine alcune altre nozioni generali a
schiarimento de' modi seguiti dall'autore ne' suoi
disegni. Si discorre del disegno fatto in prospet-
tiva di alcuni edifici « acciochè gli occhi possino
vedere et giudicare la grafia di quella similitudine
Che se gli appresenta per la bella proportione et
simetria elei li edificii: il che non apar nel disegno di
quelli che son misurati architecticamente. Perchè
la grossezza dei corpi non si può dimostrare in un
piano, se quelle parti che si hanno da veder più
lontane non diminuischano con proportione se-
condo che l'occhio naturalmente vede... ». Dopo
questa dichiarazione del perchè alcuni edifici si
presentino dall'Autore in prospettiva, segue qual-
che distinzione degli ordini usati dagli antichi:
dorico, ionico, corinzio, toscano, attico. Ma, dopo
brevi definizioni di essi, l'autore par che dica di
voler dare le maggiori spiegazioni a tempo e luogo,
e con Vitruvio alla mano. Tutta questa parte,
forse perchè non portava con sè se non concetti
generali e comuni, fu soppressa dal revisore, dal
letterato, che purificò, nobilitò la forma della prima
lezione.
Certo è che l'intenzione di svolgere i criteri
usati andava forse oltre il necessario. L'Autore
voleva mostrar troppo tutti i ferri del suo mestiere.
In un certo punto, parlando del modo di misurare
gli edifici tondi, si cita, nella, prima lezione, il
terzo libro di Euclide, e il revisore'toglie la cita-
zione, e dice semplicemente:
« i tondi, li quali si misurano in altra maniera;
« come poi si mostrerà a luogo più accomodato ».
Il luogo non è nel seguito della lettera, ma il
revisore doveva sapere che, nel seguito, si sarebbe
trovato. Tale mancanza, come l'altra del disegno
in tutte e due le lezioni, e la mancanza maggiore
dell'opera o della descrizione di Roma antica, che
doveva dar continuazione alle premesse, le quali
formano il testo della prima e della seconda le-
zione, ci persuade che entrambe non rappresen-
tino se non un frammento del grande lavoro, l'ela-
borazione del principio o dei preliminari dell'opera,
alla quale Raffaello attese negli ultimi giorni della
sua vita gloriosa. Il Michiel, scrivendo al Marsilio,
appena morto Raffaello, mostrò di saper bene a
qual punto era giunta la composizione della pianta
di Roma antica; « et già », scriveva, « havea fornita
la prima «regione». Anche Andrea Fulvio dice come
Raffaello, poco tempo prima della sua morte, avesse
segnato col pennello, secondo le sue indicazioni, gli
antichi luoghi di Roma per regioni. E Celio Calca-
gnini discorre della pianta di Roma con gli antichi
edifici in parte ricostruiti, riprodotta dal Principe
di tutti i pittori, secondo l'aspetto vetusto, le loro
proporzioni e il loro ordine; e la ricostruzione, ese-
guita a norma delle descrizioni dei testi classici,
destò tanto l'ammirazione del Pontefice Leone e di
tutti i Romani da far considerare l'artista come
un nume sceso dal cielo a ridarci nell'antica maestà
la città eterna. Celio Calcagnini tornava da Fran-
coforte, dove il protonotario apostolico in Ungheria
si era recato come nunzio all'incoronazione di
ADOLFO VENTURI
Così, alla fine d'ella lettera nella seconda lezione,
dopo aver detto di fornire uri esempio di disegno
d'un solo edificio, conclude a questo modo:
« Se poi nel rimanente {della descrizione di Poma
« antica] io averò tanta ventura, quanto mi viene
« in ubbidire, e servire a Vostra Santità, primo e
« supremo Principe in terra della Cristianità, sie-
te come potrò dire d'esser fortunatissimo fra tutti
« li suoi più di voti servitori; così anelerò predicando
« di riconoscere l'occasione di essa mia avventura
« dalla Santa mano di vostra Beatitudine; alla
« quale bacio umilissimamente li santissimi piedi ».
Evidentemente, giunto a un certo progresso il
lavoro, compiuta la prefazione dedicatoria, tra-
smise questa o intendeva trasmetterla al ponte-
fice. Un distacco segnava le spiegazioni prelimi-
nari dalla trattazione, anche nella prima lezione,
ove si legge:
« E questa via havemo seguitata e tenuta noi,
« come si vederà nel progresso di tutta questa
« nostra opera ».
Periodo che nella lezione cominiana si muta così:
« E questa via abbiamo seguitato noi, come si
« vedrà nel progresso di tutta questa nostra de-
« scrizione ».
Via seguitata e tenuta diviene, senza quel tenuta
che raddoppia inutilmente l'azione: Via seguitata.
E il progresso di tutta questa nostra opera diviene
più modestamente: il progresso di tutta questa
nostra descrizione.
È inutile d'insistere in altri confronti tra le due
lezioni, per persuaderci ancor più che l'edizione
cominiana o volpiana o maffeiana è un raffina-
mento dell'altra di Monaco; un'edizione, diciamo
così, riveduta e migliorata nella forma da un mae-
stro, da un letterato che altro non è, come dimo-
streremo, se non Baldassar Castiglione, tra le cui
lettere questa fu veduta da' suoi antichi biografi.
Nella prima lezione a Monaco, come nella se-
conda, mancano i tre disegni di una, pianta dell'al-
zata e dello spaccato, che dovevano vedersi come
esempio dimostrativo del modo di rappresentare
tutte le parti d'un edificio esterne e interne. Sotto
la lettera, nella lezione maffeiana, si legge: «manca
il Disegno e la Descrizione di Roma antica », frase
probabilmente apocrifa, aggiunta da alcuno che,
sapendo la promessa dell'autore della lettera, si
trovò deluso nell'aspettativa di trovare il disegno.
Nella lezione di Monaco vi è uno spazio bianco non
riempito; e poi si hanno in carattere più sciolto e
sopra carta più fine alcune altre nozioni generali a
schiarimento de' modi seguiti dall'autore ne' suoi
disegni. Si discorre del disegno fatto in prospet-
tiva di alcuni edifici « acciochè gli occhi possino
vedere et giudicare la grafia di quella similitudine
Che se gli appresenta per la bella proportione et
simetria elei li edificii: il che non apar nel disegno di
quelli che son misurati architecticamente. Perchè
la grossezza dei corpi non si può dimostrare in un
piano, se quelle parti che si hanno da veder più
lontane non diminuischano con proportione se-
condo che l'occhio naturalmente vede... ». Dopo
questa dichiarazione del perchè alcuni edifici si
presentino dall'Autore in prospettiva, segue qual-
che distinzione degli ordini usati dagli antichi:
dorico, ionico, corinzio, toscano, attico. Ma, dopo
brevi definizioni di essi, l'autore par che dica di
voler dare le maggiori spiegazioni a tempo e luogo,
e con Vitruvio alla mano. Tutta questa parte,
forse perchè non portava con sè se non concetti
generali e comuni, fu soppressa dal revisore, dal
letterato, che purificò, nobilitò la forma della prima
lezione.
Certo è che l'intenzione di svolgere i criteri
usati andava forse oltre il necessario. L'Autore
voleva mostrar troppo tutti i ferri del suo mestiere.
In un certo punto, parlando del modo di misurare
gli edifici tondi, si cita, nella, prima lezione, il
terzo libro di Euclide, e il revisore'toglie la cita-
zione, e dice semplicemente:
« i tondi, li quali si misurano in altra maniera;
« come poi si mostrerà a luogo più accomodato ».
Il luogo non è nel seguito della lettera, ma il
revisore doveva sapere che, nel seguito, si sarebbe
trovato. Tale mancanza, come l'altra del disegno
in tutte e due le lezioni, e la mancanza maggiore
dell'opera o della descrizione di Roma antica, che
doveva dar continuazione alle premesse, le quali
formano il testo della prima e della seconda le-
zione, ci persuade che entrambe non rappresen-
tino se non un frammento del grande lavoro, l'ela-
borazione del principio o dei preliminari dell'opera,
alla quale Raffaello attese negli ultimi giorni della
sua vita gloriosa. Il Michiel, scrivendo al Marsilio,
appena morto Raffaello, mostrò di saper bene a
qual punto era giunta la composizione della pianta
di Roma antica; « et già », scriveva, « havea fornita
la prima «regione». Anche Andrea Fulvio dice come
Raffaello, poco tempo prima della sua morte, avesse
segnato col pennello, secondo le sue indicazioni, gli
antichi luoghi di Roma per regioni. E Celio Calca-
gnini discorre della pianta di Roma con gli antichi
edifici in parte ricostruiti, riprodotta dal Principe
di tutti i pittori, secondo l'aspetto vetusto, le loro
proporzioni e il loro ordine; e la ricostruzione, ese-
guita a norma delle descrizioni dei testi classici,
destò tanto l'ammirazione del Pontefice Leone e di
tutti i Romani da far considerare l'artista come
un nume sceso dal cielo a ridarci nell'antica maestà
la città eterna. Celio Calcagnini tornava da Fran-
coforte, dove il protonotario apostolico in Ungheria
si era recato come nunzio all'incoronazione di