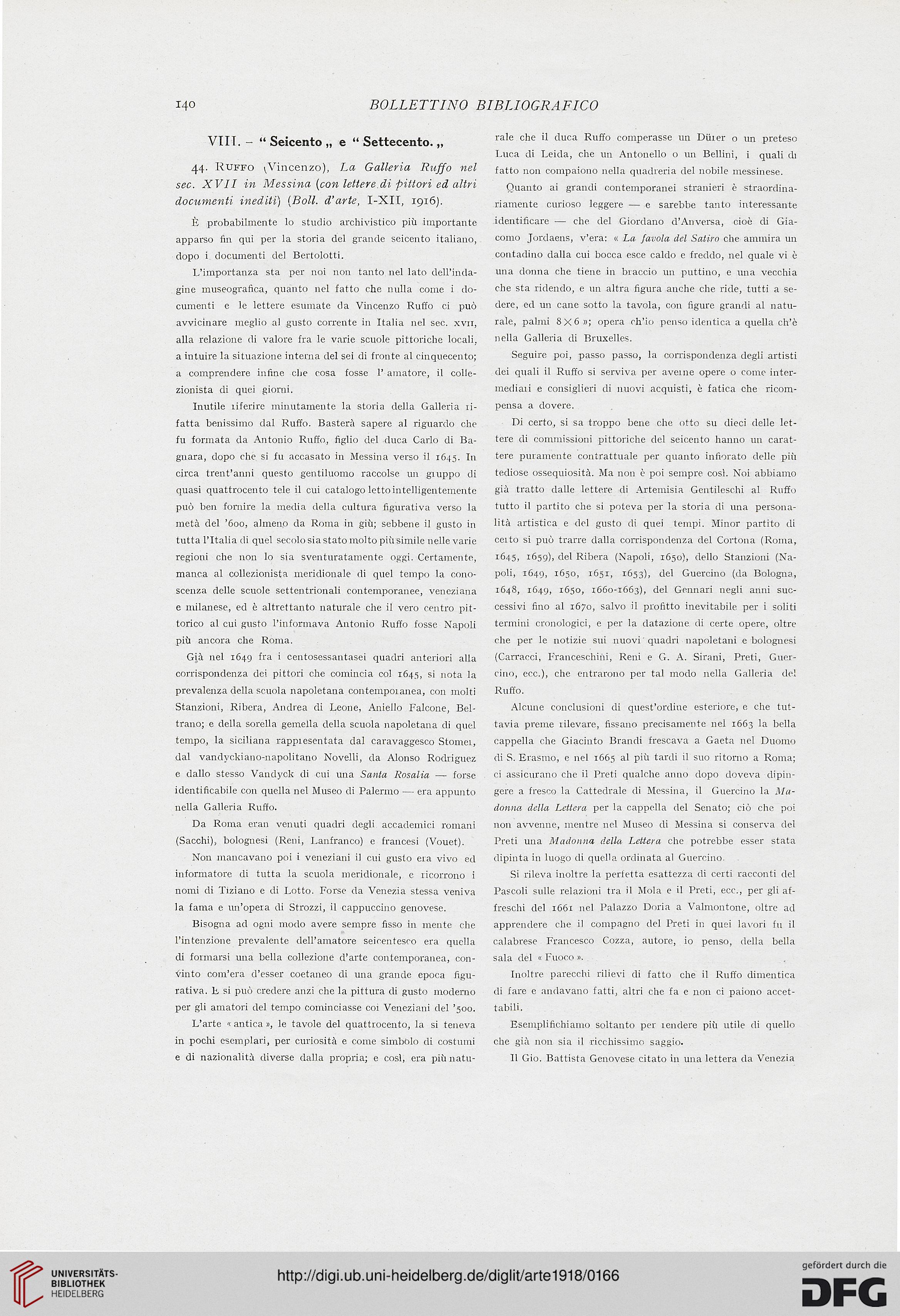140
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
VI IT. - " Seicento „ e " Settecento. „
44. Ruffo (Vincenzo), La Galleria Ruffo nel
sec. XVII in Messina {con lettere.di pittori ed altri
documenti inediti) (Boll, d'arte, I-XIT, 1916).
È probabilmente lo studio archivistico più importante
apparso fin qui per la storia del grande seicento italiano,
dopo i documenti del Bertolotti.
L'importanza sta per noi non tanto nel lato dell'inda-
gine museografica, quanto nel fatto che nulla come i do-
cumenti e le lettere esumate da Vincenzo Ruffo ci può
avvicinare meglio al gusto corrente in Italia nel sec. xvn,
alla relazione di valore fra le varie scuole pittoriche locali,
a intuire la situazione interna del sei di fronte al cinquecento;
a comprendere infine che cosa fosse 1' amatore, il colle-
zionista di quei giorni.
Inutile riferire minutamente la storia della Galleria ri-
fatta benissimo dal Ruffo. Basterà sapere al riguardo che
fu formata da Antonio Ruffo, figlio del duca Carlo di Ba-
guara, dopo che si fu accasato in Messina verso il 1645. In
circa trent'anni questo gentiluomo raccolse un giuppo di
quasi quattrocento tele il cui catalogo letto intelligentemente
può ben fornire la media della cultura figurativa verso la
metà del '600, almeno da Roma in giù; sebbene il gusto in
tutta l'Italia di quel secolo sia stato molto piìi simile nelle varie
regioni che non lo sia sventuratamente oggi. Certamente,
manca al collezionista meridionale di quel tempo la cono-
scenza delle scuole settentrionali contemporanee, veneziana
e milanese, ed è altrettanto naturale che il vero centro pit-
torico al cui gusto l'informava Antonio Ruffo fosse Napoli
più ancora che Roma.
G^à nel 1649 fra i centosessantasei quadri anteriori alla
corrispondenza dei pittori che comincia col 1645, si nota la
prevalenza della scuola napoletana contempoianea, con molti
Stanzioni, Ribera, Andrea di Leone, Aniello Falcone, Bel-
trame;, e della sorella gemella della scuola napoletana di quel
tempo, la siciliana rappresentata dal caravaggesco Stomei,
dal vandyckiano-napolitano Novelli, da Alonso Rodriguez
e dallo stesso Vandyck di cui una Santa Rosalia — forse
identificabile con quella nel Museo di Palermo — era appunto
nella Galleria Ruffo.
Da Roma eran venuti quadri degli accademici romani
(Sacchi), bolognesi (Reni, Lanfranco) e francesi (Vouet).
Non mancavano poi i veneziani il cui gusto era vivo ed
informatore di tutta la scuola meridionale, e ricorrono i
nomi di Tiziano e di Lotto. Forse da Venezia stessa veniva
la fama e un'opera di Strozzi, il cappuccino genovese.
Bisogna ad ogni modo avere sempre fisso in mente che
l'intenzione prevalente dell'amatore seicentesco era quella
di formarsi una bella collezione d'arte contemporanea, con-
vinto com'era d'esser coetaneo di una grande epoca figu-
rativa, li si può credere anzi che la pittura di gusto moderno
per gli amatori del tempo cominciasse coi Veneziani del '500.
L'arte « antica », le tavole del quattrocento, la si teneva
in pochi esemplari, per curiosità e come simbolo di costumi
e di nazionalità diverse dalla propria; e cosi, era più natu-
rale che il duca Ruffo comperasse un Dùier o un preteso
Luca di Leida, che un Antonello o un Bellini, i quali di
fatto non compaiono nella quadreria del nobile messinese.
Quanto ai grandi contemporanei stranieri è straordina-
riamente curioso leggere — e sarebbe tanto interessante
identificare — che del Giordano d'Anversa, cioè di Gia-
como Jordaens, v'era: « La favola del Satiro che ammira un
contadino dalla cui bocca esce caldo e freddo, nel quale vi è
una donna che tiene in braccio un puttino, e una vecchia
che sta ridendo, e un altra figura anche che ride, tutti a se-
dere, ed un cane sotto la tavola, con figure grandi al natu-
rale, palmi 8X6 »; opera ch'io penso identica a quella ch'è
nella Galleria di Bruxelles.
Seguire poi, passo passo, la corrispondenza degli artisti
dei quali il Ruffo si serviva per averne opere o come inter-
mediali e consiglieri di nuovi acquisti, è fatica che ricom-
pensa a dovere.
Di certo, si sa troppo bene che otto su dieci delle let-
tere di commissioni pittoriche del seicento hanno un carat-
tere puramente contrattuale per quanto infiorato delle più
tediose ossequiosità. Ma non è poi sempre cosi. Noi abbiamo
già tratto dalle lettere di Artemisia Gentileschi al Ruffo
tutto il partito che si poteva per la storia di una persona-
lità artistica e del gusto di quei tempi. Minor partito di
ceito si può trarre dalla corrispondenza del Cortona (Roma,
1645, 1659). del Ribera (Napoli, 1650), dello Stanzioni (Na-
poli, 1649, J65o, r6sr, 1653), del Guercino (da Bologna,
1648, rÓ49, 1650, 1660-1663), del Gennari negli anni suc-
cessivi fino al 1670, salvo il profitto inevitabile per i soliti
termini cronologici, e per la datazione di certe opere, oltre
che per le notizie sui nuovi ' quadri napoletani e bolognesi
(Carnicci, Franceschifù, Reni e G. A. Sirani, Preti, Guer-
cino, ecc.), che entrarono per tal modo nella Galleria del
Ruffo.
Alcune conclusioni di quest'ordine esteriore, e che tut-
tavia preme rilevare, fissano precisamente nel 1663 la bella
cappella che Giacinto Brandi trescava a Gaeta nel Duomo
di S. Erasmo, e nel 1665 al più tardi il suo ritorno a Roma;
ci assicurano che il Preti qualche anno dopo doveva dipin-
gere a fresco la Cattedrale di Messina, il Guercino la Ma-
donna della Lettera per la cappella del Senato; ciò che poi
non avvenne, mentre nel Museo di Messina si conserva del
Preti una Madonna della Lettera che potrebbe esser stata
dipinta in luogo di quella ordinata al Guercino.
Si rileva inoltre la perfetta esattezza di certi racconti del
Pascoli sulle relazioni tra il Mola e il Preti, ecc., per gli af-
freschi del r66i nel Palazzo Doria a Valmontone, oltre ad
apprendere che il compagno del Preti in quei lavori fu il
calabrese Francesco Cozza, autore, io penso, della bella
sala del « Fuoco »..
Inoltre parecchi rilievi di fatto che il Ruffo dimentica
di fare e andavano fatti, altri che fa e non ci paiono accet-
tabili.
Esemplifichiamo soltanto per rendere più utile di quello
che già non sia il ricchissimo saggio.
11 Gio. Battista Genovese citato in una lettera da Venezia
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
VI IT. - " Seicento „ e " Settecento. „
44. Ruffo (Vincenzo), La Galleria Ruffo nel
sec. XVII in Messina {con lettere.di pittori ed altri
documenti inediti) (Boll, d'arte, I-XIT, 1916).
È probabilmente lo studio archivistico più importante
apparso fin qui per la storia del grande seicento italiano,
dopo i documenti del Bertolotti.
L'importanza sta per noi non tanto nel lato dell'inda-
gine museografica, quanto nel fatto che nulla come i do-
cumenti e le lettere esumate da Vincenzo Ruffo ci può
avvicinare meglio al gusto corrente in Italia nel sec. xvn,
alla relazione di valore fra le varie scuole pittoriche locali,
a intuire la situazione interna del sei di fronte al cinquecento;
a comprendere infine che cosa fosse 1' amatore, il colle-
zionista di quei giorni.
Inutile riferire minutamente la storia della Galleria ri-
fatta benissimo dal Ruffo. Basterà sapere al riguardo che
fu formata da Antonio Ruffo, figlio del duca Carlo di Ba-
guara, dopo che si fu accasato in Messina verso il 1645. In
circa trent'anni questo gentiluomo raccolse un giuppo di
quasi quattrocento tele il cui catalogo letto intelligentemente
può ben fornire la media della cultura figurativa verso la
metà del '600, almeno da Roma in giù; sebbene il gusto in
tutta l'Italia di quel secolo sia stato molto piìi simile nelle varie
regioni che non lo sia sventuratamente oggi. Certamente,
manca al collezionista meridionale di quel tempo la cono-
scenza delle scuole settentrionali contemporanee, veneziana
e milanese, ed è altrettanto naturale che il vero centro pit-
torico al cui gusto l'informava Antonio Ruffo fosse Napoli
più ancora che Roma.
G^à nel 1649 fra i centosessantasei quadri anteriori alla
corrispondenza dei pittori che comincia col 1645, si nota la
prevalenza della scuola napoletana contempoianea, con molti
Stanzioni, Ribera, Andrea di Leone, Aniello Falcone, Bel-
trame;, e della sorella gemella della scuola napoletana di quel
tempo, la siciliana rappresentata dal caravaggesco Stomei,
dal vandyckiano-napolitano Novelli, da Alonso Rodriguez
e dallo stesso Vandyck di cui una Santa Rosalia — forse
identificabile con quella nel Museo di Palermo — era appunto
nella Galleria Ruffo.
Da Roma eran venuti quadri degli accademici romani
(Sacchi), bolognesi (Reni, Lanfranco) e francesi (Vouet).
Non mancavano poi i veneziani il cui gusto era vivo ed
informatore di tutta la scuola meridionale, e ricorrono i
nomi di Tiziano e di Lotto. Forse da Venezia stessa veniva
la fama e un'opera di Strozzi, il cappuccino genovese.
Bisogna ad ogni modo avere sempre fisso in mente che
l'intenzione prevalente dell'amatore seicentesco era quella
di formarsi una bella collezione d'arte contemporanea, con-
vinto com'era d'esser coetaneo di una grande epoca figu-
rativa, li si può credere anzi che la pittura di gusto moderno
per gli amatori del tempo cominciasse coi Veneziani del '500.
L'arte « antica », le tavole del quattrocento, la si teneva
in pochi esemplari, per curiosità e come simbolo di costumi
e di nazionalità diverse dalla propria; e cosi, era più natu-
rale che il duca Ruffo comperasse un Dùier o un preteso
Luca di Leida, che un Antonello o un Bellini, i quali di
fatto non compaiono nella quadreria del nobile messinese.
Quanto ai grandi contemporanei stranieri è straordina-
riamente curioso leggere — e sarebbe tanto interessante
identificare — che del Giordano d'Anversa, cioè di Gia-
como Jordaens, v'era: « La favola del Satiro che ammira un
contadino dalla cui bocca esce caldo e freddo, nel quale vi è
una donna che tiene in braccio un puttino, e una vecchia
che sta ridendo, e un altra figura anche che ride, tutti a se-
dere, ed un cane sotto la tavola, con figure grandi al natu-
rale, palmi 8X6 »; opera ch'io penso identica a quella ch'è
nella Galleria di Bruxelles.
Seguire poi, passo passo, la corrispondenza degli artisti
dei quali il Ruffo si serviva per averne opere o come inter-
mediali e consiglieri di nuovi acquisti, è fatica che ricom-
pensa a dovere.
Di certo, si sa troppo bene che otto su dieci delle let-
tere di commissioni pittoriche del seicento hanno un carat-
tere puramente contrattuale per quanto infiorato delle più
tediose ossequiosità. Ma non è poi sempre cosi. Noi abbiamo
già tratto dalle lettere di Artemisia Gentileschi al Ruffo
tutto il partito che si poteva per la storia di una persona-
lità artistica e del gusto di quei tempi. Minor partito di
ceito si può trarre dalla corrispondenza del Cortona (Roma,
1645, 1659). del Ribera (Napoli, 1650), dello Stanzioni (Na-
poli, 1649, J65o, r6sr, 1653), del Guercino (da Bologna,
1648, rÓ49, 1650, 1660-1663), del Gennari negli anni suc-
cessivi fino al 1670, salvo il profitto inevitabile per i soliti
termini cronologici, e per la datazione di certe opere, oltre
che per le notizie sui nuovi ' quadri napoletani e bolognesi
(Carnicci, Franceschifù, Reni e G. A. Sirani, Preti, Guer-
cino, ecc.), che entrarono per tal modo nella Galleria del
Ruffo.
Alcune conclusioni di quest'ordine esteriore, e che tut-
tavia preme rilevare, fissano precisamente nel 1663 la bella
cappella che Giacinto Brandi trescava a Gaeta nel Duomo
di S. Erasmo, e nel 1665 al più tardi il suo ritorno a Roma;
ci assicurano che il Preti qualche anno dopo doveva dipin-
gere a fresco la Cattedrale di Messina, il Guercino la Ma-
donna della Lettera per la cappella del Senato; ciò che poi
non avvenne, mentre nel Museo di Messina si conserva del
Preti una Madonna della Lettera che potrebbe esser stata
dipinta in luogo di quella ordinata al Guercino.
Si rileva inoltre la perfetta esattezza di certi racconti del
Pascoli sulle relazioni tra il Mola e il Preti, ecc., per gli af-
freschi del r66i nel Palazzo Doria a Valmontone, oltre ad
apprendere che il compagno del Preti in quei lavori fu il
calabrese Francesco Cozza, autore, io penso, della bella
sala del « Fuoco »..
Inoltre parecchi rilievi di fatto che il Ruffo dimentica
di fare e andavano fatti, altri che fa e non ci paiono accet-
tabili.
Esemplifichiamo soltanto per rendere più utile di quello
che già non sia il ricchissimo saggio.
11 Gio. Battista Genovese citato in una lettera da Venezia