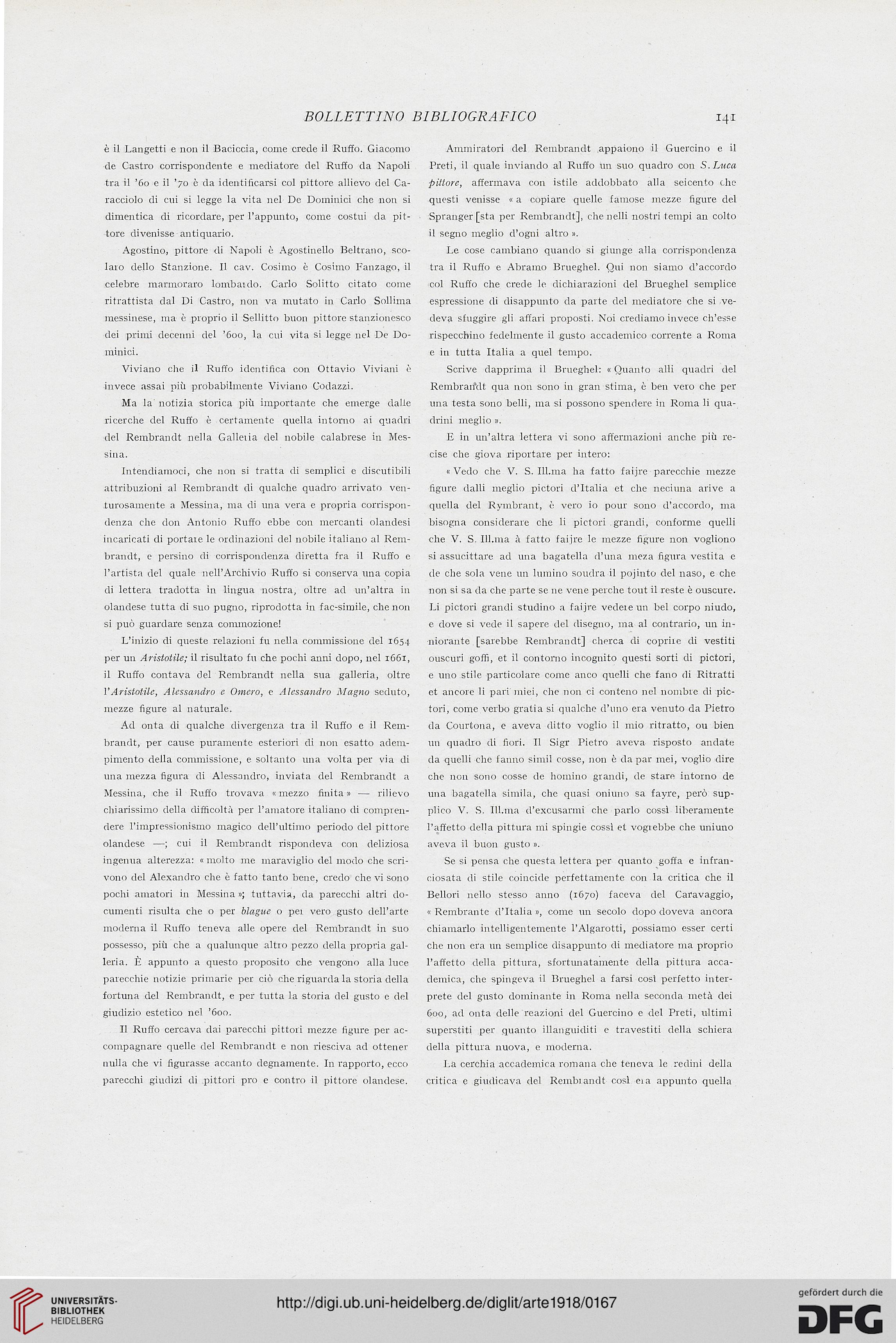BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
141
è il Langetti e non il Baciccia, come crede il Ruffo. Giacomo
de Castro corrispondente e mediatore del Ruffo da Napoli
tra il '6o e il '70 è da identificarsi col pittore allievo del Ca-
racciolo di cui si legge la vita nel De Dominici che non si
dimentica di ricordare, per l'appunto, come costui da pit-
tore divenisse antiquario.
Agostino, pittore di Napoli è Agostinello Beltrano, sco-
laro dello Stanzione. Il cav. Cosimo è Cosimo Fanzago, il
celebre marmoraro lombaulo. Carlo Solitto citato come
ritrattista dal Di Castro, non va mutato in Carlo Sollima
messinese, ma è proprio il Sellitto buon pittore stanzionesco
dei primi decenni del '600, la cui vita sì legge nel De Do-
minici.
Viviano che il Ruffo identifica con Ottavio Viviani è
invece assai più probabilmente Viviano Codazzi.
Ma la notizia storica più importante che emerge dalie
ricerche del Ruffo è certamente quella intorno ai quadri
del Rembrandt nella Galleria del nobile calabrese in Mes-
sina.
Intendiamoci, che non si tratta di semplici e discutibili
attribuzioni al Rembrandt di qualche quadro arrivato ven-
turosamente a Messina, ma di una vera e propria corrispon-
denza che don Antonio Ruffo ebbe con mercanti olandesi
incaricati di portate le ordinazioni del nobile italiano al Rem-
brandt, e persino di corrispondenza diretta fra il Ruffo e
l'artista del quale nell'Archivio Ruffo si conserva una copia
di lettera tradotta in lingua nostra, oltre ad un'altra in
olandese tutta di suo pugno, riprodotta in fac-simile, che non
si può guardare senza commozione!
L'inizio di queste relazioni fu nella commissione del 1654
per un Aristotile; il risultato fu che pochi anni dopo, nel 1661,
il Ruffo contava del Rembrandt nella sua galleria, oltre
VAristotile, Alessandro e Omero, e Alessandro Magno seduto,
mezze figure al naturale.
Ad onta di qualche divergenza tra il Ruffo e il Rem-
brandt, per cause puramente esteriori di non esatto adem-
pimento della commissione, e soltanto una volta per via di
una mezza figura di Alessandro, inviata del Rembrandt a
Messina, che il Ruffo trovava "mezzo finita» — rilievo
chiarissimo della difficoltà per l'amatore italiano di compren-
dere rimpressionismo magico dell'ultimo periodo del pittore
olandese —; cui il Rembrandt rispondeva con deliziosa
ingenua alterezza: « molto me maraviglio del modo che scri-
vono del Alex and 1*0 che è fatto tanto bene, credo che vi sono
pochi amatori in Messina »; tuttavia, da parecchi altri do-
cumenti risulta che o per blague o pei vero gusto dell'arte
moderna il Ruffo teneva alle opere del Rembrandt in suo
possesso, più che a qualunque altro pezzo della propria gal-
leria. È appunto a questo proposito che vengono alla luce
parecchie notizie primarie per ciò che riguarda la storia della
fortuna del Rembrandt, e per tutta la storia del gusto e del
giudizio estetico nel '600.
Il Ruffo cercava dai parecchi pittori mezze figure per ac-
compagnare quelle del Rembrandt e non riesciva ad ottener
nulla che vi figurasse accanto degnamente. In rapporto, ecco
parecchi giudizi di pittori prò e contro il pittore olandese.
Ammiratori del Rembrandt appaiono il Quercino e il
Preti, il quale inviando al Ruffo un suo quadro con S.Luca
pittore, affermava con istile addobbato alla seicento che
questi venisse « a copiare quelle famose mezze figure del
Spranger[sta per Rembrandt], che nelli nostri tempi an colto
il segno meglio d'ogni altro ».
Le cose cambiano quando si giunge alla corrispondenza
tra il Ruffo e Abramo Brueghel. Qui non siamo d'accordo
col Ruffo che crede le dichiarazioni del Brueghel semplice
espressione di disappunto da parte del mediatore che si ve-
deva sfuggire gli affari proposti. Noi crediamo invece ch'esse
rispecchino fedelmente il gusto accademico corrente a Roma
e in tutta Italia a quel tempo.
Scrive dapprima il Brueghel: « Quanto alli quadri del
RembranYlt qua non sono in gran stima, è ben vero che per
una testa sono belli, ma si possono spendere in Roma li qua-
drini meglio ».
E in un'altra lettera vi sono affermazioni anche più re-
cise che giova riportare per intero:
« Vedo che V. S. 111.ma ha fatto faijre parecchie mezze
figure dalli meglio pi et ori d'Italia et che ucci una arive a
quella del Rymbrant, è vero io pour sono d'accordo, ma
bisogna considerare che li pie-tori grandi, conforme quelli
che V. S, 111.ma à fatto faijre le mezze figure non vogliono
si assucittare ad una bagatella d'una meza figura vestita e
de che sola vene un lumino soudra il pojinto del naso, e che
non si sa da che parte se ne vene perche tout il reste è ouscure.
Li pictori grandi studino a faijre vedeie un bel corpo nitido,
e dove si vede il sapere del disegno, ma al contrario, un in-
■niorante [sarebbe Rembrandt] cherca di coprire di vestiti
ouscuri goffi, et il contorno incognito questi sorti di pictori,
e uno stile particolare come anco quelli che fano di Ritratti
et ancore li pari miei, che non ci conteuo nel nombie di pic-
tori, come verbo gratta si qualche d'uno era venuto da Pietro
da Courtona, e aveva ditto voglio il mio ritratto, ou bien
uri quadro di fiori. Il Sigr Pietro aveva risposto andate
da quelli che fanno simil cosse, non è da par mei, voglio dire
che non sono cosse de nomino grandi, de stare intorno de
una bagatella simila, che quasi oniuno sa fayre, però sup-
plico V. S. 111.ma d'excusarmi che parlo cossi liberamente
l'affetto della pittura mi spingie cossi et vogiebbe che uniuno
aveva il buon gusto ».
Se si pensa che questa lettera per quanto goffa e infran-
ciosata di stile coincide perfettamente con la critica che il
Bellori nello stesso anno (1670) faceva del Caravaggio,
« Rembrante d'Italia », come un secolo dopo doveva ancora
chiamarlo intelligentemente l'Algarotti, possiamo esser certi
che non era un semplice disappunto di mediatore ma proprio
l'affetto della pittura, sfortunatamente della pittura acca-
demica, che spingeva il Brueghel a farsi così perfetto inter-
prete del gusto dominante in Roma nella seconda metà dei
600, ad onta delle reazioni del Guercino e del Preti, ultimi
superstiti per quanto illanguiditi e travestiti della schiera
della pittura nuova, e moderna.
La cerchia accademica romana che teneva le redini della
critica e giudicava del Rembiandt così eia appunto quella
141
è il Langetti e non il Baciccia, come crede il Ruffo. Giacomo
de Castro corrispondente e mediatore del Ruffo da Napoli
tra il '6o e il '70 è da identificarsi col pittore allievo del Ca-
racciolo di cui si legge la vita nel De Dominici che non si
dimentica di ricordare, per l'appunto, come costui da pit-
tore divenisse antiquario.
Agostino, pittore di Napoli è Agostinello Beltrano, sco-
laro dello Stanzione. Il cav. Cosimo è Cosimo Fanzago, il
celebre marmoraro lombaulo. Carlo Solitto citato come
ritrattista dal Di Castro, non va mutato in Carlo Sollima
messinese, ma è proprio il Sellitto buon pittore stanzionesco
dei primi decenni del '600, la cui vita sì legge nel De Do-
minici.
Viviano che il Ruffo identifica con Ottavio Viviani è
invece assai più probabilmente Viviano Codazzi.
Ma la notizia storica più importante che emerge dalie
ricerche del Ruffo è certamente quella intorno ai quadri
del Rembrandt nella Galleria del nobile calabrese in Mes-
sina.
Intendiamoci, che non si tratta di semplici e discutibili
attribuzioni al Rembrandt di qualche quadro arrivato ven-
turosamente a Messina, ma di una vera e propria corrispon-
denza che don Antonio Ruffo ebbe con mercanti olandesi
incaricati di portate le ordinazioni del nobile italiano al Rem-
brandt, e persino di corrispondenza diretta fra il Ruffo e
l'artista del quale nell'Archivio Ruffo si conserva una copia
di lettera tradotta in lingua nostra, oltre ad un'altra in
olandese tutta di suo pugno, riprodotta in fac-simile, che non
si può guardare senza commozione!
L'inizio di queste relazioni fu nella commissione del 1654
per un Aristotile; il risultato fu che pochi anni dopo, nel 1661,
il Ruffo contava del Rembrandt nella sua galleria, oltre
VAristotile, Alessandro e Omero, e Alessandro Magno seduto,
mezze figure al naturale.
Ad onta di qualche divergenza tra il Ruffo e il Rem-
brandt, per cause puramente esteriori di non esatto adem-
pimento della commissione, e soltanto una volta per via di
una mezza figura di Alessandro, inviata del Rembrandt a
Messina, che il Ruffo trovava "mezzo finita» — rilievo
chiarissimo della difficoltà per l'amatore italiano di compren-
dere rimpressionismo magico dell'ultimo periodo del pittore
olandese —; cui il Rembrandt rispondeva con deliziosa
ingenua alterezza: « molto me maraviglio del modo che scri-
vono del Alex and 1*0 che è fatto tanto bene, credo che vi sono
pochi amatori in Messina »; tuttavia, da parecchi altri do-
cumenti risulta che o per blague o pei vero gusto dell'arte
moderna il Ruffo teneva alle opere del Rembrandt in suo
possesso, più che a qualunque altro pezzo della propria gal-
leria. È appunto a questo proposito che vengono alla luce
parecchie notizie primarie per ciò che riguarda la storia della
fortuna del Rembrandt, e per tutta la storia del gusto e del
giudizio estetico nel '600.
Il Ruffo cercava dai parecchi pittori mezze figure per ac-
compagnare quelle del Rembrandt e non riesciva ad ottener
nulla che vi figurasse accanto degnamente. In rapporto, ecco
parecchi giudizi di pittori prò e contro il pittore olandese.
Ammiratori del Rembrandt appaiono il Quercino e il
Preti, il quale inviando al Ruffo un suo quadro con S.Luca
pittore, affermava con istile addobbato alla seicento che
questi venisse « a copiare quelle famose mezze figure del
Spranger[sta per Rembrandt], che nelli nostri tempi an colto
il segno meglio d'ogni altro ».
Le cose cambiano quando si giunge alla corrispondenza
tra il Ruffo e Abramo Brueghel. Qui non siamo d'accordo
col Ruffo che crede le dichiarazioni del Brueghel semplice
espressione di disappunto da parte del mediatore che si ve-
deva sfuggire gli affari proposti. Noi crediamo invece ch'esse
rispecchino fedelmente il gusto accademico corrente a Roma
e in tutta Italia a quel tempo.
Scrive dapprima il Brueghel: « Quanto alli quadri del
RembranYlt qua non sono in gran stima, è ben vero che per
una testa sono belli, ma si possono spendere in Roma li qua-
drini meglio ».
E in un'altra lettera vi sono affermazioni anche più re-
cise che giova riportare per intero:
« Vedo che V. S. 111.ma ha fatto faijre parecchie mezze
figure dalli meglio pi et ori d'Italia et che ucci una arive a
quella del Rymbrant, è vero io pour sono d'accordo, ma
bisogna considerare che li pie-tori grandi, conforme quelli
che V. S, 111.ma à fatto faijre le mezze figure non vogliono
si assucittare ad una bagatella d'una meza figura vestita e
de che sola vene un lumino soudra il pojinto del naso, e che
non si sa da che parte se ne vene perche tout il reste è ouscure.
Li pictori grandi studino a faijre vedeie un bel corpo nitido,
e dove si vede il sapere del disegno, ma al contrario, un in-
■niorante [sarebbe Rembrandt] cherca di coprire di vestiti
ouscuri goffi, et il contorno incognito questi sorti di pictori,
e uno stile particolare come anco quelli che fano di Ritratti
et ancore li pari miei, che non ci conteuo nel nombie di pic-
tori, come verbo gratta si qualche d'uno era venuto da Pietro
da Courtona, e aveva ditto voglio il mio ritratto, ou bien
uri quadro di fiori. Il Sigr Pietro aveva risposto andate
da quelli che fanno simil cosse, non è da par mei, voglio dire
che non sono cosse de nomino grandi, de stare intorno de
una bagatella simila, che quasi oniuno sa fayre, però sup-
plico V. S. 111.ma d'excusarmi che parlo cossi liberamente
l'affetto della pittura mi spingie cossi et vogiebbe che uniuno
aveva il buon gusto ».
Se si pensa che questa lettera per quanto goffa e infran-
ciosata di stile coincide perfettamente con la critica che il
Bellori nello stesso anno (1670) faceva del Caravaggio,
« Rembrante d'Italia », come un secolo dopo doveva ancora
chiamarlo intelligentemente l'Algarotti, possiamo esser certi
che non era un semplice disappunto di mediatore ma proprio
l'affetto della pittura, sfortunatamente della pittura acca-
demica, che spingeva il Brueghel a farsi così perfetto inter-
prete del gusto dominante in Roma nella seconda metà dei
600, ad onta delle reazioni del Guercino e del Preti, ultimi
superstiti per quanto illanguiditi e travestiti della schiera
della pittura nuova, e moderna.
La cerchia accademica romana che teneva le redini della
critica e giudicava del Rembiandt così eia appunto quella