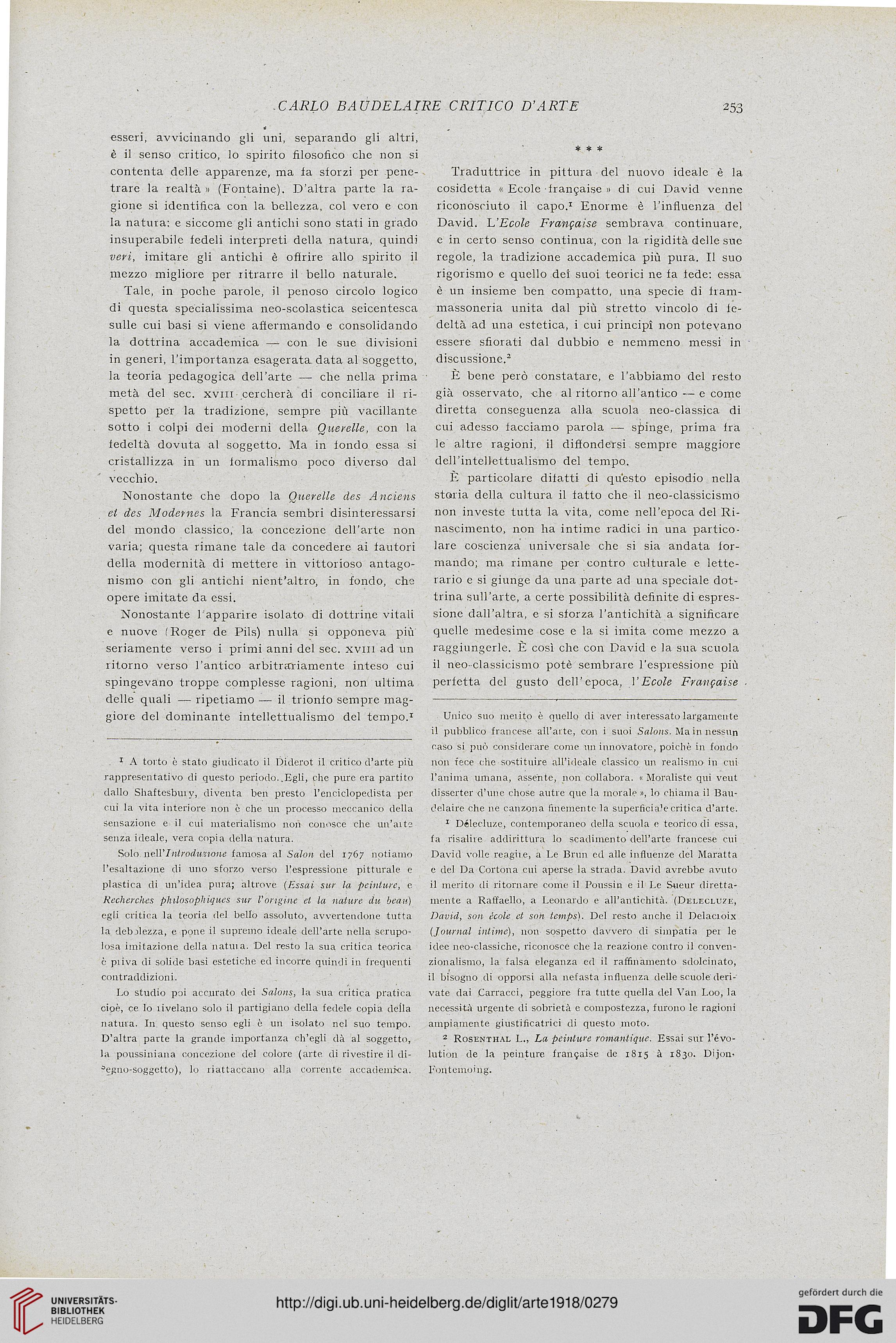CARLO BAUDELAI
esseri, avvicinando gli uni, separando gli altri,
è il senso critico, lo spirito filosofico che non si
contenta delle apparenze, ma fa sforzi per pene-
trare la realtà » (Fontaine). D'altra parte la ra-
gione si identifica con la bellezza, col vero e con
la natura: e siccome gli antichi sono stati in grado
insuperabile fedeli interpreti della natura, quindi
veri, imitare gli antichi è offrire allo spirito il
mezzo migliore per ritrarre il bello naturale.
Tale, in poche parole, il penoso circolo logico
di questa specialissima neo-scolastica seicentesca
sulle cui basi si viene affermando e consolidando
la dottrina accademica — con le sue divisioni
in generi, l'importanza esagerata data al soggetto,
la teoria pedagogica dell'arte — che nella prima
metà del sec. xvm cercherà di conciliare il ri-
spetto per la tradizione, sempre più vacillante
sotto i colpi dei moderni della Querelle, con la
fedeltà dovuta al soggetto. Ma in londo essa si
cristallizza in un formalismo poco diverso dal
vecchio.
Nonostante che dopo la Querelle des Ancicns
et des Modernes la Francia sembri disinteressarsi
del mondo classico, la concezione dell'arte non
varia; questa rimane tale da concedere ai fautori
della modernità di mettere in vittorioso antago-
nismo con gli antichi nient'altro, in fondo, che
opere imitate da essi.
Nonostante l'apparire isolato di dottrine vitali
e nuove (Roger de Pils) nulla si opponeva più
seriamente verso i primi anni del sec. xvm ad un
ritorno verso l'antico arbitrariamente inteso cui
spingevano troppe complesse ragioni, non ultima
delle quali — ripetiamo — il trionfo sempre mag-
giore del dominante intellettualismo del tempo.1
1 A torto è stato giudicato il Diderot il critico d'arte più
rappresentativo di questo periodo..Egli, che pure era partito
dallo Shaftesbury, diventa ben presto l'enciclopedista per
cui la vita interiore non è che un processo meccanico della
sensazione e il cui materialismo non conosce che un'aite
senza ideale, vera copia della natura.
So\o nell'Introduzione famosa al Salon del 1767 notiamo
l'esaltazione di uno sforzo verso l'espressione pitturale e
plastica di un'idea pura; altrove (Essai sur la peinture, e
Recherches philosopkiques sur l'origine et la nature du beau)
egli critica la teoria del bello assoluto, avvertendone tutta
la debolezza, e pone il supremo ideale dell'arte nella scrupo-
losa imitazione della natura. Del resto la sua critica teorica
è piiva di solide basi estetiche ed incorre quindi in frequenti
contraddizioni.
Lo studio poi accurato dei Salons, la sua critica pratica
cioè, ce lo livelano solo il partigiano della fedele copia della
natura. In questo senso egli è un isolato nel suo tempo.
D'altra parte la grande importanza ch'egli dà al soggetto,
la poussiniana concezione del colore (arte di rivestire il di-
segno-soggetto), lo riattaccano alla corrente accademica.
E CRITICO D'ARTE 253
* * *
Traduttrice in pittura del nuovo ideale è la
cosidetta « Ecole irancaisc » di cui David venne
riconósciuto il capo.1 Enorme è l'influenza del
David. L'Ecole Frangaise sembrava continuare,
c in certo senso continua, con la rigidità delle sue
regole, la tradizione accademica più pura, fi suo
rigorismo e quello dei suoi teorici ne fa lede: essa
è un insieme ben compatto, una specie di fram-
massoneria unita dal più stretto vincolo di fe-
deltà ad una estetica, i cui principi non potevano
essere sfiorati dal dubbio e nemmeno messi in
discussione.2
E bene però constatare, c l'abbiamo del resto
già osservato, che al ritorno all'antico — e come
diretta conseguenza alla scuola neo-classica di
cui adesso facciamo parola — spinge, prima fra
le altre ragioni, il diffondersi sempre maggiore
dell'intellettualismo del tempo.
E particolare difatti di questo episodio nella
storia della cultura il latto che il neo-classicismo
non investe tutta la vita, come nell'epoca del Ri-
nascimento, non ha intime radici in una partico-
lare coscienza universale che si sia andata (or-
mando; ma rimane per contro culturale e lette-
rario e si giunge da una parte ad una speciale dot-
trina sull'arte, a certe possibilità definite di espres-
sione dall'altra, e si sforza l'antichità a significare
quelle medesime cose e la si imita come mezzo a
raggiungerle. E così che con David e la sua scuola
il neo-classicismo potè sembrare l'espressione più
perfetta del gusto dell'epoca, V Ecole Fraticaise
Unico suo meritò è quello di aver interessato largamente
il pubblico francese all'arte, con i suoi Salons. Ma in nessun
caso si può considerare come un innovatore, poiché in fondo
non fece che sostituire all'ideale classico un realismo in cui
l'anima umana, assente, non collabora. « Moraliste qui veut
disserter d'une chose autre que la morale », lo chiama il Bau-
delaire che ne canzona finemente la superficiale critica d'arte.
1 Délecluze, contemporaneo della scuola e teorico di essa,
fa risalire addirittura lo scadimento dell'arte francese cui
David volle reagir e, a Le Bruii ed alle influenze del Maratta
e del Da Cortona cui aperse la strada. David avrebbe avuto
il merito ili ritornare come il Poussin e il Le Sueur diretta-
mente a Raffaello, a Leonardo e all'antichità. (Délecluze,
David, son école et son temps). Del resto anche il Delacioix
(Journal intime), non sospetto davvero di simpatia per le
idee neo-classiche, riconosce che la reazione contro il conven-
zionalismo, la falsa eleganza ed il raffinamento sdolcinato,
il bisogno di opporsi alla nefasta influenza delle scuole'deri-
vate dai Carracci, peggiore fra tutte quella del Van Loo, la
necessità urgente di sobrietà e compostezza, furono le ragioni
ampiamente giustificatrici di questo moto.
2 Rosenthal L., La peinture romantique. Essai sur l'évo-
lution de la peinture francaise de 1815 à 1830. Dijon-
l'ontenioing.
esseri, avvicinando gli uni, separando gli altri,
è il senso critico, lo spirito filosofico che non si
contenta delle apparenze, ma fa sforzi per pene-
trare la realtà » (Fontaine). D'altra parte la ra-
gione si identifica con la bellezza, col vero e con
la natura: e siccome gli antichi sono stati in grado
insuperabile fedeli interpreti della natura, quindi
veri, imitare gli antichi è offrire allo spirito il
mezzo migliore per ritrarre il bello naturale.
Tale, in poche parole, il penoso circolo logico
di questa specialissima neo-scolastica seicentesca
sulle cui basi si viene affermando e consolidando
la dottrina accademica — con le sue divisioni
in generi, l'importanza esagerata data al soggetto,
la teoria pedagogica dell'arte — che nella prima
metà del sec. xvm cercherà di conciliare il ri-
spetto per la tradizione, sempre più vacillante
sotto i colpi dei moderni della Querelle, con la
fedeltà dovuta al soggetto. Ma in londo essa si
cristallizza in un formalismo poco diverso dal
vecchio.
Nonostante che dopo la Querelle des Ancicns
et des Modernes la Francia sembri disinteressarsi
del mondo classico, la concezione dell'arte non
varia; questa rimane tale da concedere ai fautori
della modernità di mettere in vittorioso antago-
nismo con gli antichi nient'altro, in fondo, che
opere imitate da essi.
Nonostante l'apparire isolato di dottrine vitali
e nuove (Roger de Pils) nulla si opponeva più
seriamente verso i primi anni del sec. xvm ad un
ritorno verso l'antico arbitrariamente inteso cui
spingevano troppe complesse ragioni, non ultima
delle quali — ripetiamo — il trionfo sempre mag-
giore del dominante intellettualismo del tempo.1
1 A torto è stato giudicato il Diderot il critico d'arte più
rappresentativo di questo periodo..Egli, che pure era partito
dallo Shaftesbury, diventa ben presto l'enciclopedista per
cui la vita interiore non è che un processo meccanico della
sensazione e il cui materialismo non conosce che un'aite
senza ideale, vera copia della natura.
So\o nell'Introduzione famosa al Salon del 1767 notiamo
l'esaltazione di uno sforzo verso l'espressione pitturale e
plastica di un'idea pura; altrove (Essai sur la peinture, e
Recherches philosopkiques sur l'origine et la nature du beau)
egli critica la teoria del bello assoluto, avvertendone tutta
la debolezza, e pone il supremo ideale dell'arte nella scrupo-
losa imitazione della natura. Del resto la sua critica teorica
è piiva di solide basi estetiche ed incorre quindi in frequenti
contraddizioni.
Lo studio poi accurato dei Salons, la sua critica pratica
cioè, ce lo livelano solo il partigiano della fedele copia della
natura. In questo senso egli è un isolato nel suo tempo.
D'altra parte la grande importanza ch'egli dà al soggetto,
la poussiniana concezione del colore (arte di rivestire il di-
segno-soggetto), lo riattaccano alla corrente accademica.
E CRITICO D'ARTE 253
* * *
Traduttrice in pittura del nuovo ideale è la
cosidetta « Ecole irancaisc » di cui David venne
riconósciuto il capo.1 Enorme è l'influenza del
David. L'Ecole Frangaise sembrava continuare,
c in certo senso continua, con la rigidità delle sue
regole, la tradizione accademica più pura, fi suo
rigorismo e quello dei suoi teorici ne fa lede: essa
è un insieme ben compatto, una specie di fram-
massoneria unita dal più stretto vincolo di fe-
deltà ad una estetica, i cui principi non potevano
essere sfiorati dal dubbio e nemmeno messi in
discussione.2
E bene però constatare, c l'abbiamo del resto
già osservato, che al ritorno all'antico — e come
diretta conseguenza alla scuola neo-classica di
cui adesso facciamo parola — spinge, prima fra
le altre ragioni, il diffondersi sempre maggiore
dell'intellettualismo del tempo.
E particolare difatti di questo episodio nella
storia della cultura il latto che il neo-classicismo
non investe tutta la vita, come nell'epoca del Ri-
nascimento, non ha intime radici in una partico-
lare coscienza universale che si sia andata (or-
mando; ma rimane per contro culturale e lette-
rario e si giunge da una parte ad una speciale dot-
trina sull'arte, a certe possibilità definite di espres-
sione dall'altra, e si sforza l'antichità a significare
quelle medesime cose e la si imita come mezzo a
raggiungerle. E così che con David e la sua scuola
il neo-classicismo potè sembrare l'espressione più
perfetta del gusto dell'epoca, V Ecole Fraticaise
Unico suo meritò è quello di aver interessato largamente
il pubblico francese all'arte, con i suoi Salons. Ma in nessun
caso si può considerare come un innovatore, poiché in fondo
non fece che sostituire all'ideale classico un realismo in cui
l'anima umana, assente, non collabora. « Moraliste qui veut
disserter d'une chose autre que la morale », lo chiama il Bau-
delaire che ne canzona finemente la superficiale critica d'arte.
1 Délecluze, contemporaneo della scuola e teorico di essa,
fa risalire addirittura lo scadimento dell'arte francese cui
David volle reagir e, a Le Bruii ed alle influenze del Maratta
e del Da Cortona cui aperse la strada. David avrebbe avuto
il merito ili ritornare come il Poussin e il Le Sueur diretta-
mente a Raffaello, a Leonardo e all'antichità. (Délecluze,
David, son école et son temps). Del resto anche il Delacioix
(Journal intime), non sospetto davvero di simpatia per le
idee neo-classiche, riconosce che la reazione contro il conven-
zionalismo, la falsa eleganza ed il raffinamento sdolcinato,
il bisogno di opporsi alla nefasta influenza delle scuole'deri-
vate dai Carracci, peggiore fra tutte quella del Van Loo, la
necessità urgente di sobrietà e compostezza, furono le ragioni
ampiamente giustificatrici di questo moto.
2 Rosenthal L., La peinture romantique. Essai sur l'évo-
lution de la peinture francaise de 1815 à 1830. Dijon-
l'ontenioing.