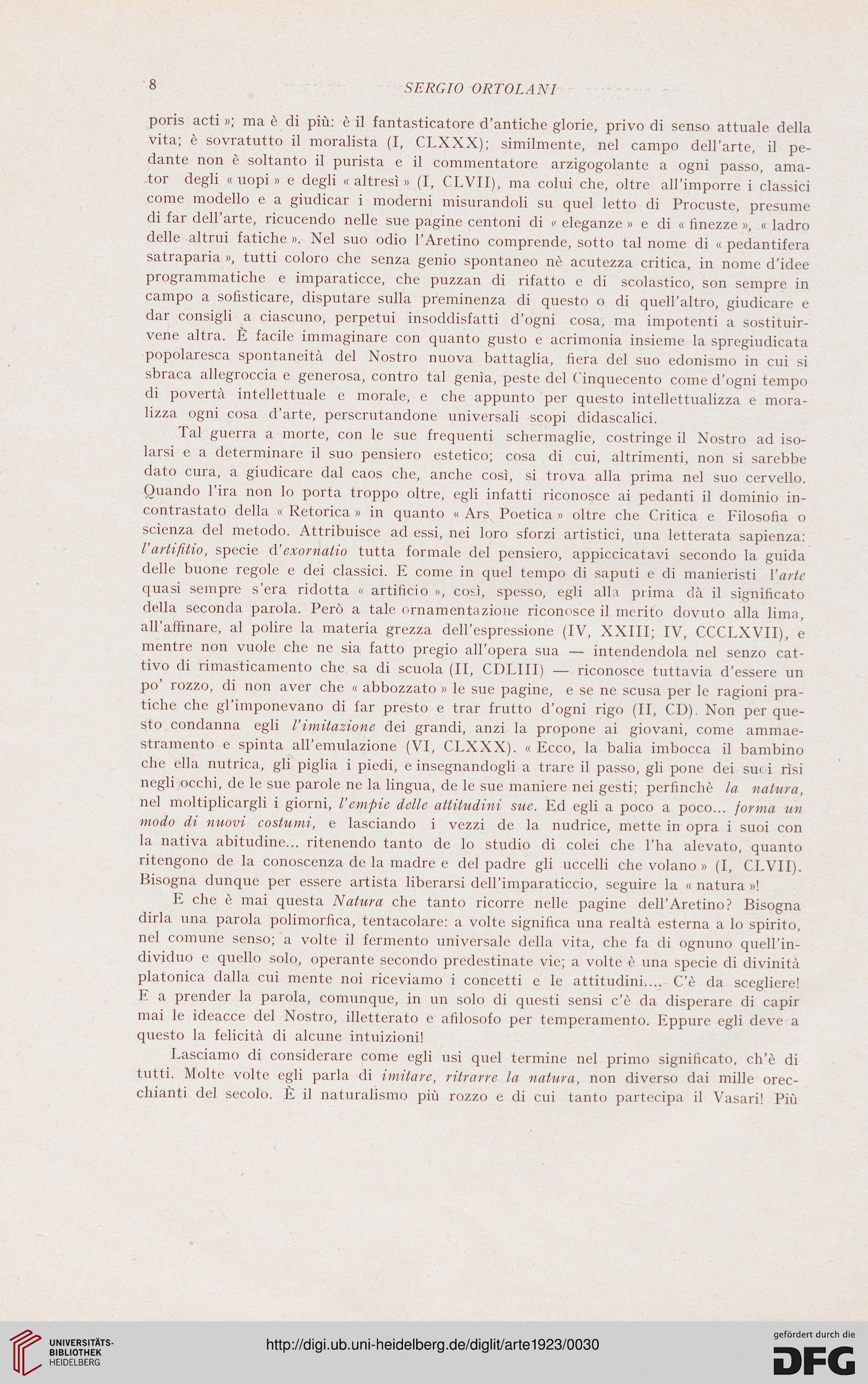8
SERGIO ORTOLANI
poris acti »; ma è di più: è il fantasticatore d'antiche glorie, privo di senso attuale della
vita; è sovratutto il moralista (I, CLXXX); similmente, nel campo dell'arte, il pe-
dante non è soltanto il purista e il commentatore arzigogolante a ogni passo, ama-
tor degli « uopi » e degli « altresì » (I, CLVII), ma colui che, oltre all'imporre i classici
come modello e a giudicar i moderni misurandoli su quel letto di Procuste, presume
di far dell'arte, ricucendo nelle sue pagine centoni di « eleganze » e di « finezze », « ladro
delle altrui fatiche ». Nel suo odio l'Aretino comprende, sotto tal nome di « pedantifera
satraparia », tutti coloro che senza genio spontaneo nè acutezza critica, in nome d'idee
programmatiche e imparaticce, che puzzan di rifatto e di scolastico, son sempre in
campo a sofisticare, disputare sulla preminenza di questo o di quell'altro, giudicare e
dar consigli a ciascuno, perpetui insoddisfatti d'ogni cosa, ma impotenti a sostituir-
vene altra. È facile immaginare con quanto gusto e acrimonia insieme la spregiudicata
popolaresca spontaneità del Nostro nuova battaglia, fiera del suo edonismo in cui si
sbraca allegroccia e generosa, contro tal genìa, peste del Cinquecento come d'ogni tempo
di povertà intellettuale e morale, e che appunto per questo intellettualizza e mora-
lizza ogni cosa d'arte, perscrutandone universali scopi didascalici.
Tal guerra a morte, con le sue frequenti schermaglie, costringe il Nostro ad iso-
larsi e a determinare il suo pensiero estetico; cosa di cui, altrimenti, non si sarebbe
dato cura, a giudicare dal caos che, anche così, si trova alla prima nel suo cervello.
Quando l'ira non lo porta troppo oltre, egli infatti riconosce ai pedanti il dominio in-
contrastato della « Retorica » in quanto « Ars Poetica » oltre che Critica e Filosofia o
scienza del metodo. Attribuisce ad essi, nei loro sforzi artistici, una letterata sapienza:
Tartifitio, specie d''cxornatio tutta formale del pensiero, appiccicatavi secondo la guida
delle buone regole e dei classici. E come in quel tempo di saputi e di manieristi l'arte
quasi sempre s'era ridotta « artifìcio », così, spesso, egli alla prima dà il significato
della seconda parola. Però a tale ornamentazione riconosce il merito dovuto alla lim;i,
all'affinare, al polire la materia grezza dell'espressione (IV, XXIII; IV, CCCLXVII), e
mentre non vuole che ne sia fatto pregio all'opera sua — intendendola nel senzo cat-
tivo di rimasticamento che sa di scuola (II, CDLIII) — riconosce tuttavia d'essere un
po' rozzo, di non aver che « abbozzato » le sue pagine, e se ne scusa per le ragioni pra-
tiche che gl'imponevano di far presto e trar frutto d'ogni rigo (II, CD). Non per que-
sto condanna egli l'imitazione dei grandi, anzi la propone ai giovani, come ammae-
stramento e spinta all'emulazione (VI, CLXXX). « Ecco, la balia imbocca il bambino
che ella nutrica, gli piglia i piedi, e insegnandogli a trare il passo, gli pone dei suoi rìsi
negli occhi, de le sue parole ne la lingua, de le sue maniere nei gesti; perfinchè la natura,
nel moltiplicargli i giorni, l'empie delle attitudini sue. Ed egli a poco a poco... forma un
modo di nuovi costumi, e lasciando i vezzi de la nudrice, mette in opra i suoi con
la nativa abitudine... ritenendo tanto de lo studio di colei che l'ha alevato, quanto
ritengono de la conoscenza de la madre e del padre gli uccelli che volano » (I, CLVII).
Bisogna dunque per essere artista liberarsi dell'imparaticcio, seguire la « natura »!
E che è mai questa Natura che tanto ricorre nelle pagine dell'Aretino? Bisogna
dirla una parola polimorfica, tentacolare: a volte significa una realtà esterna a lo spirito,
nel comune senso; a volte il fermento universale della vita, che fa di ognuno quell'in-
dividuo e quello solo, operante secondo predestinate vie; a volte è una specie di divinità
platonica dalla cui mente noi riceviamo i concetti e le attitudini.... C'è da scegliere!
E a prender la parola, comunque, in un solo di questi sensi c'è da disperare di capir
mai le ideacce del Nostro, illetterato e afilosofo per temperamento. Eppure egli deve a
questo la felicità di alcune intuizioni!
Lasciamo di considerare come egli usi quel termine nel primo significato, ch'è di
tutti. Molte volte egli parla di imitare, ritrarre la natura, non diverso dai mille orec-
chianti del secolo. È il naturalismo più rozzo e di cui tanto partecipa il Vasari! Più
SERGIO ORTOLANI
poris acti »; ma è di più: è il fantasticatore d'antiche glorie, privo di senso attuale della
vita; è sovratutto il moralista (I, CLXXX); similmente, nel campo dell'arte, il pe-
dante non è soltanto il purista e il commentatore arzigogolante a ogni passo, ama-
tor degli « uopi » e degli « altresì » (I, CLVII), ma colui che, oltre all'imporre i classici
come modello e a giudicar i moderni misurandoli su quel letto di Procuste, presume
di far dell'arte, ricucendo nelle sue pagine centoni di « eleganze » e di « finezze », « ladro
delle altrui fatiche ». Nel suo odio l'Aretino comprende, sotto tal nome di « pedantifera
satraparia », tutti coloro che senza genio spontaneo nè acutezza critica, in nome d'idee
programmatiche e imparaticce, che puzzan di rifatto e di scolastico, son sempre in
campo a sofisticare, disputare sulla preminenza di questo o di quell'altro, giudicare e
dar consigli a ciascuno, perpetui insoddisfatti d'ogni cosa, ma impotenti a sostituir-
vene altra. È facile immaginare con quanto gusto e acrimonia insieme la spregiudicata
popolaresca spontaneità del Nostro nuova battaglia, fiera del suo edonismo in cui si
sbraca allegroccia e generosa, contro tal genìa, peste del Cinquecento come d'ogni tempo
di povertà intellettuale e morale, e che appunto per questo intellettualizza e mora-
lizza ogni cosa d'arte, perscrutandone universali scopi didascalici.
Tal guerra a morte, con le sue frequenti schermaglie, costringe il Nostro ad iso-
larsi e a determinare il suo pensiero estetico; cosa di cui, altrimenti, non si sarebbe
dato cura, a giudicare dal caos che, anche così, si trova alla prima nel suo cervello.
Quando l'ira non lo porta troppo oltre, egli infatti riconosce ai pedanti il dominio in-
contrastato della « Retorica » in quanto « Ars Poetica » oltre che Critica e Filosofia o
scienza del metodo. Attribuisce ad essi, nei loro sforzi artistici, una letterata sapienza:
Tartifitio, specie d''cxornatio tutta formale del pensiero, appiccicatavi secondo la guida
delle buone regole e dei classici. E come in quel tempo di saputi e di manieristi l'arte
quasi sempre s'era ridotta « artifìcio », così, spesso, egli alla prima dà il significato
della seconda parola. Però a tale ornamentazione riconosce il merito dovuto alla lim;i,
all'affinare, al polire la materia grezza dell'espressione (IV, XXIII; IV, CCCLXVII), e
mentre non vuole che ne sia fatto pregio all'opera sua — intendendola nel senzo cat-
tivo di rimasticamento che sa di scuola (II, CDLIII) — riconosce tuttavia d'essere un
po' rozzo, di non aver che « abbozzato » le sue pagine, e se ne scusa per le ragioni pra-
tiche che gl'imponevano di far presto e trar frutto d'ogni rigo (II, CD). Non per que-
sto condanna egli l'imitazione dei grandi, anzi la propone ai giovani, come ammae-
stramento e spinta all'emulazione (VI, CLXXX). « Ecco, la balia imbocca il bambino
che ella nutrica, gli piglia i piedi, e insegnandogli a trare il passo, gli pone dei suoi rìsi
negli occhi, de le sue parole ne la lingua, de le sue maniere nei gesti; perfinchè la natura,
nel moltiplicargli i giorni, l'empie delle attitudini sue. Ed egli a poco a poco... forma un
modo di nuovi costumi, e lasciando i vezzi de la nudrice, mette in opra i suoi con
la nativa abitudine... ritenendo tanto de lo studio di colei che l'ha alevato, quanto
ritengono de la conoscenza de la madre e del padre gli uccelli che volano » (I, CLVII).
Bisogna dunque per essere artista liberarsi dell'imparaticcio, seguire la « natura »!
E che è mai questa Natura che tanto ricorre nelle pagine dell'Aretino? Bisogna
dirla una parola polimorfica, tentacolare: a volte significa una realtà esterna a lo spirito,
nel comune senso; a volte il fermento universale della vita, che fa di ognuno quell'in-
dividuo e quello solo, operante secondo predestinate vie; a volte è una specie di divinità
platonica dalla cui mente noi riceviamo i concetti e le attitudini.... C'è da scegliere!
E a prender la parola, comunque, in un solo di questi sensi c'è da disperare di capir
mai le ideacce del Nostro, illetterato e afilosofo per temperamento. Eppure egli deve a
questo la felicità di alcune intuizioni!
Lasciamo di considerare come egli usi quel termine nel primo significato, ch'è di
tutti. Molte volte egli parla di imitare, ritrarre la natura, non diverso dai mille orec-
chianti del secolo. È il naturalismo più rozzo e di cui tanto partecipa il Vasari! Più