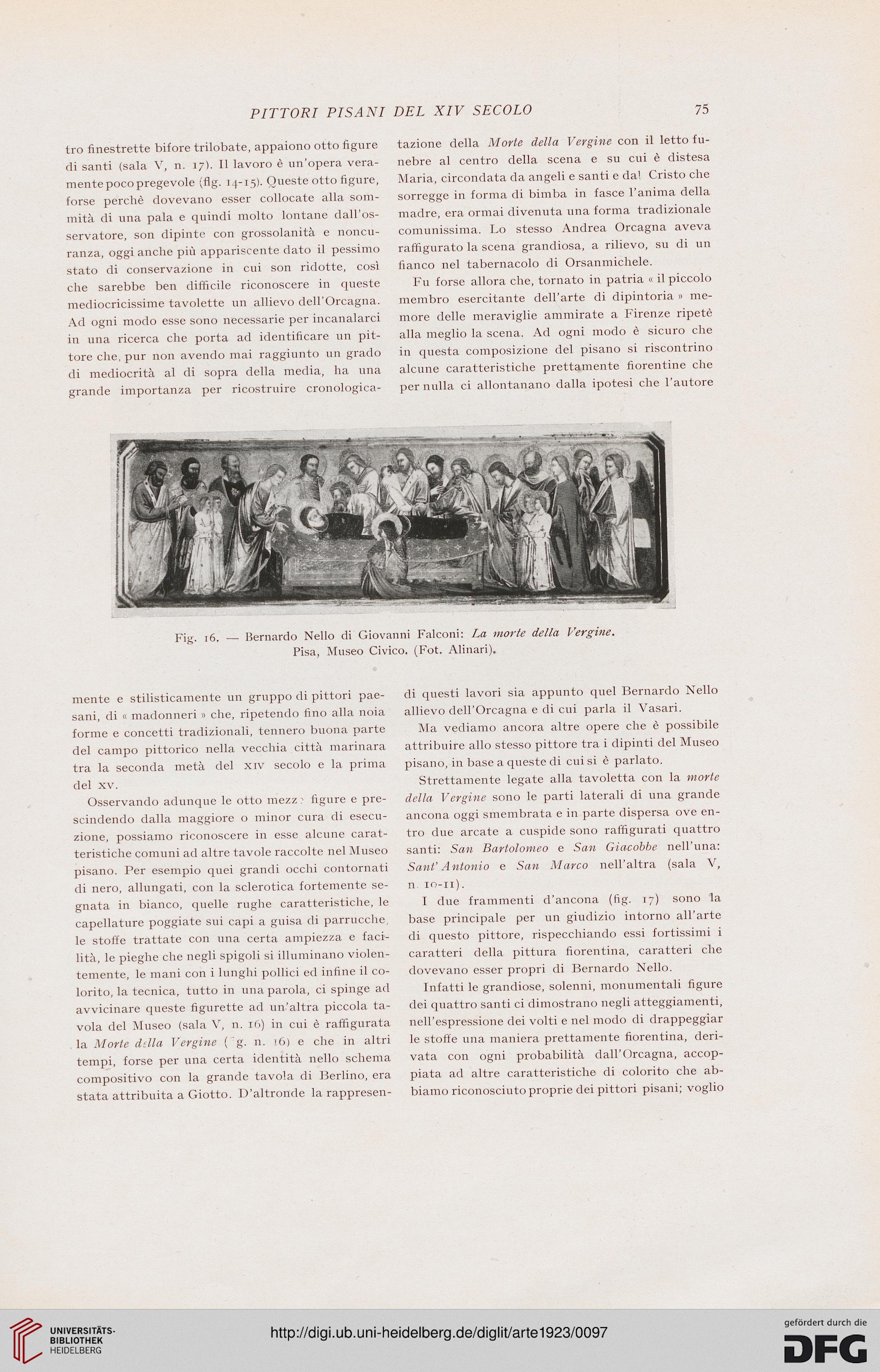PITTORI PISANI DEL XIV SECOLO
75
Irò finestrette bifore trilobate, appaiono otto figure
di santi (sala V, n. 17). Il lavoro è un'opera vera-
mente poco pregevole (flg. 14-15). Queste otto figure,
forse perchè dovevano esser collocate alla som-
mità di una pala e quindi molto lontane dall'os-
servatore, son dipinte con grossolanità e noncu-
ranza, oggi anche più appariscente dato il pessimo
stato di conservazione in cui son ridotte, così
che sarebbe ben difficile riconoscere in queste
mediocricissime tavolette un allievo dell'Orcagna.
Ad ogni modo esse sono necessarie per incanalarci
in una ricerca che porta ad identificare un pit-
tore che, pur non avendo mai raggiunto un grado
di mediocrità al di sopra della media, ha una
grande importanza per ricostruire cronologica-
tazione della Morie della Vergine con il letto fu-
nebre al centro della scena e su cui è distesa
Maria, circondata da angeli e santi e dal Cristo che
sorregge in forma di bimba in fasce l'anima della
madre, era ormai divenuta una forma tradizionale
comunissima. Lo stesso Andrea Orcagna aveva
raffigurato la scena grandiosa, a rilievo, su di un
fianco nel tabernacolo di Orsanmichele.
Fu forse allora che, tornato in patria « il piccolo
membro esercitante dell'arte di dipintoria » me-
more delle meraviglie ammirate a Firenze ripetè
alla meglio la scena. Ad ogni modo è sicuro che
in questa composizione del pisano si riscontrino
alcune caratteristiche prettamente fiorentine che
per nulla ci allontanano dalla ipotesi che l'autore
Fig. 16. — Bernardo Nello di Giovanni Falconi: La morte della Vergine.
Pisa, Museo Civico. (Fot. Alinari).
mente e stilisticamente un gruppo di pittori pae-
sani, di « madonneri » che, ripetendo fino alla noia
forme e concetti tradizionali, tennero buona parte
del campo pittorico nella vecchia città marinara
tra la seconda metà del xtv secolo e la prima
del xv.
Osservando adunque le otto mezz ligure e pre-
scindendo dalla maggiore o minor cura di esecu-
zione, possiamo riconoscere in esse alcune carat-
teristiche comuni ad altre tavole raccolte nel Museo
pisano. Per esempio quei grandi occhi contornati
di nero, allungati, con la sclerotica fortemente se-
gnata in bianco, quelle rughe caratteristiche, le
capellature poggiate sui capi a guisa di parrucche,
le stoffe trattate con una certa ampiezza e faci-
lità, le pieghe che negli spigoli si illuminano violen-
temente, le mani con i lunghi pollici ed infine il co-
lorito, la tecnica, tutto in una parola, ci spinge ad
avvicinare queste figurette ad un'altra piccola ta-
vola del Museo (sala V, n. i(>) in cui è raffigurata
la Morte della Vergine ( g. 11. !(>) e che in altri
tempi, forse per una certa identità nello schema
compositivo con la grande tavola di Berlino, era
stata attribuita a Giotto. D'altronde la rappresen-
di questi lavori sia appunto quel Bernardo Nello
allievo dell'Orcagna e di cui parla il Vasari.
Ma vediamo ancora altre opere che è possibile
attribuire allo stesso pittore tra i dipinti del Museo
pisano, in base a queste di cui si è parlato.
Strettamente legate alla tavoletta con la morte
della Vergine sono le parti laterali di una grande
ancona oggi smembrata e in parte dispersa ove en-
tro due arcate a cuspide sono raffigurati quattro
santi: San Bartolomeo e San Giacobbe nell'una:
Sant' Antonio e San Marco nell'altra (sala V,
n 10-11).
I due frammenti d'ancona (fig. 77) sono la
base principale per un giudizio intorno all'arte
di questo pittore, rispecchiando essi fortissimi i
caratteri della pittura fiorentina, caratteri che
dovevano esser propri di Bernardo Nello.
Infatti le grandiose, solenni, monumentali figure
dei quattro santi ci dimostrano negli atteggiamenti,
nell'espressione dei volti e nel modo di drappeggiar
le stoffe una maniera prettamente fiorentina, deri-
vata con ogni probabilità dall'Orcagna, accop-
piata ad altre caratteristiche di colorito che ab-
biamo riconosciuto proprie dei pittori pisani; voglio
75
Irò finestrette bifore trilobate, appaiono otto figure
di santi (sala V, n. 17). Il lavoro è un'opera vera-
mente poco pregevole (flg. 14-15). Queste otto figure,
forse perchè dovevano esser collocate alla som-
mità di una pala e quindi molto lontane dall'os-
servatore, son dipinte con grossolanità e noncu-
ranza, oggi anche più appariscente dato il pessimo
stato di conservazione in cui son ridotte, così
che sarebbe ben difficile riconoscere in queste
mediocricissime tavolette un allievo dell'Orcagna.
Ad ogni modo esse sono necessarie per incanalarci
in una ricerca che porta ad identificare un pit-
tore che, pur non avendo mai raggiunto un grado
di mediocrità al di sopra della media, ha una
grande importanza per ricostruire cronologica-
tazione della Morie della Vergine con il letto fu-
nebre al centro della scena e su cui è distesa
Maria, circondata da angeli e santi e dal Cristo che
sorregge in forma di bimba in fasce l'anima della
madre, era ormai divenuta una forma tradizionale
comunissima. Lo stesso Andrea Orcagna aveva
raffigurato la scena grandiosa, a rilievo, su di un
fianco nel tabernacolo di Orsanmichele.
Fu forse allora che, tornato in patria « il piccolo
membro esercitante dell'arte di dipintoria » me-
more delle meraviglie ammirate a Firenze ripetè
alla meglio la scena. Ad ogni modo è sicuro che
in questa composizione del pisano si riscontrino
alcune caratteristiche prettamente fiorentine che
per nulla ci allontanano dalla ipotesi che l'autore
Fig. 16. — Bernardo Nello di Giovanni Falconi: La morte della Vergine.
Pisa, Museo Civico. (Fot. Alinari).
mente e stilisticamente un gruppo di pittori pae-
sani, di « madonneri » che, ripetendo fino alla noia
forme e concetti tradizionali, tennero buona parte
del campo pittorico nella vecchia città marinara
tra la seconda metà del xtv secolo e la prima
del xv.
Osservando adunque le otto mezz ligure e pre-
scindendo dalla maggiore o minor cura di esecu-
zione, possiamo riconoscere in esse alcune carat-
teristiche comuni ad altre tavole raccolte nel Museo
pisano. Per esempio quei grandi occhi contornati
di nero, allungati, con la sclerotica fortemente se-
gnata in bianco, quelle rughe caratteristiche, le
capellature poggiate sui capi a guisa di parrucche,
le stoffe trattate con una certa ampiezza e faci-
lità, le pieghe che negli spigoli si illuminano violen-
temente, le mani con i lunghi pollici ed infine il co-
lorito, la tecnica, tutto in una parola, ci spinge ad
avvicinare queste figurette ad un'altra piccola ta-
vola del Museo (sala V, n. i(>) in cui è raffigurata
la Morte della Vergine ( g. 11. !(>) e che in altri
tempi, forse per una certa identità nello schema
compositivo con la grande tavola di Berlino, era
stata attribuita a Giotto. D'altronde la rappresen-
di questi lavori sia appunto quel Bernardo Nello
allievo dell'Orcagna e di cui parla il Vasari.
Ma vediamo ancora altre opere che è possibile
attribuire allo stesso pittore tra i dipinti del Museo
pisano, in base a queste di cui si è parlato.
Strettamente legate alla tavoletta con la morte
della Vergine sono le parti laterali di una grande
ancona oggi smembrata e in parte dispersa ove en-
tro due arcate a cuspide sono raffigurati quattro
santi: San Bartolomeo e San Giacobbe nell'una:
Sant' Antonio e San Marco nell'altra (sala V,
n 10-11).
I due frammenti d'ancona (fig. 77) sono la
base principale per un giudizio intorno all'arte
di questo pittore, rispecchiando essi fortissimi i
caratteri della pittura fiorentina, caratteri che
dovevano esser propri di Bernardo Nello.
Infatti le grandiose, solenni, monumentali figure
dei quattro santi ci dimostrano negli atteggiamenti,
nell'espressione dei volti e nel modo di drappeggiar
le stoffe una maniera prettamente fiorentina, deri-
vata con ogni probabilità dall'Orcagna, accop-
piata ad altre caratteristiche di colorito che ab-
biamo riconosciuto proprie dei pittori pisani; voglio