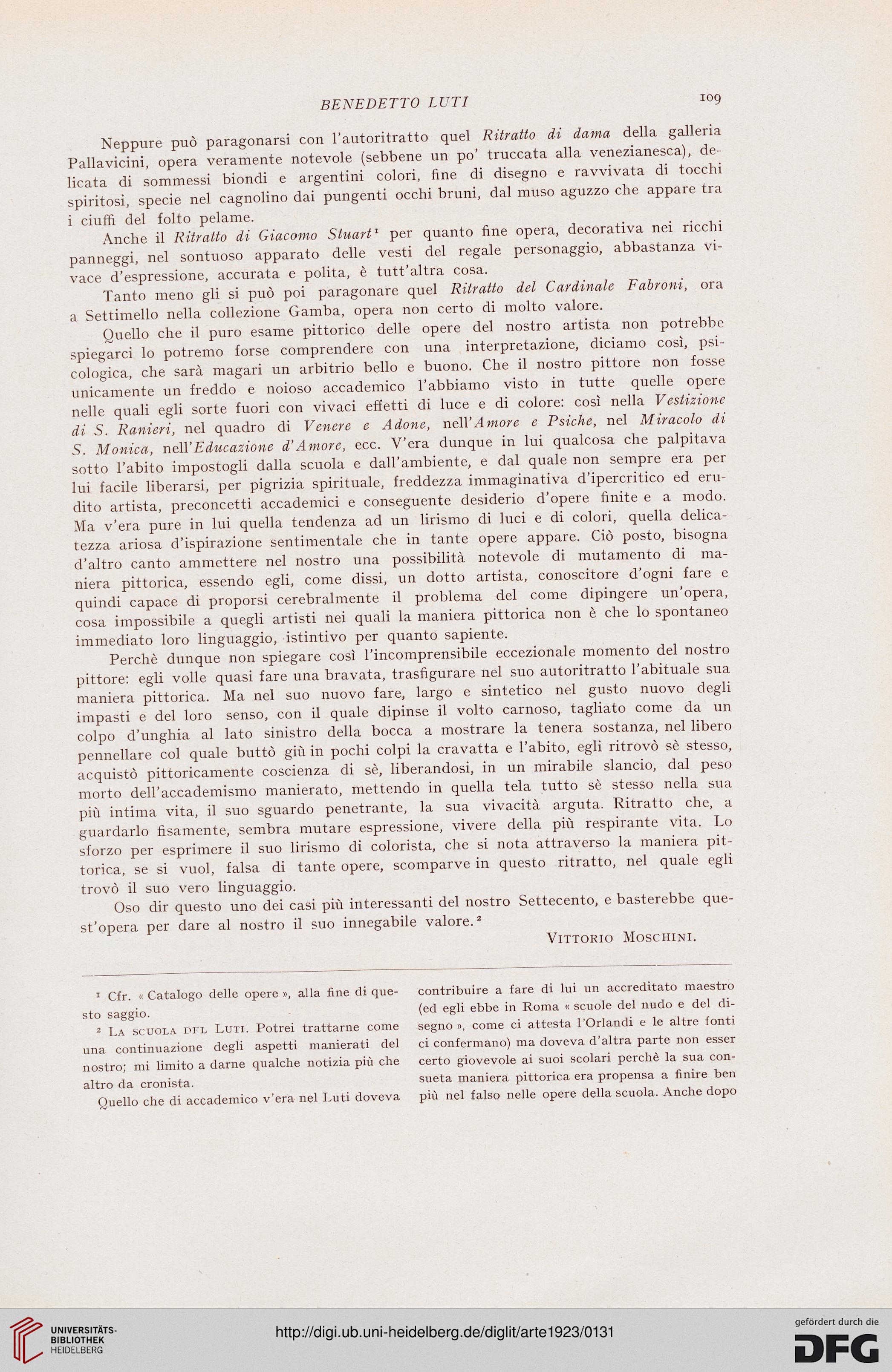BENEDETTO LUTI
109
Neppure può paragonarsi con l'autoritratto quel Ritratto di dama della galleria
Pallavicini, opera veramente notevole (sebbene un po' truccata alla venezianesca), de-
licata di sommessi biondi e argentini colori, fine di disegno e ravvivata di tocchi
spiritosi, specie nel cagnolino dai pungenti occhi bruni, dal muso aguzzo che appare tra
i ciuffi del folto pelame.
Anche il Ritratto di Giacomo Stuart* per quanto fine opera, decorativa nei ricchi
panneggi, nel sontuoso apparato delle vesti del regale personaggio, abbastanza vi-
vace d'espressione, accurata e polita, è tutt'altra cosa.
Tanto meno gli si può poi paragonare quel Ritratto del Cardinale Fabroni, ora
a Settimello nella collezione Gamba, opera non certo di molto valore.
Quello che il puro esame pittorico delle opere del nostro artista non potrebbe
spiegarci lo potremo forse comprendere con una interpretazione, diciamo così, psi-
cologica, che sarà magari un arbitrio bello e buono. Che il nostro pittore non fosse
unicamente un freddo e noioso accademico l'abbiamo visto in tutte quelle opere
nelle quali egli sorte fuori con vivaci effetti di luce e di colore: così nella Vestizione
di S. Ranieri, nel quadro di Venere e Adone, ne\Y Amore e Psiche, nel Miracolo di
S. Monica, ne\V Educazione d'Amore, ecc. V'era dunque in lui qualcosa che palpitava
sotto l'abito impostogli dalla scuola e dall'ambiente, e dal quale non sempre era per
lui facile liberarsi, per pigrizia spirituale, freddezza immaginativa d'ipercritico ed eru-
dito artista, preconcetti accademici e conseguente desiderio d'opere finite e a modo.
Ma v'era pure in lui quella tendenza ad un lirismo di luci e di colori, quella delica-
tezza ariosa d'ispirazione sentimentale che in tante opere appare. Ciò posto, bisogna
d'altro canto ammettere nel nostro una possibilità notevole di mutamento di ma-
niera pittorica, essendo egli, come dissi, un dotto artista, conoscitore d'ogni fare e
quindi capace di proporsi cerebralmente il problema del come dipingere un'opera,
cosa impossibile a quegli artisti nei quali la maniera pittorica non è che lo spontaneo
immediato loro linguaggio, istintivo per quanto sapiente.
Perchè dunque non spiegare così l'incomprensibile eccezionale momento del nostro
pittore: egli volle quasi fare una bravata, trasfigurare nel suo autoritratto l'abituale sua
maniera pittorica. Ma nel suo nuovo fare, largo e sintetico nel gusto nuovo degli
impasti e del loro senso, con il quale dipinse il volto carnoso, tagliato come da un
colpo d'unghia al lato sinistro della bocca a mostrare la tenera sostanza, nel libero
pennellare col quale buttò giù in pochi colpi la cravatta e l'abito, egli ritrovò sè stesso,
acquistò pittoricamente coscienza di sè, liberandosi, in un mirabile slancio, dal peso
morto dell'accademismo manierato, mettendo in quella tela tutto sè stesso nella sua
più intima vita, il suo sguardo penetrante, la sua vivacità arguta. Ritratto che, a
guardarlo fisamente, sembra mutare espressione, vivere della più respirante vita. Lo
sforzo per esprimere il suo lirismo di colorista, che si nota attraverso la maniera pit-
torica, se si vuol, falsa di tante opere, scomparve in questo ritratto, nel quale egli
trovò il suo vero linguaggio.
Oso dir questo uno dei casi più interessanti del nostro Settecento, e basterebbe que-
st'opera per dare al nostro il suo innegabile valore.3
Vittorio Moschini.
1 Cfr. « Catalogo delle opere », alla fine di que-
sto saggio.
2 La scuola dfl Luti. Potrei trattarne come
una continuazione degli aspetti manierati del
nostro; mi limito a darne qualche notizia più che
altro da cronista.
Quello che di accademico v'era nel Luti doveva
contribuire a fare di lui un accreditato maestro
(ed egli ebbe in Roma « scuole del nudo e del di-
segno », come ci attesta l'Orlandi e le altre fonti
ci confermano) ma doveva d'altra parte non esser
certo giovevole ai suoi scolari perchè la sua con-
sueta maniera pittorica era propensa a finire ben
più nel falso nelle opere della scuola. Anche dopo
109
Neppure può paragonarsi con l'autoritratto quel Ritratto di dama della galleria
Pallavicini, opera veramente notevole (sebbene un po' truccata alla venezianesca), de-
licata di sommessi biondi e argentini colori, fine di disegno e ravvivata di tocchi
spiritosi, specie nel cagnolino dai pungenti occhi bruni, dal muso aguzzo che appare tra
i ciuffi del folto pelame.
Anche il Ritratto di Giacomo Stuart* per quanto fine opera, decorativa nei ricchi
panneggi, nel sontuoso apparato delle vesti del regale personaggio, abbastanza vi-
vace d'espressione, accurata e polita, è tutt'altra cosa.
Tanto meno gli si può poi paragonare quel Ritratto del Cardinale Fabroni, ora
a Settimello nella collezione Gamba, opera non certo di molto valore.
Quello che il puro esame pittorico delle opere del nostro artista non potrebbe
spiegarci lo potremo forse comprendere con una interpretazione, diciamo così, psi-
cologica, che sarà magari un arbitrio bello e buono. Che il nostro pittore non fosse
unicamente un freddo e noioso accademico l'abbiamo visto in tutte quelle opere
nelle quali egli sorte fuori con vivaci effetti di luce e di colore: così nella Vestizione
di S. Ranieri, nel quadro di Venere e Adone, ne\Y Amore e Psiche, nel Miracolo di
S. Monica, ne\V Educazione d'Amore, ecc. V'era dunque in lui qualcosa che palpitava
sotto l'abito impostogli dalla scuola e dall'ambiente, e dal quale non sempre era per
lui facile liberarsi, per pigrizia spirituale, freddezza immaginativa d'ipercritico ed eru-
dito artista, preconcetti accademici e conseguente desiderio d'opere finite e a modo.
Ma v'era pure in lui quella tendenza ad un lirismo di luci e di colori, quella delica-
tezza ariosa d'ispirazione sentimentale che in tante opere appare. Ciò posto, bisogna
d'altro canto ammettere nel nostro una possibilità notevole di mutamento di ma-
niera pittorica, essendo egli, come dissi, un dotto artista, conoscitore d'ogni fare e
quindi capace di proporsi cerebralmente il problema del come dipingere un'opera,
cosa impossibile a quegli artisti nei quali la maniera pittorica non è che lo spontaneo
immediato loro linguaggio, istintivo per quanto sapiente.
Perchè dunque non spiegare così l'incomprensibile eccezionale momento del nostro
pittore: egli volle quasi fare una bravata, trasfigurare nel suo autoritratto l'abituale sua
maniera pittorica. Ma nel suo nuovo fare, largo e sintetico nel gusto nuovo degli
impasti e del loro senso, con il quale dipinse il volto carnoso, tagliato come da un
colpo d'unghia al lato sinistro della bocca a mostrare la tenera sostanza, nel libero
pennellare col quale buttò giù in pochi colpi la cravatta e l'abito, egli ritrovò sè stesso,
acquistò pittoricamente coscienza di sè, liberandosi, in un mirabile slancio, dal peso
morto dell'accademismo manierato, mettendo in quella tela tutto sè stesso nella sua
più intima vita, il suo sguardo penetrante, la sua vivacità arguta. Ritratto che, a
guardarlo fisamente, sembra mutare espressione, vivere della più respirante vita. Lo
sforzo per esprimere il suo lirismo di colorista, che si nota attraverso la maniera pit-
torica, se si vuol, falsa di tante opere, scomparve in questo ritratto, nel quale egli
trovò il suo vero linguaggio.
Oso dir questo uno dei casi più interessanti del nostro Settecento, e basterebbe que-
st'opera per dare al nostro il suo innegabile valore.3
Vittorio Moschini.
1 Cfr. « Catalogo delle opere », alla fine di que-
sto saggio.
2 La scuola dfl Luti. Potrei trattarne come
una continuazione degli aspetti manierati del
nostro; mi limito a darne qualche notizia più che
altro da cronista.
Quello che di accademico v'era nel Luti doveva
contribuire a fare di lui un accreditato maestro
(ed egli ebbe in Roma « scuole del nudo e del di-
segno », come ci attesta l'Orlandi e le altre fonti
ci confermano) ma doveva d'altra parte non esser
certo giovevole ai suoi scolari perchè la sua con-
sueta maniera pittorica era propensa a finire ben
più nel falso nelle opere della scuola. Anche dopo