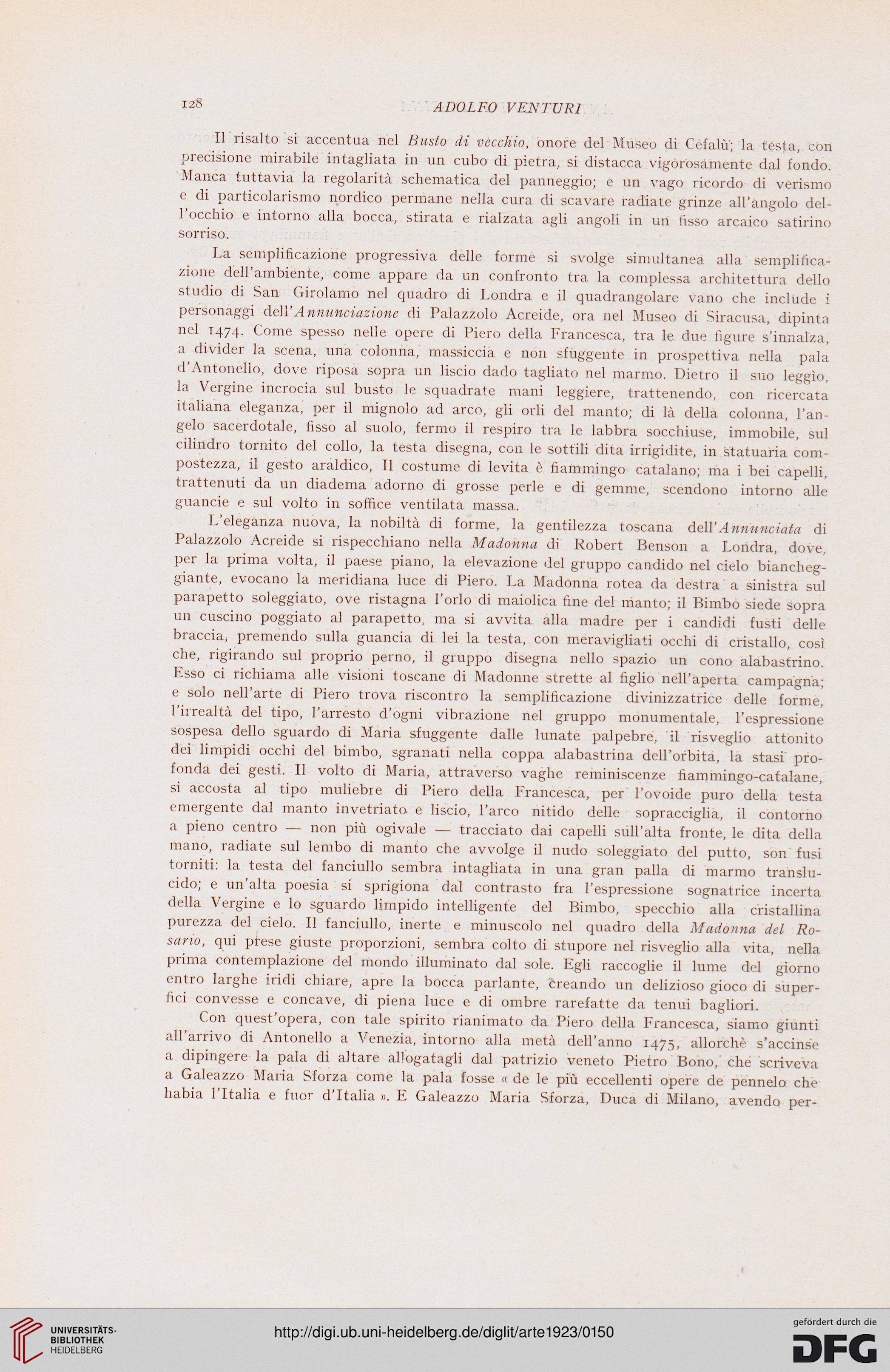128
ADOLFO VENTURI
II risalto si accentua nel Busto di vecchio, onore del Museo di Cèfalù"; la testa, con
precisione mirabile intagliata in un cubo di pietra, si distacca vigorosamente dal fondo.
Manca tuttavia la regolarità schematica del panneggio; e un vago ricordo di verismo
e di particolarismo nordico permane nella cura di scavale radiate grinze all'angolo del-
l'occhio e intorno alla bocca, stirata e rialzata agli angoli in uri fisso arcaico satirino
sorriso.
La semplificazione progressiva delle forme si svolge simultanea alla semplifica-
zione dell'ambiente, come appare da un confronto tra la complessa architettura dello
studio di San Girolamo nel quadro di Londra e il quadrangolare vano che include i
personaggi dell' Annunciazione di Palazzolo Acreide, ora nel Museo di Siracusa, dipinta
nel 1474. Come spesso nelle opere di Piero della Francesca, tra le due ligure s'innalza,
a divider la scena, una colonna, massiccia e non sfuggente in prospettiva nella pala
d'Antonello, dove riposa sopra un liscio dado tagliato nel marmo. Dietro il suo leggìo,
la Vergine incrocia sul busto le squadrate mani leggiere, trattenendo, con ricercata
italiana eleganza, per il mignolo ad arco, gli orli del manto; di là della colonna, l'an-
gelo sacerdotale, fisso al suolo, fermo il respiro tra le labbra socchiuse, immobile, sul
cilindro tornito del collo, la testa disegna, con le sottili dita irrigidite, in statuaria com-
postezza, il gesto araldico, Il costume di levita è fiammingo catalano; ma i bei capelli,
trattenuti da un diadema adorno di grosse perle e di gemme, scendono intorno alle
guancie e sul volto in soffice ventilata massa.
L'eleganza nuova, la nobiltà di forme, la gentilezza toscana dell' Annunciata di
Palazzolo Acreide si rispecchiano nella Madonna di Robert Benson a Londra, dove,
per la prima volta, il paese piano, la elevazione del gruppo candido nel cielo biancheg-
giante, evocano la meridiana luce di Piero. La Madonna rotea da destra a sinistra sul
parapetto soleggiato, ove ristagna l'orlo di maiolica fine de! manto; il Bimbo siede sopra
un cuscino poggiato al parapetto, ma si avvita alla madre per i candidi fusti delle
braccia, premendo sulla guancia di lei la testa, con meravigliati occhi di cristallo, così
che, rigirando sul proprio perno, il gruppo disegna nello spazio un cono alabastrino.
Esso ci richiama alle visioni toscane di Madonne strette al figlio nell'aperta campagna;
e solo nell'arte di Piero trova riscontro la semplificazione divinizzatrice delle forme,
l'irrealtà del tipo, l'arresto d'ogni vibrazione nel gruppo monumentale, l'espressione
sospesa dello sguardo di Maria sfuggente dalle lunate palpebre, il risveglio attonito
dei limpidi occhi del bimbo, sgranati nella coppa alabastrina dell'orbita, la stasi' pro-
fonda dei gesti. Il volto di Maria, attraverso vaghe reminiscenze fiammingo-catalane,
si accosta al tipo muliebre di Piero della Francesca, per l'ovoide puro della testa
emergente dal manto invetriato e liscio, l'arco nitido delle sopracciglia, il contorno
a pieno centro — non più ogivale — tracciato dai capelli sull'alta fronte, le dita della
mano, radiate sul lembo di manto che avvolge il nudo soleggiato del putto, son fusi
torniti: la testa del fanciullo sembra intagliata in una gran palla di marmo translu-
cido; e un'alta poesia si sprigiona dal contrasto fra l'espressione sognatrice incerta
della Vergine e lo sguardo limpido intelligente del Bimbo, specchio alla cristallina
purezza del cielo. Il fanciullo, inerte e minuscolo nel quadro della Madonna del Ro-
sario, qui prese giuste proporzioni, sembra colto di stupore nel risveglio alla vita, nella
prima contemplazione del mondo illuminato dal sole. Egli raccoglie il lume del giorno
entro larghe iridi chiare, apre la bocca parlante, Creando un delizioso gioco di super-
fici convesse e concave, di piena luce e di ombre rarefatte da tenui bagliori.
Con quest'opera, con tale spirito rianimato da Piero della Francesca, siamo giunti
all'arrivo di Antonello a Venezia, intorno alla metà dell'anno 1475, allorché s'accinse
a dipingere la pala di altare allogatagli dal patrizio veneto Pietro Bono, che scriveva
a Galeazzo Maria Sforza come la pala fosse « de le più eccellenti opere de pennelo che
habia l'Italia e fuor d'Italia ». E Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano, avendo per-
ADOLFO VENTURI
II risalto si accentua nel Busto di vecchio, onore del Museo di Cèfalù"; la testa, con
precisione mirabile intagliata in un cubo di pietra, si distacca vigorosamente dal fondo.
Manca tuttavia la regolarità schematica del panneggio; e un vago ricordo di verismo
e di particolarismo nordico permane nella cura di scavale radiate grinze all'angolo del-
l'occhio e intorno alla bocca, stirata e rialzata agli angoli in uri fisso arcaico satirino
sorriso.
La semplificazione progressiva delle forme si svolge simultanea alla semplifica-
zione dell'ambiente, come appare da un confronto tra la complessa architettura dello
studio di San Girolamo nel quadro di Londra e il quadrangolare vano che include i
personaggi dell' Annunciazione di Palazzolo Acreide, ora nel Museo di Siracusa, dipinta
nel 1474. Come spesso nelle opere di Piero della Francesca, tra le due ligure s'innalza,
a divider la scena, una colonna, massiccia e non sfuggente in prospettiva nella pala
d'Antonello, dove riposa sopra un liscio dado tagliato nel marmo. Dietro il suo leggìo,
la Vergine incrocia sul busto le squadrate mani leggiere, trattenendo, con ricercata
italiana eleganza, per il mignolo ad arco, gli orli del manto; di là della colonna, l'an-
gelo sacerdotale, fisso al suolo, fermo il respiro tra le labbra socchiuse, immobile, sul
cilindro tornito del collo, la testa disegna, con le sottili dita irrigidite, in statuaria com-
postezza, il gesto araldico, Il costume di levita è fiammingo catalano; ma i bei capelli,
trattenuti da un diadema adorno di grosse perle e di gemme, scendono intorno alle
guancie e sul volto in soffice ventilata massa.
L'eleganza nuova, la nobiltà di forme, la gentilezza toscana dell' Annunciata di
Palazzolo Acreide si rispecchiano nella Madonna di Robert Benson a Londra, dove,
per la prima volta, il paese piano, la elevazione del gruppo candido nel cielo biancheg-
giante, evocano la meridiana luce di Piero. La Madonna rotea da destra a sinistra sul
parapetto soleggiato, ove ristagna l'orlo di maiolica fine de! manto; il Bimbo siede sopra
un cuscino poggiato al parapetto, ma si avvita alla madre per i candidi fusti delle
braccia, premendo sulla guancia di lei la testa, con meravigliati occhi di cristallo, così
che, rigirando sul proprio perno, il gruppo disegna nello spazio un cono alabastrino.
Esso ci richiama alle visioni toscane di Madonne strette al figlio nell'aperta campagna;
e solo nell'arte di Piero trova riscontro la semplificazione divinizzatrice delle forme,
l'irrealtà del tipo, l'arresto d'ogni vibrazione nel gruppo monumentale, l'espressione
sospesa dello sguardo di Maria sfuggente dalle lunate palpebre, il risveglio attonito
dei limpidi occhi del bimbo, sgranati nella coppa alabastrina dell'orbita, la stasi' pro-
fonda dei gesti. Il volto di Maria, attraverso vaghe reminiscenze fiammingo-catalane,
si accosta al tipo muliebre di Piero della Francesca, per l'ovoide puro della testa
emergente dal manto invetriato e liscio, l'arco nitido delle sopracciglia, il contorno
a pieno centro — non più ogivale — tracciato dai capelli sull'alta fronte, le dita della
mano, radiate sul lembo di manto che avvolge il nudo soleggiato del putto, son fusi
torniti: la testa del fanciullo sembra intagliata in una gran palla di marmo translu-
cido; e un'alta poesia si sprigiona dal contrasto fra l'espressione sognatrice incerta
della Vergine e lo sguardo limpido intelligente del Bimbo, specchio alla cristallina
purezza del cielo. Il fanciullo, inerte e minuscolo nel quadro della Madonna del Ro-
sario, qui prese giuste proporzioni, sembra colto di stupore nel risveglio alla vita, nella
prima contemplazione del mondo illuminato dal sole. Egli raccoglie il lume del giorno
entro larghe iridi chiare, apre la bocca parlante, Creando un delizioso gioco di super-
fici convesse e concave, di piena luce e di ombre rarefatte da tenui bagliori.
Con quest'opera, con tale spirito rianimato da Piero della Francesca, siamo giunti
all'arrivo di Antonello a Venezia, intorno alla metà dell'anno 1475, allorché s'accinse
a dipingere la pala di altare allogatagli dal patrizio veneto Pietro Bono, che scriveva
a Galeazzo Maria Sforza come la pala fosse « de le più eccellenti opere de pennelo che
habia l'Italia e fuor d'Italia ». E Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano, avendo per-