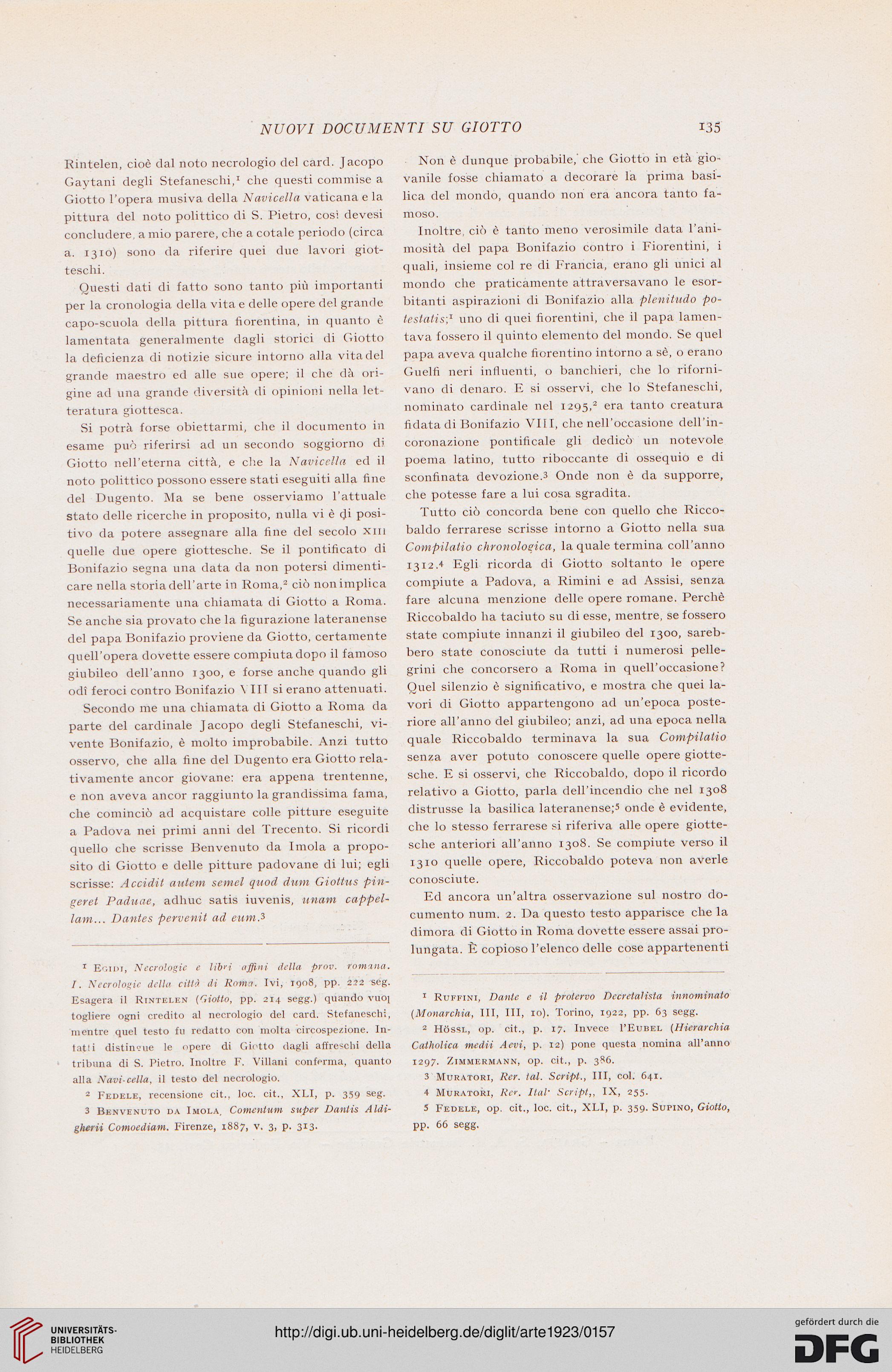NUOVI DOCUMENTI SU GIOTTO
135
Kintelen, cioè dal noto necrologio del card. Jacopo
Gaytani degli Stefaneschi,1 che questi commise a
Giotto l'opera musiva della Navicella vaticana e la
pittura del noto polittico di S. Pietro, cosi devesi
concludere, a mio parere, che a cotale periodo (circa
a. 1310) sono da riferire quei due lavori giot-
teschi.
Onesti dati di fatto sono tanto più importanti
per la cronologia della vita e delle opere del grande
capo-scuola della pittura fiorentina, in (pianto è
lamentata generalmente dagli storici di Giotto
la deficienza di notizie sicure intorno alla vita del
grande maestro ed alle sue opere; il che dà ori-
gine ad una grande diversità di opinioni nella let-
teratura giottesca.
Si potrà torse obiettarmi, che il documento in
esame può riferirsi ad un secondo soggiorno di
Giotto nell'eterna città, e che la Navicelli! ed il
noto polittico possono essere stati eseguiti alla fine
del Dugento. Ma se bene osserviamo l'attuale
stato delle ricerche in proposito, nulla vi è di posi-
tivo da potere assegnare alla fine del secolo xm
quelle due opere giottesche. Se il pontificato di
Bonifacio segna una data da non potersi dimenti-
care nella storia dell'arte in Roma,2 ciò non implica
necessariamente una chiamata di Giotto a Roma.
Se anche sia provato che la figurazione lateranense
del papa Bonifazio proviene da Giotto, certamente
quell'opera dovette essere compiuta dopo il famoso
giubileo dell'anno 1300, e forse anche quando gli
odi feroci contro Bonifazio \ III si erano attenuati.
Secondo me una chiamata di Giotto a Roma da
parte del cardinale Jacopo degli Stefaneschi, vi-
vente Bonifazio, è molto improbabile. Anzi tutto
osservo, che alla fine del Dugento era Giotto rela-
tivamente ancor giovane: era appena trentenne,
e non aveva ancor raggiunto la grandissima fama,
che cominciò ad acquistare colle pitture eseguite
a Padova nei primi anni del Trecento. Si ricordi
quello che scrisse Benvenuto da Imola a propo-
sito di Giotto e delle pitture padovane di lui; egli
scrisse: Accidit antan scimi quod dutn Giottus pun-
gerei Paduae, adhuc satis iuvenis, unam cappel-
lani... Dantes pervenit ad enm.3
1 Bgidt, Necrologie t libri offini {Iella prov. romina.
I. Necrologie dello città di Roma. Ivi, 1908, pp. 2?2 seg.
Esagera il Rintelen [liotto, pp. 214 segg.) quando vuo[
togliere ogni credito al necrologio del card. Stefaneschi,
mentre quel testo fu redatto con molta circospezione. In-
tatti distingue le opere di Giotto dagli affreschi della
tribuna di S. Pietro. Inoltre F. Villani conferma, quanto
alla Navi cella, il testo del necrologio.
2 Fedele, recensione cit., loc. cit., XLI, p. 359 seg.
3 Benvenuto da Imola Comcntum super Dantis Aldi-
gherii Comoediam. Firenze, 1887, v. 3, p. 313.
Non è dunque probabile, che Giotto in età gio-
vanile fosse chiamato a decorare la prima basi-
lica del mondo, quando non era ancora tanto fa-
moso.
Inoltre ciò è tanto meno verosimile data l'ani-
mosità del papa Bonifazio contro i Fiorentini, i
quali, insieme col re di Francia, erano gli unici al
mondo che praticamente attraversavano le esor-
bitanti aspirazioni di Bonifazio alla plenitudo po-
testatis;1 uno di quei fiorentini, che il papa lamen-
tava fossero il quinto elemento del mondo. Se quel
papa aveva qualche fiorentino intorno a sè, o erano
Guelfi neri influenti, o banchieri, che lo riforni-
vano ili denaro. E si osservi, che lo Stefaneschi,
nominato cardinale nel 1295,2 era tanto creatura
fidata di Boni fa zio Vili, che nell'occasione dell'in-
coronazione pontificale gli dedicò un notevole
poema latino, tutto riboccante di ossequio e di
sconfinata devozione.3 Onde non è da supporre,
che potesse fare a lui cosa sgradita.
Tutto ciò concorda bene con quello che Ricco-
baldo ferrarese scrisse intorno a Giotto nella sua
Compilatio chronoloeica, la quale termina coiranno
1312.4 Egli ricorda di Giotto soltanto le opere
compiute a Padova, a Rimini e ad Assisi, senza
fare alcuna menzione delle opere romane. Perchè
Kiccobaldo ha taciuto su di esse, mentre, se fossero
state compiute innanzi il giubileo del 1300, sareb-
bero state conosciute da tutti i numerosi pelle-
grini che concorsero a Roma in quell'occasione?
Quel silenzio è significativo, e mostra che quei la-
vori di Giotto appartengono ad un'epoca poste-
riore all'anno del giubileo; anzi, ad una epoca nella
quale Riccobaldo terminava la sua Compilatio
senza aver potuto conoscere quelle opere giotte-
sche. E si osservi, che Riccobaldo, dopo il ricordo
relativo a Giotto, parla dell'incendio che nel 1308
distrusse la basilica lateranense;' onde è evidente,
che lo stesso ferrarese si riferiva alle opere giotte-
sche anteriori all'anno 1308. Se compiute verso il
1310 quelle opere, Riccobaldo poteva non averle
conosciute.
Ed ancora un'altra osservazione sul nostro do-
cumento num. 2. Da questo testo apparisce che la
dimora di Giotto in Roma dovette essere assai pro-
lungata. È copioso l'elenco delle cose appartenenti
1 Ruffini, Dante e il protervo Decrctalista innominato
(Monarchia, III, III, 10). Torino, 1922, pp. 63 segg.
2 Hossl, op. cit., p. 17. Invece I'Eubel (Hierarchia
Catholica medii Aevi, p. 12) pone questa nomina all'anno
1297. ZlMMERMANN, Op. CÌt., p. 386.
3 Muratori, Rcr. lai. Script., Ili, col. 641.
4 Muratori, A'n\ lini- Script,, IX, 255.
5 Fedele, op. cit., loc. cit., XLI, p. 359. Supino, Giotto,
pp. 66 segg.
135
Kintelen, cioè dal noto necrologio del card. Jacopo
Gaytani degli Stefaneschi,1 che questi commise a
Giotto l'opera musiva della Navicella vaticana e la
pittura del noto polittico di S. Pietro, cosi devesi
concludere, a mio parere, che a cotale periodo (circa
a. 1310) sono da riferire quei due lavori giot-
teschi.
Onesti dati di fatto sono tanto più importanti
per la cronologia della vita e delle opere del grande
capo-scuola della pittura fiorentina, in (pianto è
lamentata generalmente dagli storici di Giotto
la deficienza di notizie sicure intorno alla vita del
grande maestro ed alle sue opere; il che dà ori-
gine ad una grande diversità di opinioni nella let-
teratura giottesca.
Si potrà torse obiettarmi, che il documento in
esame può riferirsi ad un secondo soggiorno di
Giotto nell'eterna città, e che la Navicelli! ed il
noto polittico possono essere stati eseguiti alla fine
del Dugento. Ma se bene osserviamo l'attuale
stato delle ricerche in proposito, nulla vi è di posi-
tivo da potere assegnare alla fine del secolo xm
quelle due opere giottesche. Se il pontificato di
Bonifacio segna una data da non potersi dimenti-
care nella storia dell'arte in Roma,2 ciò non implica
necessariamente una chiamata di Giotto a Roma.
Se anche sia provato che la figurazione lateranense
del papa Bonifazio proviene da Giotto, certamente
quell'opera dovette essere compiuta dopo il famoso
giubileo dell'anno 1300, e forse anche quando gli
odi feroci contro Bonifazio \ III si erano attenuati.
Secondo me una chiamata di Giotto a Roma da
parte del cardinale Jacopo degli Stefaneschi, vi-
vente Bonifazio, è molto improbabile. Anzi tutto
osservo, che alla fine del Dugento era Giotto rela-
tivamente ancor giovane: era appena trentenne,
e non aveva ancor raggiunto la grandissima fama,
che cominciò ad acquistare colle pitture eseguite
a Padova nei primi anni del Trecento. Si ricordi
quello che scrisse Benvenuto da Imola a propo-
sito di Giotto e delle pitture padovane di lui; egli
scrisse: Accidit antan scimi quod dutn Giottus pun-
gerei Paduae, adhuc satis iuvenis, unam cappel-
lani... Dantes pervenit ad enm.3
1 Bgidt, Necrologie t libri offini {Iella prov. romina.
I. Necrologie dello città di Roma. Ivi, 1908, pp. 2?2 seg.
Esagera il Rintelen [liotto, pp. 214 segg.) quando vuo[
togliere ogni credito al necrologio del card. Stefaneschi,
mentre quel testo fu redatto con molta circospezione. In-
tatti distingue le opere di Giotto dagli affreschi della
tribuna di S. Pietro. Inoltre F. Villani conferma, quanto
alla Navi cella, il testo del necrologio.
2 Fedele, recensione cit., loc. cit., XLI, p. 359 seg.
3 Benvenuto da Imola Comcntum super Dantis Aldi-
gherii Comoediam. Firenze, 1887, v. 3, p. 313.
Non è dunque probabile, che Giotto in età gio-
vanile fosse chiamato a decorare la prima basi-
lica del mondo, quando non era ancora tanto fa-
moso.
Inoltre ciò è tanto meno verosimile data l'ani-
mosità del papa Bonifazio contro i Fiorentini, i
quali, insieme col re di Francia, erano gli unici al
mondo che praticamente attraversavano le esor-
bitanti aspirazioni di Bonifazio alla plenitudo po-
testatis;1 uno di quei fiorentini, che il papa lamen-
tava fossero il quinto elemento del mondo. Se quel
papa aveva qualche fiorentino intorno a sè, o erano
Guelfi neri influenti, o banchieri, che lo riforni-
vano ili denaro. E si osservi, che lo Stefaneschi,
nominato cardinale nel 1295,2 era tanto creatura
fidata di Boni fa zio Vili, che nell'occasione dell'in-
coronazione pontificale gli dedicò un notevole
poema latino, tutto riboccante di ossequio e di
sconfinata devozione.3 Onde non è da supporre,
che potesse fare a lui cosa sgradita.
Tutto ciò concorda bene con quello che Ricco-
baldo ferrarese scrisse intorno a Giotto nella sua
Compilatio chronoloeica, la quale termina coiranno
1312.4 Egli ricorda di Giotto soltanto le opere
compiute a Padova, a Rimini e ad Assisi, senza
fare alcuna menzione delle opere romane. Perchè
Kiccobaldo ha taciuto su di esse, mentre, se fossero
state compiute innanzi il giubileo del 1300, sareb-
bero state conosciute da tutti i numerosi pelle-
grini che concorsero a Roma in quell'occasione?
Quel silenzio è significativo, e mostra che quei la-
vori di Giotto appartengono ad un'epoca poste-
riore all'anno del giubileo; anzi, ad una epoca nella
quale Riccobaldo terminava la sua Compilatio
senza aver potuto conoscere quelle opere giotte-
sche. E si osservi, che Riccobaldo, dopo il ricordo
relativo a Giotto, parla dell'incendio che nel 1308
distrusse la basilica lateranense;' onde è evidente,
che lo stesso ferrarese si riferiva alle opere giotte-
sche anteriori all'anno 1308. Se compiute verso il
1310 quelle opere, Riccobaldo poteva non averle
conosciute.
Ed ancora un'altra osservazione sul nostro do-
cumento num. 2. Da questo testo apparisce che la
dimora di Giotto in Roma dovette essere assai pro-
lungata. È copioso l'elenco delle cose appartenenti
1 Ruffini, Dante e il protervo Decrctalista innominato
(Monarchia, III, III, 10). Torino, 1922, pp. 63 segg.
2 Hossl, op. cit., p. 17. Invece I'Eubel (Hierarchia
Catholica medii Aevi, p. 12) pone questa nomina all'anno
1297. ZlMMERMANN, Op. CÌt., p. 386.
3 Muratori, Rcr. lai. Script., Ili, col. 641.
4 Muratori, A'n\ lini- Script,, IX, 255.
5 Fedele, op. cit., loc. cit., XLI, p. 359. Supino, Giotto,
pp. 66 segg.