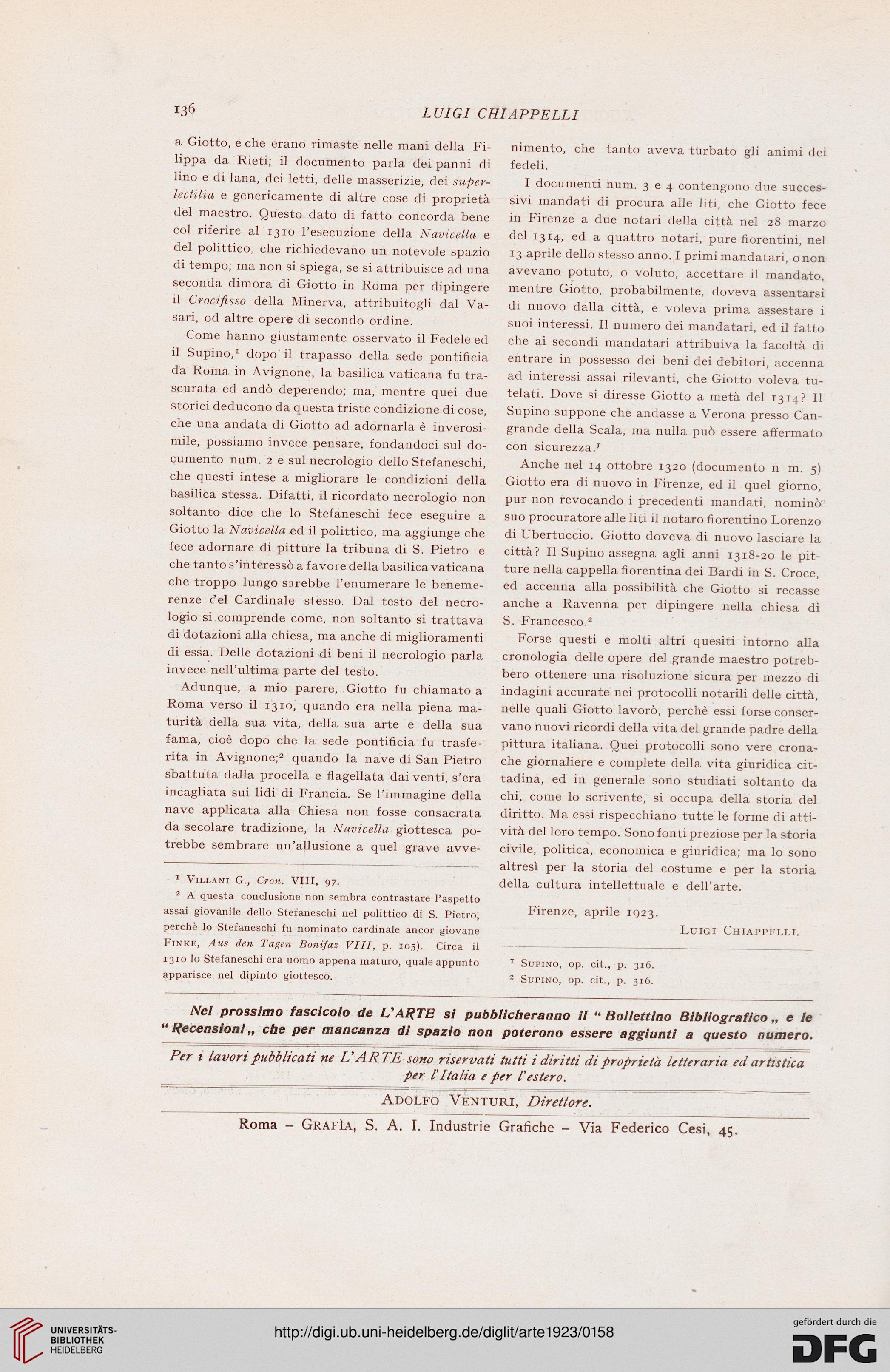136
LUIGI CHI APPELLI
a Giotto, e che erano rimaste nelle mani della Fi-
lippa da Rieti; il documento parla dei panni di
lino e di lana, dei letti, delle masserizie, dei super-
lectilia e genericamente di altre cose di proprietà
del maestro. Questo dato di fatto concorda bene
col riferire al 1310 l'esecuzione della Navicella e
del polittico, che richiedevano un notevole spazio
di tempo; ma non si spiega, se si attribuisce ad una
seconda dimora di Giotto in Roma per dipingere
il Crocifisso della Minerva, attribuitogli dal Va-
sari, od altre opere di secondo ordine.
Come hanno giustamente osservato il Fedele ed
il Supino,1 dopo il trapasso della sede pontificia
da Roma in Avignone, la basilica vaticana fu tra-
scurata ed andò deperendo; ma, mentre quei due
storici deducono da questa triste condizione di cose,
che una andata di Giotto ad adornarla è inverosi-
mile, possiamo invece pensare, fondandoci sul do-
cumento num. 2 e sul necrologio dello Stefaneschi,
che questi intese a migliorare le condizioni della
basilica stessa. Difatti, il ricordato necrologio non
soltanto dice che lo Stefaneschi fece eseguire a
Giotto la Navicella ed il polittico, ma aggiunge che
fece adornare di pitture la tribuna di S. Pietro e
che tanto s'interessò a favore della basilica vaticana
che troppo lungo sarebbe l'enumerare le beneme-
renze r'el Cardinale slesso. Dal testo del necro-
logio si comprende come, non soltanto si trattava
di dotazioni alla chiesa, ma anche di miglioramenti
di essa. Delle dotazioni di beni il necrologio parla
invece nell'ultima parte del testo.
Adunque, a mio parere, Giotto fu chiamato a
Roma verso il 1310, quando era nella piena ma-
turità della sua vita, della sua arte e della sua
fama, cioè dopo che la sede pontificia fu trasfe-
rita in Avignone;2 quando la nave di San Pietro
sbattuta dalla procella e flagellata dai venti, s'era
incagliata sui lidi di Francia. Se l'immagine della
nave applicata alla Chiesa non fosse consacrata
da secolare tradizione, la Navicella giottesca po-
trebbe sembrare un'allusione a quel grave avve-
1 Villani G., Cron. Vili, 97.
2 a questa conclusione non sembra contrastare l'aspetto
assai giovanile dello Stefaneschi nel polittico di S. Pietro,
perchè lo Stefaneschi fu nominato cardinale ancor giovane
Fin», Aus den Tagen Bonifaz Vili, p. 105). Circa il
1310 lo Stefaneschi era uomo appena maturo, quale appunto
apparisce nel dipinto giottesco.
nimento, che tanto aveva turbato gli animi dei
fedeli.
I documenti num. 3 e 4 contengono due succes-
sivi mandati di procura alle liti, che Giotto fece
in Firenze a due notari della città nel 28 marzo
del 1314, ed a quattro notari, pure fiorentini, nel
13 aprile dello stesso anno. I primi mandatari, onon
avevano potuto, o voluto, accettare il mandato,
mentre Giotto, probabilmente, doveva assentarsi
di nuovo dalla città, e voleva prima assestare i
suoi interessi. Il numero dei mandatari, ed il fatto
che ai secondi mandatari attribuiva la facoltà di
entrare in possesso dei beni dei debitori, accenna
ad interessi assai rilevanti, che Giotto voleva tu-
telati. Dove si diresse Giotto a metà del 1314? Il
Supino suppone che andasse a Verona presso Can-
grande della Scala, ma nulla può essere affermato
con sicurezza.'
Anche nel 14 ottobre 1320 (documento n m. 5)
Giotto era di nuovo in Firenze, ed il quel giorno,
pur non revocando i precedenti mandati, nominò
suo procuratore alle liti il notaro fiorentino Lorenzo
di Ubertuccio. Giotto doveva di nuovo lasciare la
città? Il Supino assegna agli anni 1318-20 le pit-
ture nella cappella fiorentina dei Bardi in S. Croce,
ed accenna alla possibilità che Giotto si recasse
anche a Ravenna per dipingere nella chiesa di
S. Francesco.2
Forse questi e molti altri quesiti intorno alla
cronologia delle opere del grande maestro potreb-
bero ottenere una risoluzione sicura per mezzo di
indagini accurate nei protocolli notarili delle città,
nelle quali Giotto lavorò, perchè essi forse conser-
vano nuovi ricordi della vita del grande padre della
pittura italiana. Quei protocolli sono vere crona-
che giornaliere e complete della vita giuridica cit-
tadina, ed in generale sono studiati soltanto da
chi, come lo scrivente, si occupa della storia del
diritto. Ma essi rispecchiano tutte le forme di atti-
vità del loro tempo. Sono fonti preziose per la storia
civile, politica, economica e giuridica; ma lo sono
altresì per la storia del costume e per la storia
della cultura intellettuale e dell'arte.
Firenze, aprile 1923.
Luigi Chiappflli.
1 Supino, op. cit., p. 316.
2 Supino, op. cit., p. 316.
Nel prossimo fascicolo de L'ARTE si pubblicheranno II " Bollettino Bibliografico „ e le
Recensioni,, che per mancanza di spazio non poterono essere aggiunti a questo numero.
Per i lavori pubblicati ne L'ARTE sono riservati tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica
per l'Italia e per l'estero.
Adolfo Venturi, Direttore.
Roma - Grafìa, S. A. I. Industrie Grafiche - Via Federico Cesi, 45.
LUIGI CHI APPELLI
a Giotto, e che erano rimaste nelle mani della Fi-
lippa da Rieti; il documento parla dei panni di
lino e di lana, dei letti, delle masserizie, dei super-
lectilia e genericamente di altre cose di proprietà
del maestro. Questo dato di fatto concorda bene
col riferire al 1310 l'esecuzione della Navicella e
del polittico, che richiedevano un notevole spazio
di tempo; ma non si spiega, se si attribuisce ad una
seconda dimora di Giotto in Roma per dipingere
il Crocifisso della Minerva, attribuitogli dal Va-
sari, od altre opere di secondo ordine.
Come hanno giustamente osservato il Fedele ed
il Supino,1 dopo il trapasso della sede pontificia
da Roma in Avignone, la basilica vaticana fu tra-
scurata ed andò deperendo; ma, mentre quei due
storici deducono da questa triste condizione di cose,
che una andata di Giotto ad adornarla è inverosi-
mile, possiamo invece pensare, fondandoci sul do-
cumento num. 2 e sul necrologio dello Stefaneschi,
che questi intese a migliorare le condizioni della
basilica stessa. Difatti, il ricordato necrologio non
soltanto dice che lo Stefaneschi fece eseguire a
Giotto la Navicella ed il polittico, ma aggiunge che
fece adornare di pitture la tribuna di S. Pietro e
che tanto s'interessò a favore della basilica vaticana
che troppo lungo sarebbe l'enumerare le beneme-
renze r'el Cardinale slesso. Dal testo del necro-
logio si comprende come, non soltanto si trattava
di dotazioni alla chiesa, ma anche di miglioramenti
di essa. Delle dotazioni di beni il necrologio parla
invece nell'ultima parte del testo.
Adunque, a mio parere, Giotto fu chiamato a
Roma verso il 1310, quando era nella piena ma-
turità della sua vita, della sua arte e della sua
fama, cioè dopo che la sede pontificia fu trasfe-
rita in Avignone;2 quando la nave di San Pietro
sbattuta dalla procella e flagellata dai venti, s'era
incagliata sui lidi di Francia. Se l'immagine della
nave applicata alla Chiesa non fosse consacrata
da secolare tradizione, la Navicella giottesca po-
trebbe sembrare un'allusione a quel grave avve-
1 Villani G., Cron. Vili, 97.
2 a questa conclusione non sembra contrastare l'aspetto
assai giovanile dello Stefaneschi nel polittico di S. Pietro,
perchè lo Stefaneschi fu nominato cardinale ancor giovane
Fin», Aus den Tagen Bonifaz Vili, p. 105). Circa il
1310 lo Stefaneschi era uomo appena maturo, quale appunto
apparisce nel dipinto giottesco.
nimento, che tanto aveva turbato gli animi dei
fedeli.
I documenti num. 3 e 4 contengono due succes-
sivi mandati di procura alle liti, che Giotto fece
in Firenze a due notari della città nel 28 marzo
del 1314, ed a quattro notari, pure fiorentini, nel
13 aprile dello stesso anno. I primi mandatari, onon
avevano potuto, o voluto, accettare il mandato,
mentre Giotto, probabilmente, doveva assentarsi
di nuovo dalla città, e voleva prima assestare i
suoi interessi. Il numero dei mandatari, ed il fatto
che ai secondi mandatari attribuiva la facoltà di
entrare in possesso dei beni dei debitori, accenna
ad interessi assai rilevanti, che Giotto voleva tu-
telati. Dove si diresse Giotto a metà del 1314? Il
Supino suppone che andasse a Verona presso Can-
grande della Scala, ma nulla può essere affermato
con sicurezza.'
Anche nel 14 ottobre 1320 (documento n m. 5)
Giotto era di nuovo in Firenze, ed il quel giorno,
pur non revocando i precedenti mandati, nominò
suo procuratore alle liti il notaro fiorentino Lorenzo
di Ubertuccio. Giotto doveva di nuovo lasciare la
città? Il Supino assegna agli anni 1318-20 le pit-
ture nella cappella fiorentina dei Bardi in S. Croce,
ed accenna alla possibilità che Giotto si recasse
anche a Ravenna per dipingere nella chiesa di
S. Francesco.2
Forse questi e molti altri quesiti intorno alla
cronologia delle opere del grande maestro potreb-
bero ottenere una risoluzione sicura per mezzo di
indagini accurate nei protocolli notarili delle città,
nelle quali Giotto lavorò, perchè essi forse conser-
vano nuovi ricordi della vita del grande padre della
pittura italiana. Quei protocolli sono vere crona-
che giornaliere e complete della vita giuridica cit-
tadina, ed in generale sono studiati soltanto da
chi, come lo scrivente, si occupa della storia del
diritto. Ma essi rispecchiano tutte le forme di atti-
vità del loro tempo. Sono fonti preziose per la storia
civile, politica, economica e giuridica; ma lo sono
altresì per la storia del costume e per la storia
della cultura intellettuale e dell'arte.
Firenze, aprile 1923.
Luigi Chiappflli.
1 Supino, op. cit., p. 316.
2 Supino, op. cit., p. 316.
Nel prossimo fascicolo de L'ARTE si pubblicheranno II " Bollettino Bibliografico „ e le
Recensioni,, che per mancanza di spazio non poterono essere aggiunti a questo numero.
Per i lavori pubblicati ne L'ARTE sono riservati tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica
per l'Italia e per l'estero.
Adolfo Venturi, Direttore.
Roma - Grafìa, S. A. I. Industrie Grafiche - Via Federico Cesi, 45.