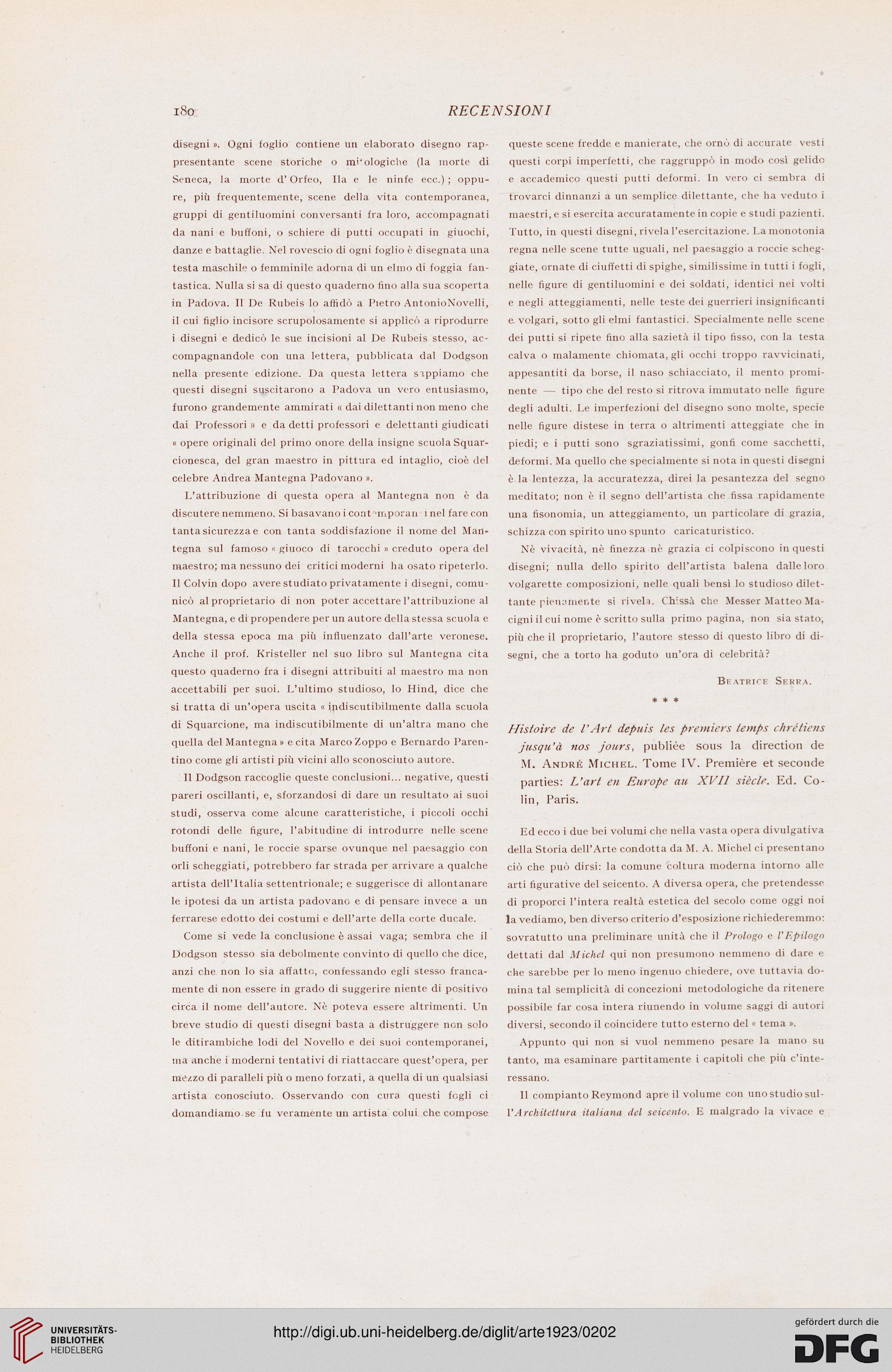RECENSIONI
i.So
disegni ». Ogni foglio contiene un elaborato disegno rap-
presentante scene storielle o micologiche (la inori.1 di
Seneca, la morte d'Orfeo, Ila e le ninfe ecc.); oppu-
re, più frequentemente, scene della vita contemporanea,
gruppi di gentiluomini conversanti fra loro, accompagnati
da nani e buffoni, o schiere di putti occupati in giuochi,
danze e battaglie Nel rovescio di ogni foglio è disegnata una
testa maschile o femminile adorna di un « lino di foggi.i fan
tastica. Nulla si sa di questo quaderno fino alla sua scopri t a
in Padova. Il De Rubeis lo affidò a Pietro AntonioNovelli,
il cui figlio incisore scrupolosamente si applicò a riprodurre
i disegni e dedicò le sue incisioni al De Rubeis stesso, ac-
compagnandole con una lettera, pubblicata dal Dodgson
nella presente edizione. Da questa lettera sappiamo che
questi disegni suscitarono a Padova un vero entusiasmo,
furono grandemente ammirati « dai dilettanti non meno che
dai Professori » e da detti professori e deiettanti giudicati
i opere originali del primo onore della insigne scuola Squar-
cionesca, del gran maestro in pittura ed intaglio, cioè del
celebre Andrea Mantegna Padovano ».
L'attribuzione di questa opera al Mantegna non è da
discutere nemmeno. Si basavano i cont 'mporan 1 nel fare con
tanta sicurezza e con tanta soddisfazione il nome del Man-
tegna sul famoso « giuoco di tarocchi » creduto opera del
maestro; ina nessuno dei critici moderni ha osato ripeterlo.
Il Colvin dopo avere studiato privatamente i disegni, comu-
nicò al proprietario di non poter accettare l'attribuzione al
Mantegna, e di propendere per un autore della stessa scuola e
della stessa epoca ma più influenzato dall'arte veronese.
Anche il prof. Kristeller nel suo libro sul Mantegna cita
questo quaderno fra i disegni attribuiti al maestro ma non
accettabili per suoi. L'ultimo studioso, lo Hind, dice che
si tratta di un'opera uscita « Indiscutibilmente dalla scuola
di Squarcione, ma indiscutibilmente di un'altra mano che
quella del Manti glia » e cita Marco Zoppo e Bernardo Paren-
tino come gli artisti più vicini allo sconosciuto autore.
II Dodgson raccoglie queste conclusioni... negative, questi
pareri oscillanti, e, sforzandosi di dare un resultato ai suoi
studi, osserva come alcune caratteristiche, i piccoli occhi
rotondi delle figure, l'abitudine di introdurre nelle scene
buffoni e nani, le roccie sparse ovunque nel paesaggio con
orli scheggiati, potrebbero far strada per arrivare a qualche
artista dell'Italia settentrionale; e suggerisce di allontanare
le ipotesi da un artista padovano e di pensare invece a un
ferrarese edotto dei costumi e dell'arte della corte ducale.
Come si vede la conclusione è assai vaga; sembra che il
Dodgson stesso sia debolmente convinto di quello che dice,
anzi che non lo sia affatto, confessando egli stesso franca-
mente di non essere in grado di suggerire niente di positivo
circa il ninne dell'autore. Nè poteva essere altrimenti. Un
breve studio di questi disegni basta a distruggere non solo
le ditirambiche lodi del Novello e dei suoi contemporanei,
ma anche i moderni tentativi di riattaccare quest'opera, per
mezzo di paralleli più o meno forzati, a quella di un qualsiasi
artista conosciuto. Osservando con cura questi fogli ci
domandiamo se fu veramente un artista colui che compose
questi' sicue fredde e manierate, che ornò di accurate vesti
questi corpi imperfetti, die raggruppò in modo cosi gelido
e accademico questi putti deformi. In vero ci sembra di
trovarci dinnanzi a un semplice dilettante, che ha veduto i
maestri, e si esercita accuratamente in copie e studi pazienti.
Tutto, in questi disegni, rivela l'esercitazione. La monotonia
regna nelle scene tutte uguali, nel paesaggio a roccie scheg-
giate, uniate di ciuffetti di spighe, similissime in tutti i fogli,
nelle figure di gentiluomini e dei soldati, identici nei volti
e negli atteggiamenti, nelle teste ilei guerrieri insignificanti
e volgari, sotto gli elmi fantastici. Specialmente nelle scene
dei putti si ripete fino alla sazietà il tipo fisso, con la testa
calva o malamente chiomata, gli occhi troppo ravvicinati,
appesantiti da borse, il naso schiacciato, il mento promi-
nente — tipo che del resto si ritrova immutato nelle figure
degli adulti, l.e imperfezioni del disegno sono molte, specie
nelle figure distese in terra o altrimenti atteggiate che in
piedi; e i putti sono Sgraziati Stimi, gonfi come sacchetti,
deformi. Ma quello che specialmente si nota in questi disegni
è la lentezza, la accuratezza, direi la pesantezza del segno
meditato; non è il segno dell'artista che fissa rapidamente
una tìsonomia, un atteggiamento, un particolare di grazia,
schizza con spirito uno spunto caricaturistico.
Nè vivacità, nè finezza nè grazia ci colpiscono in questi
disegni; nulla dello spirito dell'artista balena dalle loro
volgarette composizioni, nelle quali bensì lo studioso dilet-
tante pienamente si riveli. Ch:ssà che Messer Matteo Ma-
cigni il cui nome è scritto sulla primo pagina, non sia stato,
più che il proprietario, l'autore stesso di questo libro di di-
segni, che a torto ha goduto un'ora di celebrità?
Beatrice Serra.
* * •
Ilisloire de l'Art depuis les premier* Umps chrétiens
jusgu'à no* jours, pùbliée sous la direction <U-
M. André Michel. Tome IV. Première et seconde
parties: L'art en Europe au XVII siècle. Ed. Co-
lin, Paris.
Ed ecco i due bei volumi che nella vasta opera divulgativa
della Storia dell'Arte condotta da M. A. Michel ci presentano
ciò che può dirsi: la comune cultura moderna intorno alle
arti figurative del seicento. A diversa opera, che pretendesse
di proporci l'intera realtà estetici del secolo coinè oggi noi
la vediamo, ben diverso criterio d'esposizione richiederemmo:
sovratutto una preliminare unità che il Prologo e l'Epilogo
dettati dal Michel qui non presumono nemmeno di dare e
che sarebbe per lo meno ingenuo chiedere, ove tuttavia do-
mina tal semplicità di concezioni metodologiche da ritenere
possibile far cosa intera riunendo in volume saggi di autori
diversi, secondo il coincidere tutto esterno del « tema ».
Appunto qui non si vuol nemmeno pesare la mano su
tanto, ma esaminare partitamente i capitoli che più c'inte-
ressano.
Il compianto Reymond apre il volume con unostudiosul-
l'Architettura italiana del seicento. E malgrado la vivace e
i.So
disegni ». Ogni foglio contiene un elaborato disegno rap-
presentante scene storielle o micologiche (la inori.1 di
Seneca, la morte d'Orfeo, Ila e le ninfe ecc.); oppu-
re, più frequentemente, scene della vita contemporanea,
gruppi di gentiluomini conversanti fra loro, accompagnati
da nani e buffoni, o schiere di putti occupati in giuochi,
danze e battaglie Nel rovescio di ogni foglio è disegnata una
testa maschile o femminile adorna di un « lino di foggi.i fan
tastica. Nulla si sa di questo quaderno fino alla sua scopri t a
in Padova. Il De Rubeis lo affidò a Pietro AntonioNovelli,
il cui figlio incisore scrupolosamente si applicò a riprodurre
i disegni e dedicò le sue incisioni al De Rubeis stesso, ac-
compagnandole con una lettera, pubblicata dal Dodgson
nella presente edizione. Da questa lettera sappiamo che
questi disegni suscitarono a Padova un vero entusiasmo,
furono grandemente ammirati « dai dilettanti non meno che
dai Professori » e da detti professori e deiettanti giudicati
i opere originali del primo onore della insigne scuola Squar-
cionesca, del gran maestro in pittura ed intaglio, cioè del
celebre Andrea Mantegna Padovano ».
L'attribuzione di questa opera al Mantegna non è da
discutere nemmeno. Si basavano i cont 'mporan 1 nel fare con
tanta sicurezza e con tanta soddisfazione il nome del Man-
tegna sul famoso « giuoco di tarocchi » creduto opera del
maestro; ina nessuno dei critici moderni ha osato ripeterlo.
Il Colvin dopo avere studiato privatamente i disegni, comu-
nicò al proprietario di non poter accettare l'attribuzione al
Mantegna, e di propendere per un autore della stessa scuola e
della stessa epoca ma più influenzato dall'arte veronese.
Anche il prof. Kristeller nel suo libro sul Mantegna cita
questo quaderno fra i disegni attribuiti al maestro ma non
accettabili per suoi. L'ultimo studioso, lo Hind, dice che
si tratta di un'opera uscita « Indiscutibilmente dalla scuola
di Squarcione, ma indiscutibilmente di un'altra mano che
quella del Manti glia » e cita Marco Zoppo e Bernardo Paren-
tino come gli artisti più vicini allo sconosciuto autore.
II Dodgson raccoglie queste conclusioni... negative, questi
pareri oscillanti, e, sforzandosi di dare un resultato ai suoi
studi, osserva come alcune caratteristiche, i piccoli occhi
rotondi delle figure, l'abitudine di introdurre nelle scene
buffoni e nani, le roccie sparse ovunque nel paesaggio con
orli scheggiati, potrebbero far strada per arrivare a qualche
artista dell'Italia settentrionale; e suggerisce di allontanare
le ipotesi da un artista padovano e di pensare invece a un
ferrarese edotto dei costumi e dell'arte della corte ducale.
Come si vede la conclusione è assai vaga; sembra che il
Dodgson stesso sia debolmente convinto di quello che dice,
anzi che non lo sia affatto, confessando egli stesso franca-
mente di non essere in grado di suggerire niente di positivo
circa il ninne dell'autore. Nè poteva essere altrimenti. Un
breve studio di questi disegni basta a distruggere non solo
le ditirambiche lodi del Novello e dei suoi contemporanei,
ma anche i moderni tentativi di riattaccare quest'opera, per
mezzo di paralleli più o meno forzati, a quella di un qualsiasi
artista conosciuto. Osservando con cura questi fogli ci
domandiamo se fu veramente un artista colui che compose
questi' sicue fredde e manierate, che ornò di accurate vesti
questi corpi imperfetti, die raggruppò in modo cosi gelido
e accademico questi putti deformi. In vero ci sembra di
trovarci dinnanzi a un semplice dilettante, che ha veduto i
maestri, e si esercita accuratamente in copie e studi pazienti.
Tutto, in questi disegni, rivela l'esercitazione. La monotonia
regna nelle scene tutte uguali, nel paesaggio a roccie scheg-
giate, uniate di ciuffetti di spighe, similissime in tutti i fogli,
nelle figure di gentiluomini e dei soldati, identici nei volti
e negli atteggiamenti, nelle teste ilei guerrieri insignificanti
e volgari, sotto gli elmi fantastici. Specialmente nelle scene
dei putti si ripete fino alla sazietà il tipo fisso, con la testa
calva o malamente chiomata, gli occhi troppo ravvicinati,
appesantiti da borse, il naso schiacciato, il mento promi-
nente — tipo che del resto si ritrova immutato nelle figure
degli adulti, l.e imperfezioni del disegno sono molte, specie
nelle figure distese in terra o altrimenti atteggiate che in
piedi; e i putti sono Sgraziati Stimi, gonfi come sacchetti,
deformi. Ma quello che specialmente si nota in questi disegni
è la lentezza, la accuratezza, direi la pesantezza del segno
meditato; non è il segno dell'artista che fissa rapidamente
una tìsonomia, un atteggiamento, un particolare di grazia,
schizza con spirito uno spunto caricaturistico.
Nè vivacità, nè finezza nè grazia ci colpiscono in questi
disegni; nulla dello spirito dell'artista balena dalle loro
volgarette composizioni, nelle quali bensì lo studioso dilet-
tante pienamente si riveli. Ch:ssà che Messer Matteo Ma-
cigni il cui nome è scritto sulla primo pagina, non sia stato,
più che il proprietario, l'autore stesso di questo libro di di-
segni, che a torto ha goduto un'ora di celebrità?
Beatrice Serra.
* * •
Ilisloire de l'Art depuis les premier* Umps chrétiens
jusgu'à no* jours, pùbliée sous la direction <U-
M. André Michel. Tome IV. Première et seconde
parties: L'art en Europe au XVII siècle. Ed. Co-
lin, Paris.
Ed ecco i due bei volumi che nella vasta opera divulgativa
della Storia dell'Arte condotta da M. A. Michel ci presentano
ciò che può dirsi: la comune cultura moderna intorno alle
arti figurative del seicento. A diversa opera, che pretendesse
di proporci l'intera realtà estetici del secolo coinè oggi noi
la vediamo, ben diverso criterio d'esposizione richiederemmo:
sovratutto una preliminare unità che il Prologo e l'Epilogo
dettati dal Michel qui non presumono nemmeno di dare e
che sarebbe per lo meno ingenuo chiedere, ove tuttavia do-
mina tal semplicità di concezioni metodologiche da ritenere
possibile far cosa intera riunendo in volume saggi di autori
diversi, secondo il coincidere tutto esterno del « tema ».
Appunto qui non si vuol nemmeno pesare la mano su
tanto, ma esaminare partitamente i capitoli che più c'inte-
ressano.
Il compianto Reymond apre il volume con unostudiosul-
l'Architettura italiana del seicento. E malgrado la vivace e