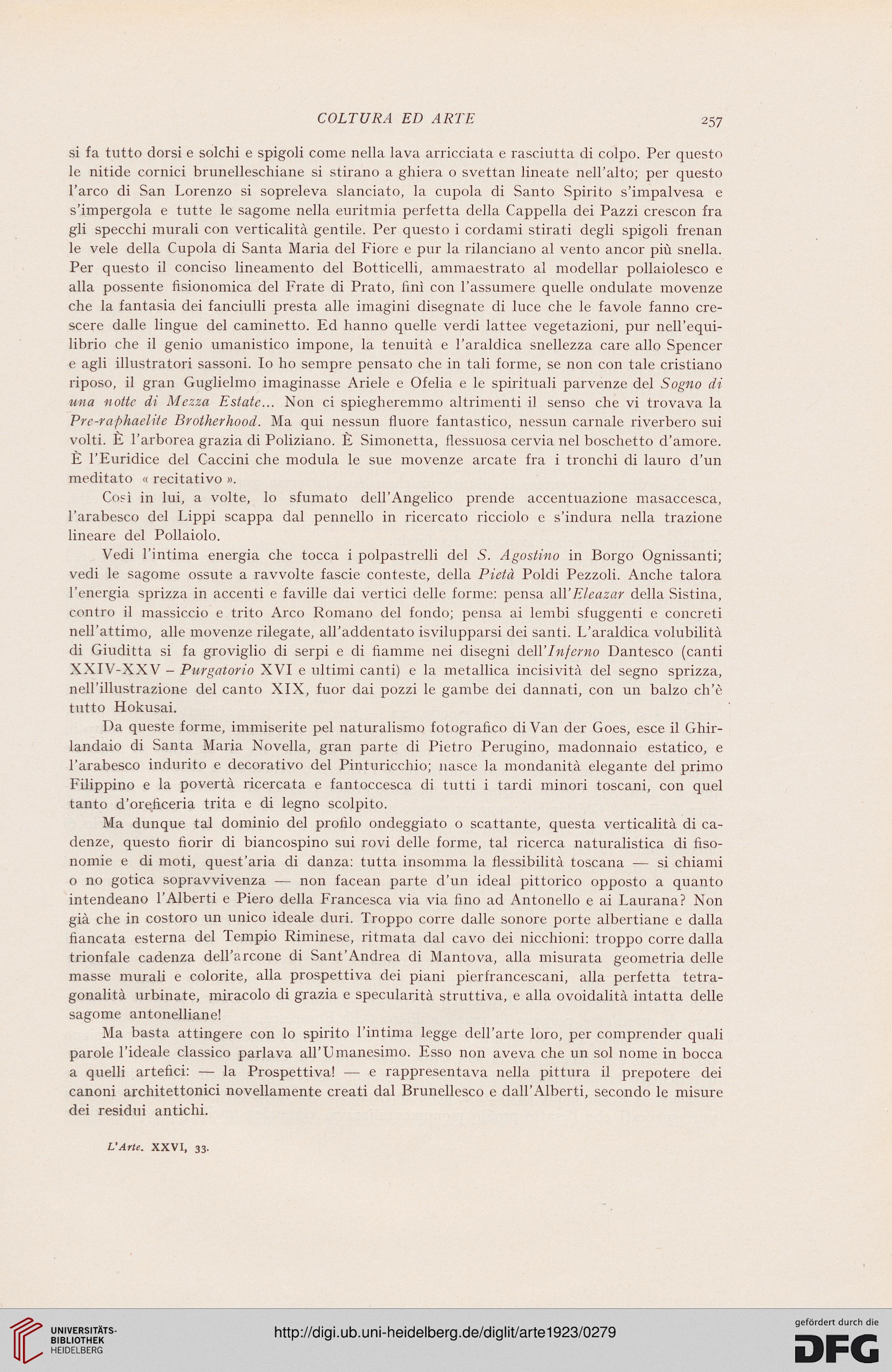COLTURA ED ARTE
257
si fa tutto dorsi e solchi e spigoli come nella lava arricciata e rasciutta di colpo. Per questo
le nitide cornici brunelleschiane si stirano a ghiera o svettan lineate nell'alto; per questo
l'arco di San Lorenzo si sopreleva slanciato, la cupola di Santo Spirito s'impalvesa e
s'impergola e tutte le sagome nella euritmia perfetta della Cappella dei Pazzi crescon fra
gli specchi murali con verticalità gentile. Per questo i cordami stirati degli spigoli frenan
le vele della Cupola di Santa Maria del Fiore e pur la rilanciano al vento ancor più snella.
Per questo il conciso lineamento del Botticelli, ammaestrato al modellar pollaiolesco e
alla possente fisionomica del Frate di Prato, finì con l'assumere quelle ondulate movenze
che la fantasia dei fanciulli presta alle imagini disegnate di luce che le favole fanno cre-
scere dalle lingue del caminetto. Ed hanno quelle verdi lattee vegetazioni, pur nell'equi-
librio che il genio umanistico impone, la tenuità e l'araldica snellezza care allo Spencer
e agli illustratori sassoni. Io ho sempre pensato che in tali forme, se non con tale cristiano
riposo, il gran Guglielmo imaginasse Ariele e Ofelia e le spirituali parvenze del Sogno di
una notte di Mezza Estate... Non ci spiegheremmo altrimenti il senso che vi trovava la
Pre-raphaeliic Brotherhood. Ma qui nessun fluore fantastico, nessun carnale riverbero sui
volti. È l'arborea grazia di Poliziano. È Simonetta, flessuosa cervia nel boschetto d'amore.
È l'Euridice del Caccini che modula le sue movenze arcate fra i tronchi di lauro d'un
meditato « recitativo ».
Così in lui, a volte, lo sfumato dell'Angelico prende accentuazione masaccesca,
l'arabesco del Lippi scappa dal pennello in ricercato ricciolo e s'indura nella trazione
lineare del Pollaiolo.
Vedi l'intima energia che tocca i polpastrelli del S. Agostino in Borgo Ognissanti;
vedi le sagome ossute a ravvolte fascie conteste, della Pietà Poldi Pezzoli. Anche talora
l'energia sprizza in accenti e faville dai vertici delle forme: pensa all'Eleazar della Sistina,
contro il massiccio e trito Arco Romano del fondo; pensa ai lembi sfuggenti e concreti
nell'attimo, alle movenze rilegate, all'addentato isvilupparsi dei santi. L'araldica volubilità
di Giuditta si fa groviglio di serpi e di fiamme nei disegni dell'Inferno Dantesco (canti
XXIV-XXV - Purgatorio XVI e ultimi canti) e la metallica incisività del segno sprizza,
nell'illustrazione del canto XIX, fuor dai pozzi le gambe dei dannati, con un balzo ch'è
tutto Hokusai.
Da queste forme, immiserite pel naturalismo fotografico diVan der Goes, esce il Ghir-
landaio di Santa Maria Novella, gran parte di Pietro Perugino, madonnaio estatico, e
l'arabesco indurito e decorativo del Pinturicchio; nasce la mondanità elegante del primo
Filippino e la povertà ricercata e fantoccesca di tutti i tardi minori toscani, con quel
tanto d'oreficeria trita e di legno scolpito.
Ma dunque tal dominio del profilo ondeggiato o scattante, questa verticalità di ca-
denze, questo fiorir di biancospino sui rovi delle forme, tal ricerca naturalistica di fiso-
nomie e di moti, quest'aria di danza: tutta insomma la flessibilità toscana — si chiami
0 no gotica sopravvivenza — non facean parte d'un ideal pittorico opposto a quanto
intendeano l'Alberti e Piero della Francesca via via fino ad Antonello e ai Laurana? Non
già che in costoro un unico ideale duri. Troppo corre dalle sonore porte albertiane e dalla
fiancata esterna del Tempio Riminese, ritmata dal cavo dei nicchioni: troppo corre dalla
trionfale cadenza dell'arcone di Sant'Andrea di Mantova, alla misurata geometria delle
masse murali e colorite, alla prospettiva dei piani pierfrancescani, alla perfetta tetra-
gonalità urbinate, miracolo di grazia e specularità struttiva, e alla ovoidalità intatta delle
sagome antonelliane!
Ma basta attingere con lo spirito l'intima legge dell'arte loro, per comprender quali
parole l'ideale classico parlava all'Umanesimo. Esso non aveva che un sol nome in bocca
a quelli artefici: — la Prospettiva! — e rappresentava nella pittura il prepotere dei
canoni architettonici novellamente creati dal Brunellesco e dall'Alberti, secondo le misure
dei residui antichi.
L'Arte. XXVI, 33.
257
si fa tutto dorsi e solchi e spigoli come nella lava arricciata e rasciutta di colpo. Per questo
le nitide cornici brunelleschiane si stirano a ghiera o svettan lineate nell'alto; per questo
l'arco di San Lorenzo si sopreleva slanciato, la cupola di Santo Spirito s'impalvesa e
s'impergola e tutte le sagome nella euritmia perfetta della Cappella dei Pazzi crescon fra
gli specchi murali con verticalità gentile. Per questo i cordami stirati degli spigoli frenan
le vele della Cupola di Santa Maria del Fiore e pur la rilanciano al vento ancor più snella.
Per questo il conciso lineamento del Botticelli, ammaestrato al modellar pollaiolesco e
alla possente fisionomica del Frate di Prato, finì con l'assumere quelle ondulate movenze
che la fantasia dei fanciulli presta alle imagini disegnate di luce che le favole fanno cre-
scere dalle lingue del caminetto. Ed hanno quelle verdi lattee vegetazioni, pur nell'equi-
librio che il genio umanistico impone, la tenuità e l'araldica snellezza care allo Spencer
e agli illustratori sassoni. Io ho sempre pensato che in tali forme, se non con tale cristiano
riposo, il gran Guglielmo imaginasse Ariele e Ofelia e le spirituali parvenze del Sogno di
una notte di Mezza Estate... Non ci spiegheremmo altrimenti il senso che vi trovava la
Pre-raphaeliic Brotherhood. Ma qui nessun fluore fantastico, nessun carnale riverbero sui
volti. È l'arborea grazia di Poliziano. È Simonetta, flessuosa cervia nel boschetto d'amore.
È l'Euridice del Caccini che modula le sue movenze arcate fra i tronchi di lauro d'un
meditato « recitativo ».
Così in lui, a volte, lo sfumato dell'Angelico prende accentuazione masaccesca,
l'arabesco del Lippi scappa dal pennello in ricercato ricciolo e s'indura nella trazione
lineare del Pollaiolo.
Vedi l'intima energia che tocca i polpastrelli del S. Agostino in Borgo Ognissanti;
vedi le sagome ossute a ravvolte fascie conteste, della Pietà Poldi Pezzoli. Anche talora
l'energia sprizza in accenti e faville dai vertici delle forme: pensa all'Eleazar della Sistina,
contro il massiccio e trito Arco Romano del fondo; pensa ai lembi sfuggenti e concreti
nell'attimo, alle movenze rilegate, all'addentato isvilupparsi dei santi. L'araldica volubilità
di Giuditta si fa groviglio di serpi e di fiamme nei disegni dell'Inferno Dantesco (canti
XXIV-XXV - Purgatorio XVI e ultimi canti) e la metallica incisività del segno sprizza,
nell'illustrazione del canto XIX, fuor dai pozzi le gambe dei dannati, con un balzo ch'è
tutto Hokusai.
Da queste forme, immiserite pel naturalismo fotografico diVan der Goes, esce il Ghir-
landaio di Santa Maria Novella, gran parte di Pietro Perugino, madonnaio estatico, e
l'arabesco indurito e decorativo del Pinturicchio; nasce la mondanità elegante del primo
Filippino e la povertà ricercata e fantoccesca di tutti i tardi minori toscani, con quel
tanto d'oreficeria trita e di legno scolpito.
Ma dunque tal dominio del profilo ondeggiato o scattante, questa verticalità di ca-
denze, questo fiorir di biancospino sui rovi delle forme, tal ricerca naturalistica di fiso-
nomie e di moti, quest'aria di danza: tutta insomma la flessibilità toscana — si chiami
0 no gotica sopravvivenza — non facean parte d'un ideal pittorico opposto a quanto
intendeano l'Alberti e Piero della Francesca via via fino ad Antonello e ai Laurana? Non
già che in costoro un unico ideale duri. Troppo corre dalle sonore porte albertiane e dalla
fiancata esterna del Tempio Riminese, ritmata dal cavo dei nicchioni: troppo corre dalla
trionfale cadenza dell'arcone di Sant'Andrea di Mantova, alla misurata geometria delle
masse murali e colorite, alla prospettiva dei piani pierfrancescani, alla perfetta tetra-
gonalità urbinate, miracolo di grazia e specularità struttiva, e alla ovoidalità intatta delle
sagome antonelliane!
Ma basta attingere con lo spirito l'intima legge dell'arte loro, per comprender quali
parole l'ideale classico parlava all'Umanesimo. Esso non aveva che un sol nome in bocca
a quelli artefici: — la Prospettiva! — e rappresentava nella pittura il prepotere dei
canoni architettonici novellamente creati dal Brunellesco e dall'Alberti, secondo le misure
dei residui antichi.
L'Arte. XXVI, 33.