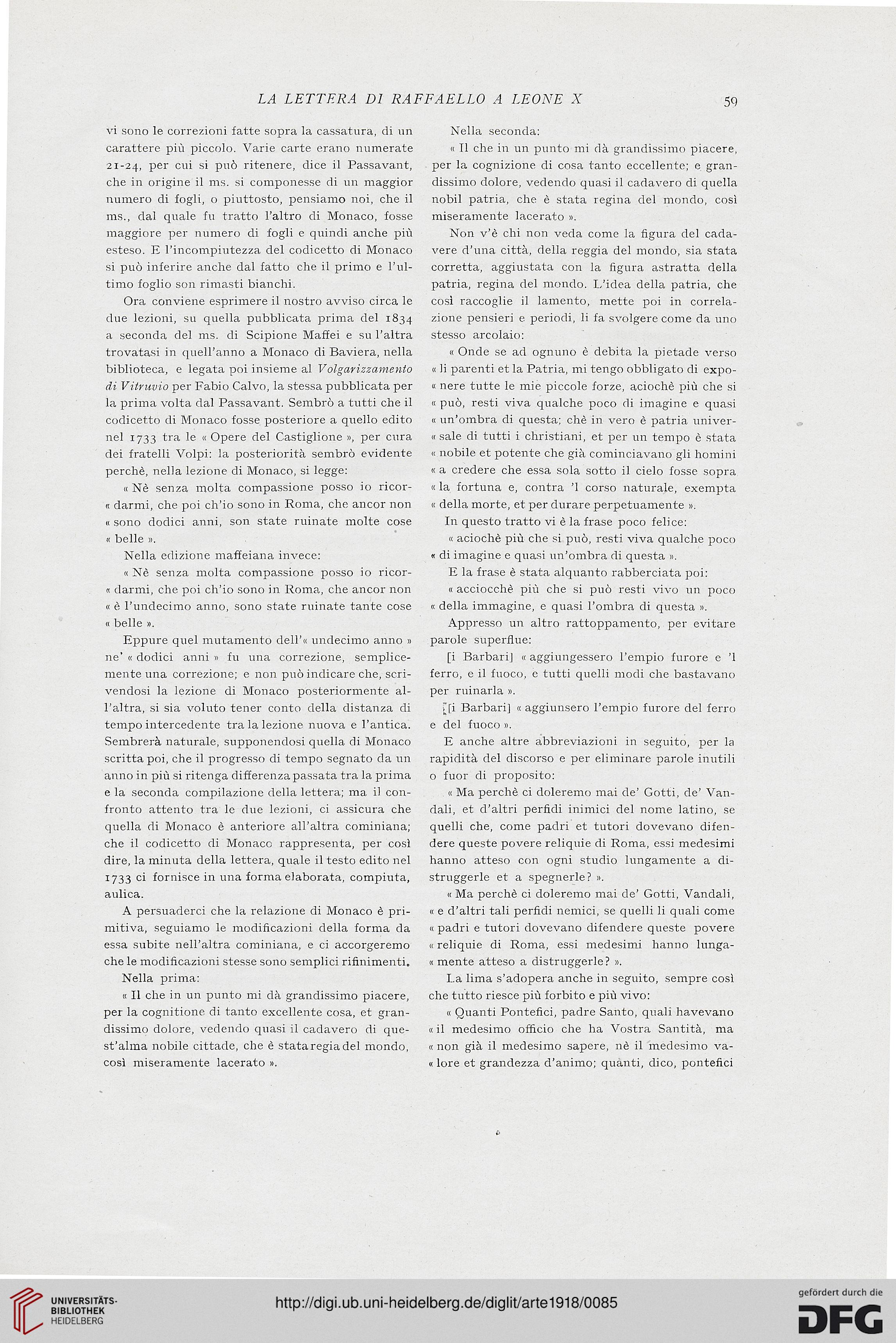LA LETTERA DI RAFFAELLO A LEONE X
59
vi sono le correzioni fatte sopra la cassatura, di un
carattere più piccolo. Varie carte erano numerate
21-24, Per cm si P11^ ritenere, dice il Passavant,
che in origine il ms. si componesse di un maggior
numero di fogli, o piuttosto, pensiamo noi, che il
ms., dal quale fu tratto l'altro di Monaco, fosse
maggiore per numero di fogli e quindi anche più
esteso. E l'incompiutezza del codicetto di Monaco
si può inferire anche dal fatto che il primo e l'ul-
timo foglio son rimasti bianchi.
Ora conviene esprimere il nostro avviso circa le
due lezioni, su quella pubblicata prima del 1834
a seconda del ms. di Scipione Maffei e su l'altra
trovatasi in quell'anno a Monaco di Baviera, nella
biblioteca, e legata poi insieme al Volgarizzamento
di Vitruvìo per Fabio Calvo, la stessa pubblicata per
la prima volta dal Passavant. Sembrò a tutti che il
codicetto di Monaco fosse posteriore a quello edito
nel 1733 tra le « Opere del Castiglione », per cura
dei fratelli Volpi: la posteriorità sembrò evidente
perchè, nella lezione di Monaco, si legge:
« Nè senza molta compassione posso io ricor-
« darmi, che poi ch'io sono in Roma, che ancor non
« sono dodici anni, son state ruinate molte cose
« belle ».
Nella edizione maffeiana invece:
« Nè senza molta compassione posso io ricor-
ri darmi, che poi ch'io sono in Roma, che ancor non
n è l'undecimo anno, sono state ruinate tante cose
« belle ».
Eppure quel mutamento dell'« undecimo anno »
ne' « dodici anni » fu una correzione, semplice-
mente una correzione; e non può indicare che, scri-
vendosi la lezione di Monaco posteriormente al-
l'altra, si sia voluto tener conto della distanza di
tempo intercedente tra la lezione nuova e l'antica.
Sembrerà naturale, supponendosi quella di Monaco
scritta poi, che il progresso di tempo segnato da un
anno in più si ritenga differenza passata tra la prima
e la seconda compilazione della lettera: ma il con-
fronto attento tra le due lezioni, ci assicura che
quella di Monaco è anteriore all'altra cominiana;
che il codicetto di Monaco rappresenta, per così
dire, la minuta della lettera, quale il testo edito nel
1733 ci fornisce in una forma elaborata, compiuta,
aulica.
A persuaderci che la relazione di Monaco è pri-
mitiva, seguiamo le modificazioni della forma da
essa subite nell'altra cominiana, e ci accorgeremo
che le modificazioni stesse sono semplici rifinimenti.
Nella prima:
« Il che in un punto mi dà grandissimo piacere,
per la cognitione di tanto excellente cosa, et gran-
dissimo dolore, vedendo quasi il cadavero di que-
st'alma nobile cittade, che è stataregiadel mondo,
cosi miseramente lacerato ».
Nella seconda:
« Il che in un punto mi dà grandissimo piacere,
per la cognizione di cosa tanto eccellente; e gran-
dissimo dolore, vedendo quasi il cadavero di quella
nobil patria, che è stata regina del mondo, così
miseramente lacerato ».
Non v'è chi non veda come la figura del cada-
vere d'una città, della reggia del mondo, sia stata
corretta, aggiustata con la figura astratta della
patria, regina del mondo. L'idea della patria, che
così raccoglie il lamento, mette poi in correla-
zione pensieri e periodi, li fa svolgere come da uno
stesso arcolaio:
« Onde se ad ognuno è debita la pietade verso
« li parenti et la Patria, mi tengo obbligato di expo-
fi nere tutte le mie piccole forze, aciochè più che si
« può, resti viva qualche poco di imagine e quasi
« un'ombra di questa; chè in vero è patria univer-
« sale di tutti i christiani, et per un tempo è stata
« nobile et potente che già cominciavano gli nomini
« a credere che essa sola sotto il cielo fosse sopra
« la fortuna e, contra '1 corso naturale, exempta
« della morte, et per durare perpetuamente ».
In questo tratto vi è la frase poco felice:
« aciochè più che si può, resti viva qualche poco
« di imagine e quasi un'ombra di questa ».
E la frase è stata alquanto rabberciata poi:
« acciocché più che si può resti vivo un poco
« della immagine, e quasi l'ombra di questa ».
Appresso un altro rattoppamento, per evitare
parole superflue:
[i Barbari] « aggiungessero l'empio furore e '1
ferro, e il fuoco, e tutti quelli modi che bastavano
per minarla ».
[[i Barbari] « aggiunsero l'empio furore del ferro
e del fuoco ».
E anche altre abbreviazioni in seguito, per la
rapidità del discorso e per eliminare parole inutili
o fuor di proposito:
« Ma perchè ci doteremo mai de' Gotti, de' Van-
dali, et d'altri perfidi inimici del nome latino, se
quelli che, come padri et tutori dovevano difen-
dere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi
hanno atteso con ogni studio lungamente 11 di-
struggerle et a spegnerle? ».
« Ma perchè ci doleremo mai de' Gotti, Vandali,
« e d'altri tali perfidi nemici, se quelli li quali come
« padri e tutori dovevano difendere queste povere
« reliquie di Roma, essi medesimi hanno lunga-
« mente atteso a distruggerle? ».
La lima s'adopera anche in seguito, sempre così
che tutto riesce più forbito e più vivo:
« Quanti Pontefici, padre Santo, quali havevano
«il medesimo officio che ha Vostra Santità, ma
« non già il medesimo sapere, nè il medesimo va-
ie lore et grandezza d'animo; quanti, dico, pontefici
59
vi sono le correzioni fatte sopra la cassatura, di un
carattere più piccolo. Varie carte erano numerate
21-24, Per cm si P11^ ritenere, dice il Passavant,
che in origine il ms. si componesse di un maggior
numero di fogli, o piuttosto, pensiamo noi, che il
ms., dal quale fu tratto l'altro di Monaco, fosse
maggiore per numero di fogli e quindi anche più
esteso. E l'incompiutezza del codicetto di Monaco
si può inferire anche dal fatto che il primo e l'ul-
timo foglio son rimasti bianchi.
Ora conviene esprimere il nostro avviso circa le
due lezioni, su quella pubblicata prima del 1834
a seconda del ms. di Scipione Maffei e su l'altra
trovatasi in quell'anno a Monaco di Baviera, nella
biblioteca, e legata poi insieme al Volgarizzamento
di Vitruvìo per Fabio Calvo, la stessa pubblicata per
la prima volta dal Passavant. Sembrò a tutti che il
codicetto di Monaco fosse posteriore a quello edito
nel 1733 tra le « Opere del Castiglione », per cura
dei fratelli Volpi: la posteriorità sembrò evidente
perchè, nella lezione di Monaco, si legge:
« Nè senza molta compassione posso io ricor-
« darmi, che poi ch'io sono in Roma, che ancor non
« sono dodici anni, son state ruinate molte cose
« belle ».
Nella edizione maffeiana invece:
« Nè senza molta compassione posso io ricor-
ri darmi, che poi ch'io sono in Roma, che ancor non
n è l'undecimo anno, sono state ruinate tante cose
« belle ».
Eppure quel mutamento dell'« undecimo anno »
ne' « dodici anni » fu una correzione, semplice-
mente una correzione; e non può indicare che, scri-
vendosi la lezione di Monaco posteriormente al-
l'altra, si sia voluto tener conto della distanza di
tempo intercedente tra la lezione nuova e l'antica.
Sembrerà naturale, supponendosi quella di Monaco
scritta poi, che il progresso di tempo segnato da un
anno in più si ritenga differenza passata tra la prima
e la seconda compilazione della lettera: ma il con-
fronto attento tra le due lezioni, ci assicura che
quella di Monaco è anteriore all'altra cominiana;
che il codicetto di Monaco rappresenta, per così
dire, la minuta della lettera, quale il testo edito nel
1733 ci fornisce in una forma elaborata, compiuta,
aulica.
A persuaderci che la relazione di Monaco è pri-
mitiva, seguiamo le modificazioni della forma da
essa subite nell'altra cominiana, e ci accorgeremo
che le modificazioni stesse sono semplici rifinimenti.
Nella prima:
« Il che in un punto mi dà grandissimo piacere,
per la cognitione di tanto excellente cosa, et gran-
dissimo dolore, vedendo quasi il cadavero di que-
st'alma nobile cittade, che è stataregiadel mondo,
cosi miseramente lacerato ».
Nella seconda:
« Il che in un punto mi dà grandissimo piacere,
per la cognizione di cosa tanto eccellente; e gran-
dissimo dolore, vedendo quasi il cadavero di quella
nobil patria, che è stata regina del mondo, così
miseramente lacerato ».
Non v'è chi non veda come la figura del cada-
vere d'una città, della reggia del mondo, sia stata
corretta, aggiustata con la figura astratta della
patria, regina del mondo. L'idea della patria, che
così raccoglie il lamento, mette poi in correla-
zione pensieri e periodi, li fa svolgere come da uno
stesso arcolaio:
« Onde se ad ognuno è debita la pietade verso
« li parenti et la Patria, mi tengo obbligato di expo-
fi nere tutte le mie piccole forze, aciochè più che si
« può, resti viva qualche poco di imagine e quasi
« un'ombra di questa; chè in vero è patria univer-
« sale di tutti i christiani, et per un tempo è stata
« nobile et potente che già cominciavano gli nomini
« a credere che essa sola sotto il cielo fosse sopra
« la fortuna e, contra '1 corso naturale, exempta
« della morte, et per durare perpetuamente ».
In questo tratto vi è la frase poco felice:
« aciochè più che si può, resti viva qualche poco
« di imagine e quasi un'ombra di questa ».
E la frase è stata alquanto rabberciata poi:
« acciocché più che si può resti vivo un poco
« della immagine, e quasi l'ombra di questa ».
Appresso un altro rattoppamento, per evitare
parole superflue:
[i Barbari] « aggiungessero l'empio furore e '1
ferro, e il fuoco, e tutti quelli modi che bastavano
per minarla ».
[[i Barbari] « aggiunsero l'empio furore del ferro
e del fuoco ».
E anche altre abbreviazioni in seguito, per la
rapidità del discorso e per eliminare parole inutili
o fuor di proposito:
« Ma perchè ci doteremo mai de' Gotti, de' Van-
dali, et d'altri perfidi inimici del nome latino, se
quelli che, come padri et tutori dovevano difen-
dere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi
hanno atteso con ogni studio lungamente 11 di-
struggerle et a spegnerle? ».
« Ma perchè ci doleremo mai de' Gotti, Vandali,
« e d'altri tali perfidi nemici, se quelli li quali come
« padri e tutori dovevano difendere queste povere
« reliquie di Roma, essi medesimi hanno lunga-
« mente atteso a distruggerle? ».
La lima s'adopera anche in seguito, sempre così
che tutto riesce più forbito e più vivo:
« Quanti Pontefici, padre Santo, quali havevano
«il medesimo officio che ha Vostra Santità, ma
« non già il medesimo sapere, nè il medesimo va-
ie lore et grandezza d'animo; quanti, dico, pontefici