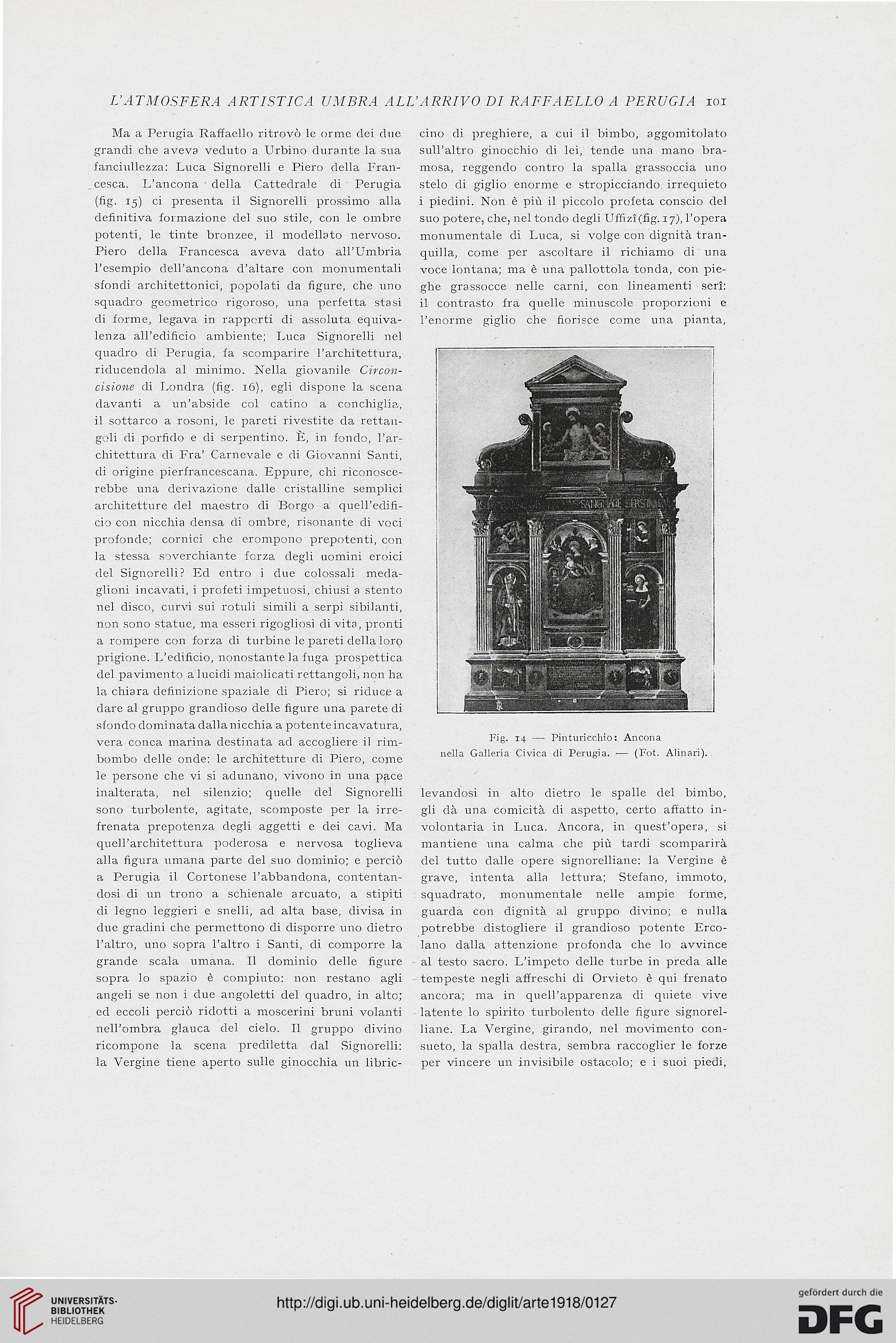L'ATMOSFERA ARTISTICA UMBRA ALL'ARRIVO DI RAFFAELLO A PERUGIA 101
Ma a Perugia Raffaello ritrovò le orme dei due
grandi che aveva veduto a Urbino durante la sua
fanciullezza: Luca Signorelli e Piero della Fran-
cesca. L'ancona ■ della Cattedrale di Perugia
(fig. 15) ci presenta il Signorelli prossimo alla
definitiva formazione del suo stile, con le ombre
potenti, le tinte bronzee, il modellato nervoso.
Piero della Francesca aveva dato all'Umbria
l'esempio dell'ancona d'altare con monumentali
sfondi architettonici, popolati da figure, che uno
squadro geometrico rigoroso, una perfetta stasi
di forme, legava in rapporti di assoluta equiva-
lenza all'edificio ambiente; Luca Signorelli nel
quadro di Perugia, fa scomparire l'architettura,
riducendola al minimo. Nella giovanile Circon-
cisione di Londra (fig. 16), egli dispone la scena
davanti a un'abside col catino a conchiglia,
il sottarco a rosoni, le pareti rivestite da rettan-
goli di porfido e di serpentino. E, in fondo, l'ar-
chitettura di Fra' Carnevale e di Giovanni Santi,
di origine pierfrancescana. Eppure, chi riconosce-
rebbe una derivazione dalle cristalline semplici
architetture del maestro di Borgo a quell'edifi-
cio con nicchia densa di ombre, risonante di voci
profonde; cornici che erompono prepotenti, con
la stessa soverchiali te forza degli uomini eroici
del Signorelli? Ed entro i due colossali meda-
glioni incavati, i profeti impetuosi, chiusi a stento
nel disco, curvi sui rotuli simili a serpi sibilanti,
non sono statue, ma esseri rigogliosi di vita, pronti
a rompere con forza di turbine le pareti della loro
prigione. L'edifìcio, nonostante la fuga prospettica
del pavimento a lucidi maiolicati rettangoli, non ha
la chiara definizione spaziale di Piero; si riduce a
dare al gruppo grandioso delle figure una parete di
sfondo dominata dalla nicchia a potente incavatura,
vera conca marina destinata ad accogliere il rim-
bombo delle onde: le architetture di Piero, come
le persone che vi si adunano, vivono in una pace
inalterata, nel silenzio; quelle del Signorelli
sono turbolente, agitate, scomposte per la irre-
frenata prepotenza degli aggetti e dei cavi. Ma
quell'architettura poderosa e nervosa toglieva
alla figura umana parte del suo dominio; e perciò
a Perugia il Cortonese l'abbandona, contentan-
dosi di un trono a schienale arcuato, a stipiti
di legno leggieri e snelli, ad alta base, divisa in
due gradini che permettono di disporre uno dietro
l'altro, uno sopra l'altro i Santi, di comporre la
grande scala umana. Il dominio delle figure
sopra lo spazio è compiuto: non restano agli
angeli se non i due angoletti del quadro, in alto;
ed eccoli perciò ridotti a moscerini bruni volanti
nell'ombra glauca del cielo. Il gruppo divino
ricompone la scena prediletta dal Signorelli:
la Vergine tiene aperto sulle ginocchia un libric-
cino di preghiere, a cui il bimbo, aggomitolato
sull'altro ginocchio di lei, tende una mano bra-
mosa, reggendo contro la spalla grassoccia uno
stelo di giglio enorme e stropicciando irrequieto
i piedini. Non è più il piccolo profeta conscio del
suo potere, che, nel tondo degli Uffizi(fig. 17), l'opera
monumentale di Luca, si volge con dignità tran-
quilla, come per ascoltare il richiamo di una
voce lontana; ma è una pallottola tonda, con pie-
ghe grassocce nelle carni, con lineamenti seri:
il contrasto fra quelle minuscole proporzioni e
l'enorme giglio che fiorisce come una pianta,
Fig. 14 — Pinturicchio: Ancona
nella Galleria Civica di Perugia. — (Fot. Alinari).
levandosi in alto dietro le spalle del bimbo,
gli dà una comicità di aspetto, certo affatto in-
volontaria in Luca. Ancora, in quest'opera, si
mantiene una calma che più tardi scomparirà
del tutto dalle opere signorelliane: la Vergine è
grave, intenta alla lettura; Stefano, immoto,
squadrato, monumentale nelle ampie forme,
guarda con dignità al gruppo divino; e nulla
potrebbe .distogliere il grandioso potente Erco-
lano dalla attenzione profonda che lo avvince
al testo sacro. L'impeto delle turbe in preda alle
tempeste negli affreschi di Orvieto è qui frenato
ancora; ma in quell'apparenza di quiete vive
latente lo spirito turbolento delle figure signorel-
liane. La Vergine, girando, nel movimento con-
sueto, la spalla destra, sembra raccoglier le forze
per vincere un invisibile ostacolo; e i suoi piedi,
Ma a Perugia Raffaello ritrovò le orme dei due
grandi che aveva veduto a Urbino durante la sua
fanciullezza: Luca Signorelli e Piero della Fran-
cesca. L'ancona ■ della Cattedrale di Perugia
(fig. 15) ci presenta il Signorelli prossimo alla
definitiva formazione del suo stile, con le ombre
potenti, le tinte bronzee, il modellato nervoso.
Piero della Francesca aveva dato all'Umbria
l'esempio dell'ancona d'altare con monumentali
sfondi architettonici, popolati da figure, che uno
squadro geometrico rigoroso, una perfetta stasi
di forme, legava in rapporti di assoluta equiva-
lenza all'edificio ambiente; Luca Signorelli nel
quadro di Perugia, fa scomparire l'architettura,
riducendola al minimo. Nella giovanile Circon-
cisione di Londra (fig. 16), egli dispone la scena
davanti a un'abside col catino a conchiglia,
il sottarco a rosoni, le pareti rivestite da rettan-
goli di porfido e di serpentino. E, in fondo, l'ar-
chitettura di Fra' Carnevale e di Giovanni Santi,
di origine pierfrancescana. Eppure, chi riconosce-
rebbe una derivazione dalle cristalline semplici
architetture del maestro di Borgo a quell'edifi-
cio con nicchia densa di ombre, risonante di voci
profonde; cornici che erompono prepotenti, con
la stessa soverchiali te forza degli uomini eroici
del Signorelli? Ed entro i due colossali meda-
glioni incavati, i profeti impetuosi, chiusi a stento
nel disco, curvi sui rotuli simili a serpi sibilanti,
non sono statue, ma esseri rigogliosi di vita, pronti
a rompere con forza di turbine le pareti della loro
prigione. L'edifìcio, nonostante la fuga prospettica
del pavimento a lucidi maiolicati rettangoli, non ha
la chiara definizione spaziale di Piero; si riduce a
dare al gruppo grandioso delle figure una parete di
sfondo dominata dalla nicchia a potente incavatura,
vera conca marina destinata ad accogliere il rim-
bombo delle onde: le architetture di Piero, come
le persone che vi si adunano, vivono in una pace
inalterata, nel silenzio; quelle del Signorelli
sono turbolente, agitate, scomposte per la irre-
frenata prepotenza degli aggetti e dei cavi. Ma
quell'architettura poderosa e nervosa toglieva
alla figura umana parte del suo dominio; e perciò
a Perugia il Cortonese l'abbandona, contentan-
dosi di un trono a schienale arcuato, a stipiti
di legno leggieri e snelli, ad alta base, divisa in
due gradini che permettono di disporre uno dietro
l'altro, uno sopra l'altro i Santi, di comporre la
grande scala umana. Il dominio delle figure
sopra lo spazio è compiuto: non restano agli
angeli se non i due angoletti del quadro, in alto;
ed eccoli perciò ridotti a moscerini bruni volanti
nell'ombra glauca del cielo. Il gruppo divino
ricompone la scena prediletta dal Signorelli:
la Vergine tiene aperto sulle ginocchia un libric-
cino di preghiere, a cui il bimbo, aggomitolato
sull'altro ginocchio di lei, tende una mano bra-
mosa, reggendo contro la spalla grassoccia uno
stelo di giglio enorme e stropicciando irrequieto
i piedini. Non è più il piccolo profeta conscio del
suo potere, che, nel tondo degli Uffizi(fig. 17), l'opera
monumentale di Luca, si volge con dignità tran-
quilla, come per ascoltare il richiamo di una
voce lontana; ma è una pallottola tonda, con pie-
ghe grassocce nelle carni, con lineamenti seri:
il contrasto fra quelle minuscole proporzioni e
l'enorme giglio che fiorisce come una pianta,
Fig. 14 — Pinturicchio: Ancona
nella Galleria Civica di Perugia. — (Fot. Alinari).
levandosi in alto dietro le spalle del bimbo,
gli dà una comicità di aspetto, certo affatto in-
volontaria in Luca. Ancora, in quest'opera, si
mantiene una calma che più tardi scomparirà
del tutto dalle opere signorelliane: la Vergine è
grave, intenta alla lettura; Stefano, immoto,
squadrato, monumentale nelle ampie forme,
guarda con dignità al gruppo divino; e nulla
potrebbe .distogliere il grandioso potente Erco-
lano dalla attenzione profonda che lo avvince
al testo sacro. L'impeto delle turbe in preda alle
tempeste negli affreschi di Orvieto è qui frenato
ancora; ma in quell'apparenza di quiete vive
latente lo spirito turbolento delle figure signorel-
liane. La Vergine, girando, nel movimento con-
sueto, la spalla destra, sembra raccoglier le forze
per vincere un invisibile ostacolo; e i suoi piedi,