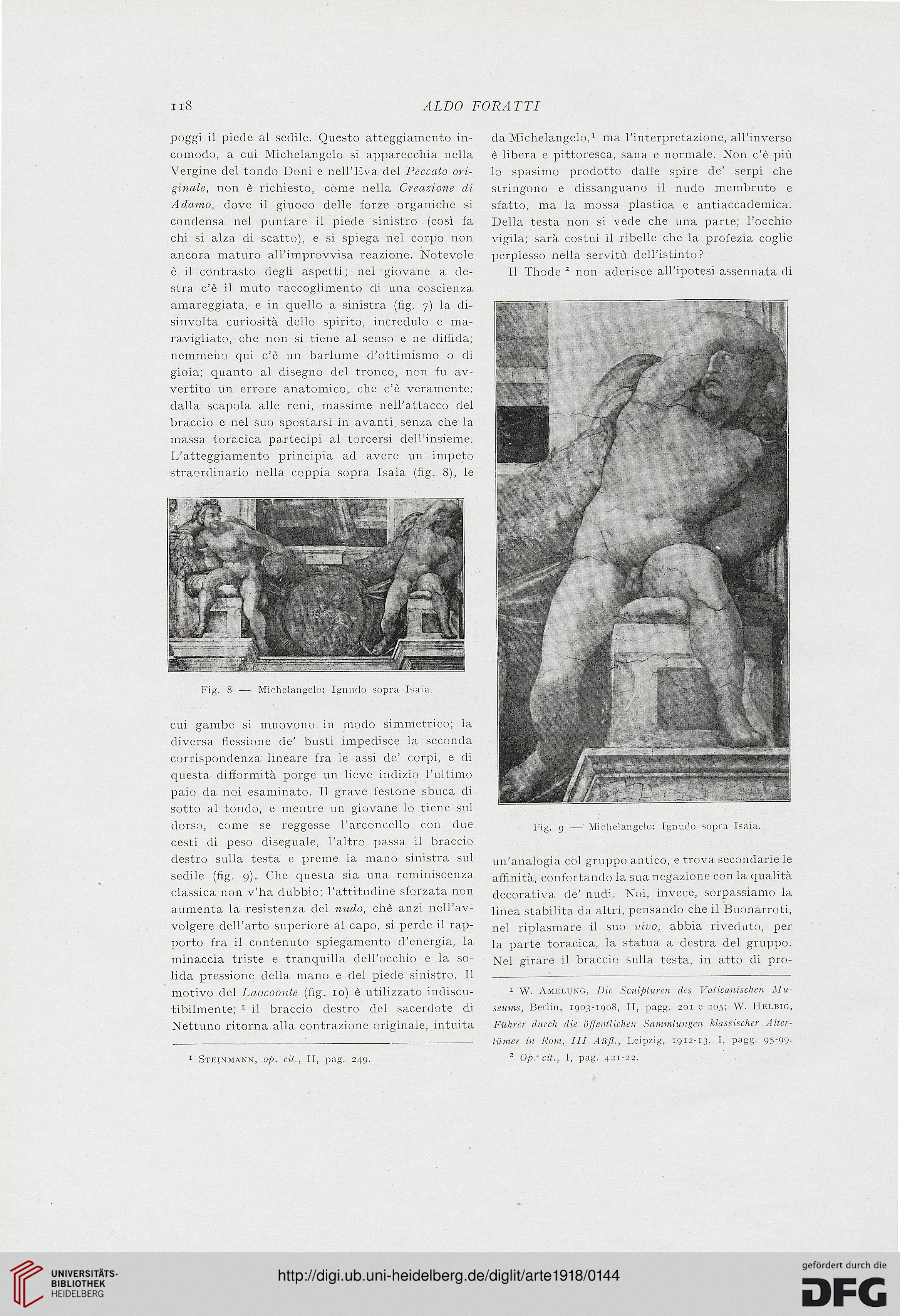iiS
ALDO FORATTI
poggi il piede al sedile. Questo atteggiamento in-
comodo, a cui Michelangelo si apparecchia nella
Vergine del tondo Doni e nell'Eva del Peccato ori-
ginale, non è richiesto, come nella Creazione di
Adamo, dove il giuoco delle forze organiche si
condensa nel puntare il piede sinistro (così fa
chi si alza di scatto), e si spiega nel corpo non
ancora maturo all'improvvisa reazione. Notevole
è il contrasto degli aspetti; nel giovane a de-
stra c'è il muto raccoglimento di una coscienza
amareggiata, e in quello a sinistra (fig. 7) la di-
sinvolta curiosità dello spirito, incredulo e ma-
ravigliato, che non si tiene al senso e ne diffida;
nemmeno qui c'è un barlume d'ottimismo o di
gioia; quanto al disegno del tronco, non fu av-
vertito un errore anatomico, che c'è veramente:
dalla scapola alle reni, massime nell'attacco del
braccio e nel suo spostarsi in avanti, senza che la
massa toracica partecipi al torcersi dell'insieme.
L'atteggiamento principia ad avere un impeto
straordinario nella coppia sopra Isaia (fig. 8), le
Fig. 8 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.
cui gambe si muovono in modo simmetrico; la
diversa flessione de' busti impedisce la seconda
corrispondenza lineare fra le assi de' corpi, e di
questa difformità porge un lieve indizio l'ultimo
paio da noi esaminato. Il grave festone sbuca di
sotto al tondo, e mentre un giovane lo tiene sul
dorso, come se reggesse l'arconcello con due
cesti di peso disegnale, l'altro passa il braccio
destro sulla testa e preme la mano sinistra sul
sedile (fig. y). Che questa sia una reminiscenza
classica non v'ha dubbio; l'attitudine sforzata non
aumenta la resistenza del nudo, eh è anzi nell'av-
volgere dell'arto superiore al capo, si perde il rap-
porto fra il contenuto spiegamento d'energia, la
minaccia triste e tranquilla dell'occhio e la so-
lida pressione della mano e del piede sinistro. 11
motivo del Laocoonte (fig. 10) è utilizzato indiscu-
tibilmente; 1 il braccio destro del sacerdote di
Nettuno ritorna alla contrazione originale, intuita
1 Stiìinmann, op. cit., II, pag. 249.
da Michelangelo,1 ma l'interpretazione, all'inverso
è libera e pittoresca, sana e normale. Non c'è più
lo spasimo prodotto dalle spire de' serpi che
stringono e dissanguano il nudo membruto e
sfatto, ma la mossa plastica e antiaccademica.
Della testa non si vede che una parte; l'occhio
vigila; sarà costui il ribelle che la profezia coglie
perplesso nella servitù dell'istinto?
11 Thode 2 non aderisce all'ipotesi assennata di
Fig. 9 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.
un'analogia col gruppo antico, e trova secondarie le
affinità, confortando la sua negazione con la qualità
decorativa de' nudi. Noi, invece, sorpassiamo la
linea stabilita da altri, pensando che il Buonarroti,
nel riplasmare il suo vivo, abbia riveduto, per
La parte toracica, la statua a destra del gruppo.
Nel girare il braccio sulla testa, in atto di pro-
1 W. Amelung, Die Scidpturcn des Vaticanischen Mu-
tìL'itms, Berlin, 1903-1908, II, pagg. 201 e 205; W. Helbig,
Fiihrcr durch die pffentlicHen Sammlungen klassischer Alter-
tilmer in Rom, III Ailfl., Leipzig, 1912-13, I, pagg. 95-99-
2 Op.'cit., I, pag. 421-22.
ALDO FORATTI
poggi il piede al sedile. Questo atteggiamento in-
comodo, a cui Michelangelo si apparecchia nella
Vergine del tondo Doni e nell'Eva del Peccato ori-
ginale, non è richiesto, come nella Creazione di
Adamo, dove il giuoco delle forze organiche si
condensa nel puntare il piede sinistro (così fa
chi si alza di scatto), e si spiega nel corpo non
ancora maturo all'improvvisa reazione. Notevole
è il contrasto degli aspetti; nel giovane a de-
stra c'è il muto raccoglimento di una coscienza
amareggiata, e in quello a sinistra (fig. 7) la di-
sinvolta curiosità dello spirito, incredulo e ma-
ravigliato, che non si tiene al senso e ne diffida;
nemmeno qui c'è un barlume d'ottimismo o di
gioia; quanto al disegno del tronco, non fu av-
vertito un errore anatomico, che c'è veramente:
dalla scapola alle reni, massime nell'attacco del
braccio e nel suo spostarsi in avanti, senza che la
massa toracica partecipi al torcersi dell'insieme.
L'atteggiamento principia ad avere un impeto
straordinario nella coppia sopra Isaia (fig. 8), le
Fig. 8 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.
cui gambe si muovono in modo simmetrico; la
diversa flessione de' busti impedisce la seconda
corrispondenza lineare fra le assi de' corpi, e di
questa difformità porge un lieve indizio l'ultimo
paio da noi esaminato. Il grave festone sbuca di
sotto al tondo, e mentre un giovane lo tiene sul
dorso, come se reggesse l'arconcello con due
cesti di peso disegnale, l'altro passa il braccio
destro sulla testa e preme la mano sinistra sul
sedile (fig. y). Che questa sia una reminiscenza
classica non v'ha dubbio; l'attitudine sforzata non
aumenta la resistenza del nudo, eh è anzi nell'av-
volgere dell'arto superiore al capo, si perde il rap-
porto fra il contenuto spiegamento d'energia, la
minaccia triste e tranquilla dell'occhio e la so-
lida pressione della mano e del piede sinistro. 11
motivo del Laocoonte (fig. 10) è utilizzato indiscu-
tibilmente; 1 il braccio destro del sacerdote di
Nettuno ritorna alla contrazione originale, intuita
1 Stiìinmann, op. cit., II, pag. 249.
da Michelangelo,1 ma l'interpretazione, all'inverso
è libera e pittoresca, sana e normale. Non c'è più
lo spasimo prodotto dalle spire de' serpi che
stringono e dissanguano il nudo membruto e
sfatto, ma la mossa plastica e antiaccademica.
Della testa non si vede che una parte; l'occhio
vigila; sarà costui il ribelle che la profezia coglie
perplesso nella servitù dell'istinto?
11 Thode 2 non aderisce all'ipotesi assennata di
Fig. 9 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.
un'analogia col gruppo antico, e trova secondarie le
affinità, confortando la sua negazione con la qualità
decorativa de' nudi. Noi, invece, sorpassiamo la
linea stabilita da altri, pensando che il Buonarroti,
nel riplasmare il suo vivo, abbia riveduto, per
La parte toracica, la statua a destra del gruppo.
Nel girare il braccio sulla testa, in atto di pro-
1 W. Amelung, Die Scidpturcn des Vaticanischen Mu-
tìL'itms, Berlin, 1903-1908, II, pagg. 201 e 205; W. Helbig,
Fiihrcr durch die pffentlicHen Sammlungen klassischer Alter-
tilmer in Rom, III Ailfl., Leipzig, 1912-13, I, pagg. 95-99-
2 Op.'cit., I, pag. 421-22.