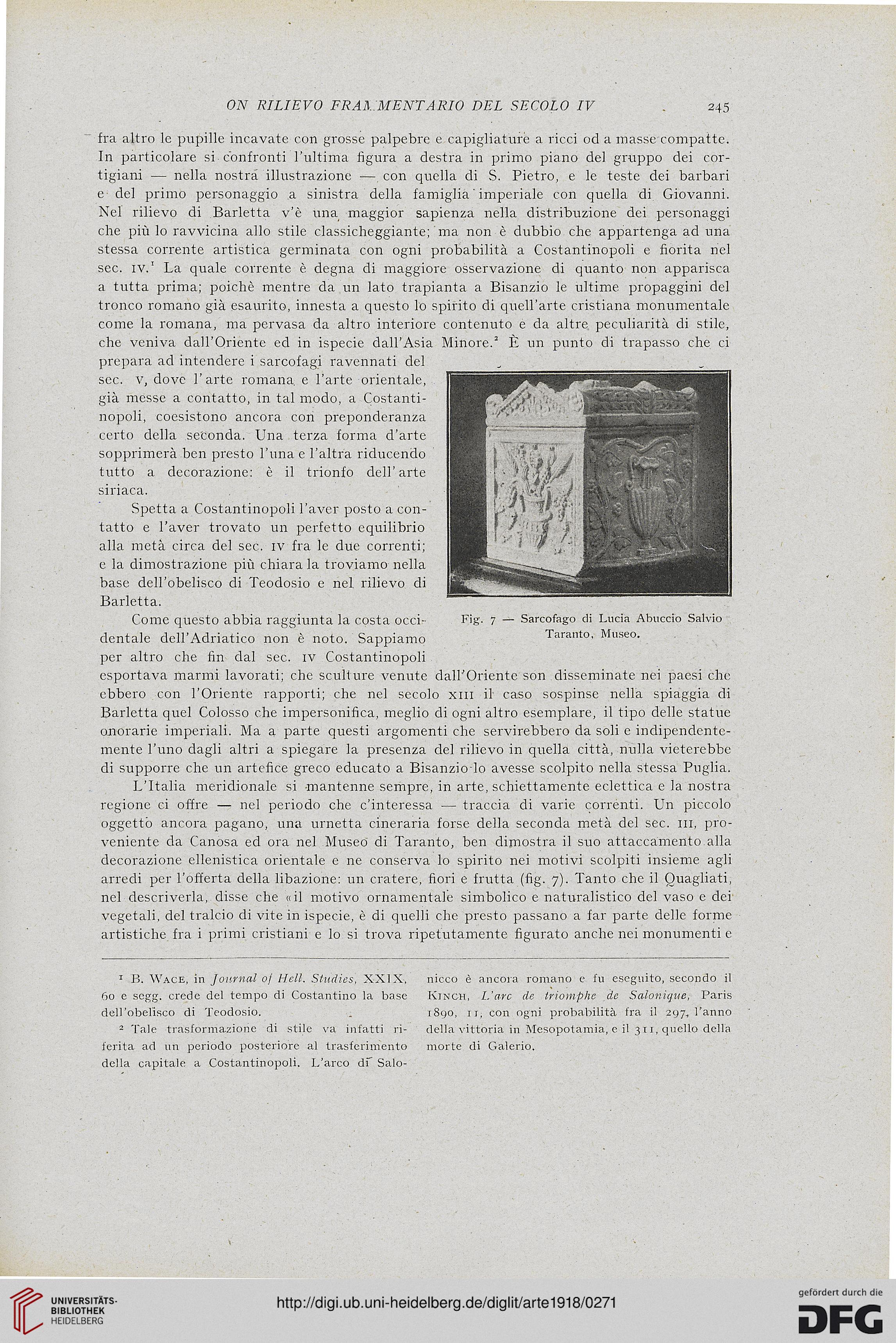ON RILIEVO FRAR.MENTARIO DEL SECOLO IV
245
fra altro le pupille incavate con grosse palpebre e capigliature a ricci od a masse compatte.
In particolare si confronti l'ultima figura a destra in primo piano del gruppo dei cor-
tigiani — nella nostra illustrazione — con quella di S. Pietro, e le teste dei barbari
e- del primo personaggio a sinistra della famiglia ' imperiale con quella di Giovanni.
Nel rilievo di Barletta v'è una maggior sapienza nella distribuzione dei personaggi
che più lo ravvicina allo stile classicheggiante; ma non è dubbio che appartenga ad una
stessa corrente artistica germinata con ogni probabilità a Costantinopoli e fiorita nel
sec. iv.1 La quale corrente è. degna di maggiore osservazione di quanto non apparisca
a tutta prima; poiché mentre da un lato trapianta a Bisanzio le ultime propaggini del
tronco romano già esaurito, innesta a questo lo spirito di quell'arte cristiana monumentale
come la romana, ma pervasa da altro interiore contenuto e da altre peculiarità di stile,
che veniva dall'Oriente ed in ispecie dall'Asia Minore.2 E un punto di trapasso che ci
prepara ad intendere i sarcofagi ravennati del
sec. v, dove l'arte romana, e l'arte orientale,
già messe a contatto, in tal modo, a Costanti-
nopoli, coesistono ancora con preponderanza
certo della seconda. Una terza forma d'arte
sopprimerà ben presto l'ima e l'altra riducendo
tutto a decorazione: è il trionfo dell'arte
siriaca.
Spetta a Costantinopoli l'aver posto a con-
tatto e l'aver trovato un perfetto equilibrio
alla metà circa del sec. iv fra le due correnti;
e la dimostrazione più chiara la troviamo nella
base dell'obelisco di Teodosio e nel. rilievo di
Barletta.
Come questo abbia raggiunta la costa occi- Pjg. 7 — Sarcofago di Lucia Abuccio Salvio
dentale dell'Adriatico non è noto. Sappiamo Taranto, Museo,
per altro che fin dal sec. iv Costantinopoli
esportava marmi lavorati; che sculture venute dall'Oriente son disseminate nei paesi che
ebbero con l'Oriente rapporti; che nel secolo xm il caso sospinse nella spiaggia di
Barletta quel Colosso che impersonifica, meglio di ogni altro esemplare, il tipo delle statue
onorarie imperiali. Ma a parte questi argomenti che servirebbero da soli e indipendente-
mente l'uno dagli altri a spiegare la presenza del rilievo in quella città, nulla vieterebbe
di supporre che un artefice greco educato a Bisanzio lo avesse scolpito nella stessa Puglia.
L'Italia meridionale si -mantenne sempre, in arte, schiettamente eclettica e la nostra
regione ci offre — nel periodo che c'interessa — traccia di varie correnti. Un piccolo
oggetto ancora pagano, una umetta cineraria forse della seconda metà del sec. 111, pro-
veniente da Canosa ed ora nel Museo di Taranto, ben dimostra il suo attaccamento alla
decorazione ellenistica orientale e ne conserva lo spirito nei motivi scolpiti insieme agli
arredi per l'offerta della libazione: un cratere, fiori e frutta (fig. 7). Tanto che il Quagliati,
nel descriverla, disse che «il motivo ornamentale simbolico e naturalistico del vaso e dei-
vegetali, del tralcio di vite in ispecie, è di quelli che presto passano a far parte delle forme
artistiche fra i primi cristiani e lo si trova ripetutamente figurato anche nei monumenti e
1 1-5. Wace, in Journal oj Hett. Studies, XXIX,
60 e segg. crede del tempo di Costantino la base
dell'obelisco di Teodosio.
2 Tale trasformazione di stile va infatti ri-
ferita ad un periodo posteriore al trasferimento
della capitale a Costantinopoli. L'arco df Salo-
nicco è ancora romano e fu eseguito, secondo il
Kinch, L'are de triomphe de Saionicpte, Paris
1800, it, con ogni probabilità fra il 297, l'anno
della vittoria in Mesopotamia, e il 311, quello della
morte di Galcrio.
245
fra altro le pupille incavate con grosse palpebre e capigliature a ricci od a masse compatte.
In particolare si confronti l'ultima figura a destra in primo piano del gruppo dei cor-
tigiani — nella nostra illustrazione — con quella di S. Pietro, e le teste dei barbari
e- del primo personaggio a sinistra della famiglia ' imperiale con quella di Giovanni.
Nel rilievo di Barletta v'è una maggior sapienza nella distribuzione dei personaggi
che più lo ravvicina allo stile classicheggiante; ma non è dubbio che appartenga ad una
stessa corrente artistica germinata con ogni probabilità a Costantinopoli e fiorita nel
sec. iv.1 La quale corrente è. degna di maggiore osservazione di quanto non apparisca
a tutta prima; poiché mentre da un lato trapianta a Bisanzio le ultime propaggini del
tronco romano già esaurito, innesta a questo lo spirito di quell'arte cristiana monumentale
come la romana, ma pervasa da altro interiore contenuto e da altre peculiarità di stile,
che veniva dall'Oriente ed in ispecie dall'Asia Minore.2 E un punto di trapasso che ci
prepara ad intendere i sarcofagi ravennati del
sec. v, dove l'arte romana, e l'arte orientale,
già messe a contatto, in tal modo, a Costanti-
nopoli, coesistono ancora con preponderanza
certo della seconda. Una terza forma d'arte
sopprimerà ben presto l'ima e l'altra riducendo
tutto a decorazione: è il trionfo dell'arte
siriaca.
Spetta a Costantinopoli l'aver posto a con-
tatto e l'aver trovato un perfetto equilibrio
alla metà circa del sec. iv fra le due correnti;
e la dimostrazione più chiara la troviamo nella
base dell'obelisco di Teodosio e nel. rilievo di
Barletta.
Come questo abbia raggiunta la costa occi- Pjg. 7 — Sarcofago di Lucia Abuccio Salvio
dentale dell'Adriatico non è noto. Sappiamo Taranto, Museo,
per altro che fin dal sec. iv Costantinopoli
esportava marmi lavorati; che sculture venute dall'Oriente son disseminate nei paesi che
ebbero con l'Oriente rapporti; che nel secolo xm il caso sospinse nella spiaggia di
Barletta quel Colosso che impersonifica, meglio di ogni altro esemplare, il tipo delle statue
onorarie imperiali. Ma a parte questi argomenti che servirebbero da soli e indipendente-
mente l'uno dagli altri a spiegare la presenza del rilievo in quella città, nulla vieterebbe
di supporre che un artefice greco educato a Bisanzio lo avesse scolpito nella stessa Puglia.
L'Italia meridionale si -mantenne sempre, in arte, schiettamente eclettica e la nostra
regione ci offre — nel periodo che c'interessa — traccia di varie correnti. Un piccolo
oggetto ancora pagano, una umetta cineraria forse della seconda metà del sec. 111, pro-
veniente da Canosa ed ora nel Museo di Taranto, ben dimostra il suo attaccamento alla
decorazione ellenistica orientale e ne conserva lo spirito nei motivi scolpiti insieme agli
arredi per l'offerta della libazione: un cratere, fiori e frutta (fig. 7). Tanto che il Quagliati,
nel descriverla, disse che «il motivo ornamentale simbolico e naturalistico del vaso e dei-
vegetali, del tralcio di vite in ispecie, è di quelli che presto passano a far parte delle forme
artistiche fra i primi cristiani e lo si trova ripetutamente figurato anche nei monumenti e
1 1-5. Wace, in Journal oj Hett. Studies, XXIX,
60 e segg. crede del tempo di Costantino la base
dell'obelisco di Teodosio.
2 Tale trasformazione di stile va infatti ri-
ferita ad un periodo posteriore al trasferimento
della capitale a Costantinopoli. L'arco df Salo-
nicco è ancora romano e fu eseguito, secondo il
Kinch, L'are de triomphe de Saionicpte, Paris
1800, it, con ogni probabilità fra il 297, l'anno
della vittoria in Mesopotamia, e il 311, quello della
morte di Galcrio.