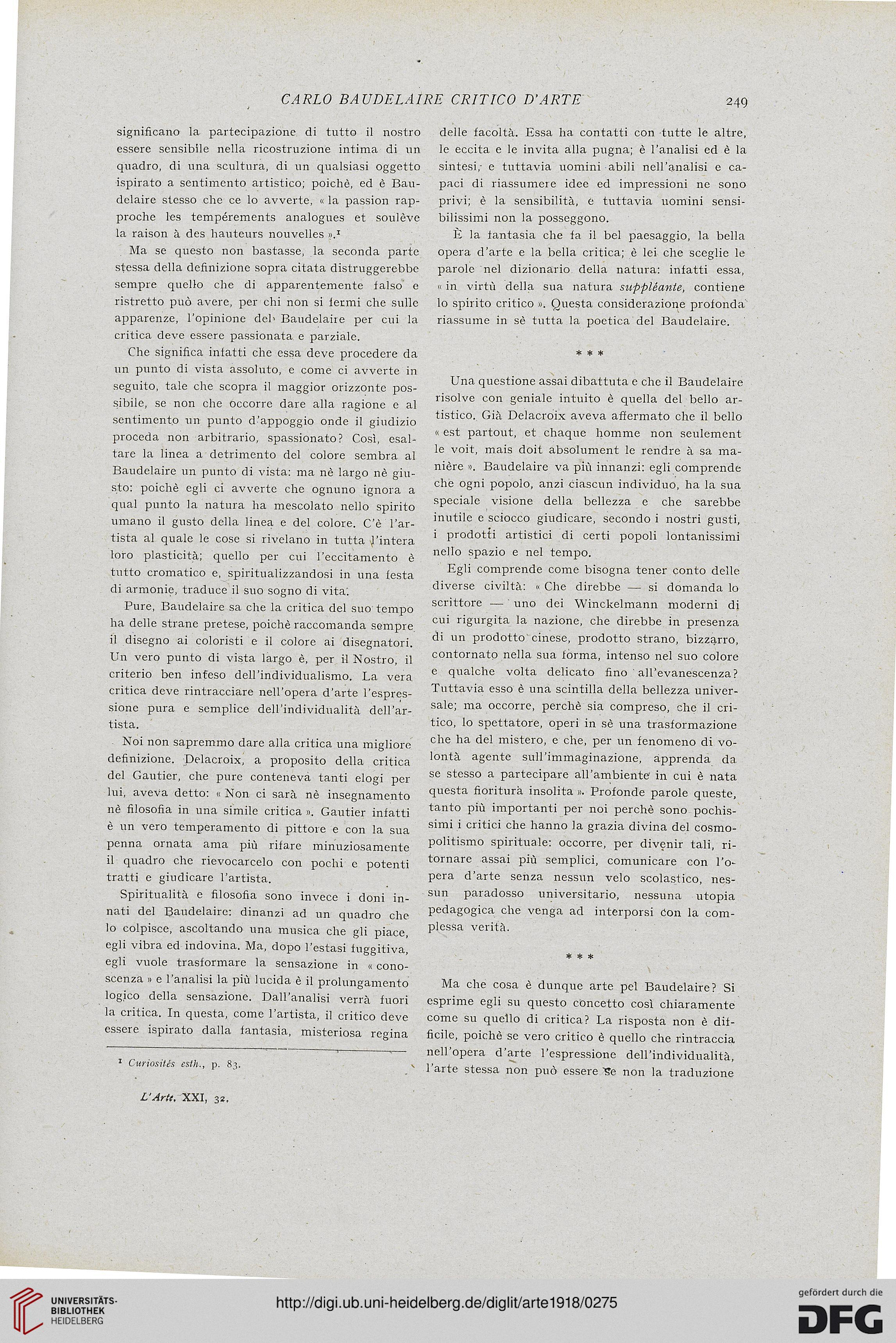CARLO BAUDELAIRE CRITICO D'ARTE
249
significano la partecipazione di tutto il nostro
essere sensibile nella ricostruzione intima di un
quadro, di una scultura, di un qualsiasi oggetto
ispirato a sentimento artistico; poiché, ed è Bau-
delaire stesso che ce lo avverte, « la passion rap-
proche les tempérements analogues et soulève
la raison à des hauteurs nouvelles n.1
Ma se questo non bastasse, la seconda parte
stessa della definizione sopra citata distruggerebbe
sempre quello che di apparentemente lalso e
ristretto può avere, per chi non si termi che sulle
apparenze, l'opinione deb Baudelaire per cui la
critica deve essere passionata e parziale.
Che significa intatti che essa deve procedere da
un punto di vista assoluto, e come ci avverte in
seguito, tale che scopra il maggior orizzonte pos-
sibile, se non che occorre dare alla ragione e al
sentimento un punto d'appoggio onde il giudizio
proceda non arbitrario, spassionato? Così, esal-
tare la linea a detrimento del colore sembra al
Baudelaire un punto di vista: ma nè largo nè giu-
sto: poiché egli ci avverte che ognuno ignora a
qual punto la natura ha mescolato nello spirito
umano il gusto della linea e del colore. C'è l'ar-
tista a! quale le cose si rivelano in tutta Lintera
loro plasticità; quello per cui l'eccitamento è
tutto cromatico e, spiritualizzandosi in una testa
di armonie, traduce il suo sogno di vita'.
Pure, Baudelaire sa che la critica del suo tempo
ha delle strane pretese, poiché raccomanda sempre
il disegno ai coloristi e il colore ai disegnatori.
Un vero punto di vista largo è, per il Nostro, il
criterio ben inteso dell'individualismo. La vera
critica deve rintracciare nell'opera d'arte l'espres-
sione pura e semplice dell'individualità dell'ar-
tista.
Noi non sapremmo dare alla critica una migliore
definizione, pclacroix, a proposito della critica
del Gautier, che pure conteneva tanti elogi per
lui, aveva detto: « Non ci sarà nè insegnamento
nè filosofia in una simile critica ». Gautier infatti
è un vero temperamento di pittore e con la sua
penna ornata ama più rifare minuziosamente
il quadro che rievocarcelo con pochi e potenti
tratti e giudicare l'artista.
Spiritualità e filosofia sono invece i doni in-
nati del Baudelaire: dinanzi ad un quadro che
lo colpisce, ascoltando una musica che gli piace,
egli vibra ed indovina. Ma, dopo l'estasi fuggitiva,
egli vuole trasformare la sensazione in « cono-
scenza » c l'analisi la più lucida è il prolungamento
logico della sensazione. Dall'analisi verrà fuori
la critica. In questa, come l'artista, il critico deve
essere ispirato dalla fantasia, misteriosa regina
1 Cwiosilés esth., p. 83. v
delle facoltà. Essa ha contatti con tutte le altre,
le eccita e le invita alla pugna; è l'analisi ed è la
sintesi, e tuttavia uomini abili nell'analisi e ca-
paci di riassumere idee ed impressioni ne sono
privi; è la sensibilità, e tuttavia uomini sensi-
bilissimi non la posseggono.
È la fantasia che fa il bel paesaggio, la bella
opera d'arte e la bella critica; è lei che sceglie le
parole nel dizionario della natura: intatti essa,
« in virtù della sua natura suppléante, contiene
lo spirito critico ». Questa considerazione profonda
riassume in sè tutta la poetica del Baudelaire.
* * *
Una questione assai dibattuta e che il Baudelaire
risolve con geniale intuito è quella del bello ar-
tistico. Già Delacroix aveva affermato che il bello
« est partout, et chaque homme non seulement
le voit, mais doit absolument le rendre à sa ma-
nière ». Baudelaire va più innanzi: egli comprende
che ogni popolo, anzi ciascun individuo, ha la sua
speciale visione della bellezza e che sarebbe
inutile e sciocco giudicare, secondo i nostri gusti,
i prodotti artistici di certi popoli lontanissimi
nello spazio e nel tempo.
Egli comprende come bisogna tener conto delle
diverse civiltà: « Che direbbe — si domanda lo
scrittore — uno dei Winckelmann moderni di
cui rigurgita la nazione, che direbbe in presenza
di un prodotto cinese, prodotto strano, bizzarro,
contornato nella sua forma, intenso nel suo colore
e qualche volta delicato fino all'evanescenza?
Tuttavia esso è una scintilla della bellezza univer-
sale; ma occorre, perchè sia compreso, che il cri-
tico, lo spettatore, operi in sè una trasformazione
che ha del mistero, e che, per un fenomeno di vo-
lontà agente sull'immaginazione, apprenda da
se stesso a partecipare all'ambiente' in cui è nata
questa fioritura insolita ». Profonde parole queste,
tanto più importanti per noi perchè sono pochis-
simi i critici che hanno la grazia divina del cosmo-
politismo spirituale: occorre, per divenir tali, ri-
tornare assai più semplici, comunicare con l'o-
pera d'arte senza nessun velo scolastico, nes-
sun paradosso universitario, nessuna utopia
pedagogica che venga ad interporsi Con la com-
plessa verità.
* * *
Ma che cosa è dunque arte pel Baudelaire? Si
esprime egli su questo concetto così chiaramente
come su quello di critica? La risposta non è dif-
ficile, poiché se vero critico è quello che rintraccia
nell'opera d'arte l'espressione dell'individualità,
l'arte stessa non può essere "Se non la traduzione
L'Arte. XXI, 32.
249
significano la partecipazione di tutto il nostro
essere sensibile nella ricostruzione intima di un
quadro, di una scultura, di un qualsiasi oggetto
ispirato a sentimento artistico; poiché, ed è Bau-
delaire stesso che ce lo avverte, « la passion rap-
proche les tempérements analogues et soulève
la raison à des hauteurs nouvelles n.1
Ma se questo non bastasse, la seconda parte
stessa della definizione sopra citata distruggerebbe
sempre quello che di apparentemente lalso e
ristretto può avere, per chi non si termi che sulle
apparenze, l'opinione deb Baudelaire per cui la
critica deve essere passionata e parziale.
Che significa intatti che essa deve procedere da
un punto di vista assoluto, e come ci avverte in
seguito, tale che scopra il maggior orizzonte pos-
sibile, se non che occorre dare alla ragione e al
sentimento un punto d'appoggio onde il giudizio
proceda non arbitrario, spassionato? Così, esal-
tare la linea a detrimento del colore sembra al
Baudelaire un punto di vista: ma nè largo nè giu-
sto: poiché egli ci avverte che ognuno ignora a
qual punto la natura ha mescolato nello spirito
umano il gusto della linea e del colore. C'è l'ar-
tista a! quale le cose si rivelano in tutta Lintera
loro plasticità; quello per cui l'eccitamento è
tutto cromatico e, spiritualizzandosi in una testa
di armonie, traduce il suo sogno di vita'.
Pure, Baudelaire sa che la critica del suo tempo
ha delle strane pretese, poiché raccomanda sempre
il disegno ai coloristi e il colore ai disegnatori.
Un vero punto di vista largo è, per il Nostro, il
criterio ben inteso dell'individualismo. La vera
critica deve rintracciare nell'opera d'arte l'espres-
sione pura e semplice dell'individualità dell'ar-
tista.
Noi non sapremmo dare alla critica una migliore
definizione, pclacroix, a proposito della critica
del Gautier, che pure conteneva tanti elogi per
lui, aveva detto: « Non ci sarà nè insegnamento
nè filosofia in una simile critica ». Gautier infatti
è un vero temperamento di pittore e con la sua
penna ornata ama più rifare minuziosamente
il quadro che rievocarcelo con pochi e potenti
tratti e giudicare l'artista.
Spiritualità e filosofia sono invece i doni in-
nati del Baudelaire: dinanzi ad un quadro che
lo colpisce, ascoltando una musica che gli piace,
egli vibra ed indovina. Ma, dopo l'estasi fuggitiva,
egli vuole trasformare la sensazione in « cono-
scenza » c l'analisi la più lucida è il prolungamento
logico della sensazione. Dall'analisi verrà fuori
la critica. In questa, come l'artista, il critico deve
essere ispirato dalla fantasia, misteriosa regina
1 Cwiosilés esth., p. 83. v
delle facoltà. Essa ha contatti con tutte le altre,
le eccita e le invita alla pugna; è l'analisi ed è la
sintesi, e tuttavia uomini abili nell'analisi e ca-
paci di riassumere idee ed impressioni ne sono
privi; è la sensibilità, e tuttavia uomini sensi-
bilissimi non la posseggono.
È la fantasia che fa il bel paesaggio, la bella
opera d'arte e la bella critica; è lei che sceglie le
parole nel dizionario della natura: intatti essa,
« in virtù della sua natura suppléante, contiene
lo spirito critico ». Questa considerazione profonda
riassume in sè tutta la poetica del Baudelaire.
* * *
Una questione assai dibattuta e che il Baudelaire
risolve con geniale intuito è quella del bello ar-
tistico. Già Delacroix aveva affermato che il bello
« est partout, et chaque homme non seulement
le voit, mais doit absolument le rendre à sa ma-
nière ». Baudelaire va più innanzi: egli comprende
che ogni popolo, anzi ciascun individuo, ha la sua
speciale visione della bellezza e che sarebbe
inutile e sciocco giudicare, secondo i nostri gusti,
i prodotti artistici di certi popoli lontanissimi
nello spazio e nel tempo.
Egli comprende come bisogna tener conto delle
diverse civiltà: « Che direbbe — si domanda lo
scrittore — uno dei Winckelmann moderni di
cui rigurgita la nazione, che direbbe in presenza
di un prodotto cinese, prodotto strano, bizzarro,
contornato nella sua forma, intenso nel suo colore
e qualche volta delicato fino all'evanescenza?
Tuttavia esso è una scintilla della bellezza univer-
sale; ma occorre, perchè sia compreso, che il cri-
tico, lo spettatore, operi in sè una trasformazione
che ha del mistero, e che, per un fenomeno di vo-
lontà agente sull'immaginazione, apprenda da
se stesso a partecipare all'ambiente' in cui è nata
questa fioritura insolita ». Profonde parole queste,
tanto più importanti per noi perchè sono pochis-
simi i critici che hanno la grazia divina del cosmo-
politismo spirituale: occorre, per divenir tali, ri-
tornare assai più semplici, comunicare con l'o-
pera d'arte senza nessun velo scolastico, nes-
sun paradosso universitario, nessuna utopia
pedagogica che venga ad interporsi Con la com-
plessa verità.
* * *
Ma che cosa è dunque arte pel Baudelaire? Si
esprime egli su questo concetto così chiaramente
come su quello di critica? La risposta non è dif-
ficile, poiché se vero critico è quello che rintraccia
nell'opera d'arte l'espressione dell'individualità,
l'arte stessa non può essere "Se non la traduzione
L'Arte. XXI, 32.