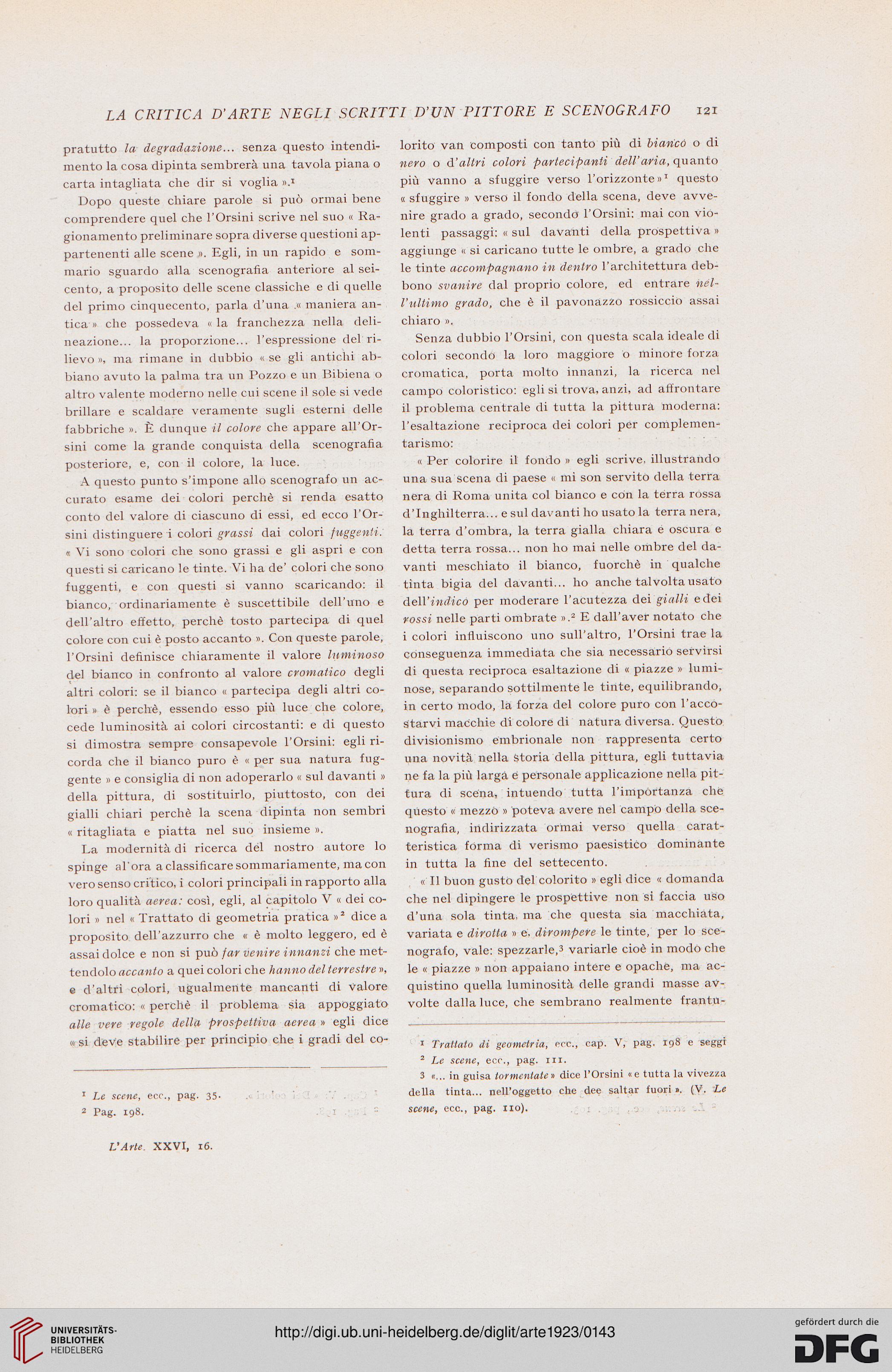LA CRITICA D'ARTE NEGLI SCRITTI D'UN PITTORE E SCENOGRAFO 121
pratutto la degradazione... senza questo intendi-
mento la cosa dipinta sembrerà una tavola piana o
carta intagliata che dir si voglia ».'
Dopo queste chiare parole si può ormai bene
comprendere quel che l'Orsini scrive nel suo « Ra-
gionamento preliminare sopra diverse questioni ap-
partenenti alle scene ». Egli, in un rapido e som-
mario sguardo alla scenografia anteriore al sei-
cento, a proposito delle scene classiche e di quelle
del primo cinquecento, parla d'una .« maniera an-
tica » che possedeva « la franchezza nella deli-
neazione... la proporzione... l'espressione del ri-
lievo », ma rimane in dubbio « se gli antichi ab-
biano avuto la palma tra un Pozzo e un Hibiena o
altro valente moderno nelle cui scene il sole si vede
brillare e scaldare veramente sugli esterni delle
fabbriche ». È dunque il colore che appare all'Or-
sini come la grande conquista della scenografia
posteriore, e, con il colore, la luce.
A questo punto s'impone allo scenografo un ac-
curato esame dei colori perchè si renda esatto
conto del valore di ciascuno di essi, ed ecco l'Or-
sini distinguere i colori grassi dai colori fuggenti:
j Vi sono colori che sono grassi e gli aspri e con
questi si caricano le tinte. Vi ha de' colori che sono
fuggenti, e con questi si vanno scaricando: il
bianco, ordinariamente è suscettibile dell'uno e
dell'altro effetto, perchè tosto partecipa di quel
colore con cui è posto accanto ». Con queste parole,
l'Orsini definisce chiaramente il valore luminoso
del bianco in confronto al valore cromatico degli
altri colori: se il bianco « partecipa degli altri co-
lori > è perchè, essendo esso più luce che colore,
cede luminosità ai colori circostanti: e di questo
si dimostra sempre consapevole l'Orsini: egli ri-
corda che il bianco puro è « per sua natura fug-
gente » e consiglia di non adoperarlo « sul davanti »
della pittura, di sostituirlo, piuttosto, con dei
gialli chiari perchè la scena dipinta non sembri
« ritagliata e piatta nel suo insieme ».
La modernità di ricerca del nostro autore lo
spinge al'ora a classificare sommariamente, ma con
vero senso critico, i colori principali in rapporto alla
loro qualità aerea: così, egli, al capitolo V « dei co-
lori » nel ■ Trattato di geometria pratica »' dice a
proposito dell'azzurro che « è molto leggero, ed è
assai dolce e non si può far venire innanzi che met-
tendolo accanto a quei colori che hanno del terrestre »,
e d'altri colori, ugualmente mancanti di Valore
cromatico: « perchè il problema sia appoggiato
alle vere regole della prospettiva aerea » egli dice
«si deve stabilire per principio che i gradi del co-
1 Le scene, ecc., pag. 35.
2 Pag. 198.
lorito van composti con tanto più di bianco o di
nero o d'altri colori partecipanti dell'aria, quanto
più vanno a sfuggire verso l'orizzonte»1 questo
« sfuggire » verso il fondo della scena, deve avve-
nire grado a grado, seconda l'Orsini: mai con vio-
lenti passaggi: « sul davanti della prospettiva »
aggiunge « si caricano tutte le ombre, a grado che
le tinte accompagnano in dentro l'architettura deb-
bono svanire dal proprio colore, ed entrare nel-
l'ultimo grado, che è il pavonazzo rossiccio assai
chiaro ».
Senza dubbio l'Orsini, con questa scala ideale di
colori secondo la loro maggiore o minore forza
cromatica, porta molto innanzi, la ricerca nel
campo coloristico: egli si trova, anzi, ad affrontare
il problema centrale di tutta la pittura moderna:
l'esaltazione reciproca dei colori per complemen-
tarismo:
« Per colorire il fondo » egli scrive, illustrando
una sua scena di paese « mi son servito della terra
nera di Roma unita col bianco e con la terra rossa
d'I nghilterra... e sul davanti ho usato la terra nera,
la terra d'ombra, la terra gialla chiara e oscura e
detta terra rossa... non ho mai nelle ombre del da-
vanti meschiato il bianco, fuorché in qualche
tinta bigia del davanti... ho anche talvolta usato
dell' indico per moderare l'acutezza dei gialli e dei
rossi nelle parti ombrate ».2 E dall'aver notato che
i colori influiscono uno sull'altro, l'Orsini trae la
conseguenza immediata che sia necessario servirsi
di questa reciproca esaltazione di « piazze » lumi-
nose, separando sottilmente le tinte, equilibrando,
in certo modo, la forza del colore puro con l'acco-
starvi macchie di colore di natura diversa. Questo
divisionismo embrionale non rappresenta certo
una novità nella Storia della pittura, egli tuttavia
ne fa la più larga e personale applicazione nella pit-
tura di scena, intuendo tutta l'importanza che
questo « mezzo » poteva avere nel campo della sce-
nografia, indirizzata ormai verso quella carat-
teristica forma di verismo paesistico dominante
in tutta la fine del settecento.
« Il buon gusto del colorito » egli dice « domanda
che nel dipingere le prospettive non si faccia uso
d'una sola tinta, ma che questa sia macchiata,
variata e dirotta » e. dirompere le tinte, per lo sce-
nografo, vale: spezzarle,3 variarle cioè in modo che
le « piazze » non appaiano intere e opache, ma ac-
quistino quella luminosità delle grandi masse av-
volte dalla luce, che sembrano realmente frantu-
1 Trattato di geometria, ecc., cap. V, pag. 198 e Seggi
2 Le scene, ecc., pag. in.
3 «... in guisa tormentateli dice l'Orsini «e tutta la vivezza
della tinta... nell'oggetto che dee saltar fuori ». (V. Le
scene, ecc., pag. no).
L'Arte XXVI, 16.
pratutto la degradazione... senza questo intendi-
mento la cosa dipinta sembrerà una tavola piana o
carta intagliata che dir si voglia ».'
Dopo queste chiare parole si può ormai bene
comprendere quel che l'Orsini scrive nel suo « Ra-
gionamento preliminare sopra diverse questioni ap-
partenenti alle scene ». Egli, in un rapido e som-
mario sguardo alla scenografia anteriore al sei-
cento, a proposito delle scene classiche e di quelle
del primo cinquecento, parla d'una .« maniera an-
tica » che possedeva « la franchezza nella deli-
neazione... la proporzione... l'espressione del ri-
lievo », ma rimane in dubbio « se gli antichi ab-
biano avuto la palma tra un Pozzo e un Hibiena o
altro valente moderno nelle cui scene il sole si vede
brillare e scaldare veramente sugli esterni delle
fabbriche ». È dunque il colore che appare all'Or-
sini come la grande conquista della scenografia
posteriore, e, con il colore, la luce.
A questo punto s'impone allo scenografo un ac-
curato esame dei colori perchè si renda esatto
conto del valore di ciascuno di essi, ed ecco l'Or-
sini distinguere i colori grassi dai colori fuggenti:
j Vi sono colori che sono grassi e gli aspri e con
questi si caricano le tinte. Vi ha de' colori che sono
fuggenti, e con questi si vanno scaricando: il
bianco, ordinariamente è suscettibile dell'uno e
dell'altro effetto, perchè tosto partecipa di quel
colore con cui è posto accanto ». Con queste parole,
l'Orsini definisce chiaramente il valore luminoso
del bianco in confronto al valore cromatico degli
altri colori: se il bianco « partecipa degli altri co-
lori > è perchè, essendo esso più luce che colore,
cede luminosità ai colori circostanti: e di questo
si dimostra sempre consapevole l'Orsini: egli ri-
corda che il bianco puro è « per sua natura fug-
gente » e consiglia di non adoperarlo « sul davanti »
della pittura, di sostituirlo, piuttosto, con dei
gialli chiari perchè la scena dipinta non sembri
« ritagliata e piatta nel suo insieme ».
La modernità di ricerca del nostro autore lo
spinge al'ora a classificare sommariamente, ma con
vero senso critico, i colori principali in rapporto alla
loro qualità aerea: così, egli, al capitolo V « dei co-
lori » nel ■ Trattato di geometria pratica »' dice a
proposito dell'azzurro che « è molto leggero, ed è
assai dolce e non si può far venire innanzi che met-
tendolo accanto a quei colori che hanno del terrestre »,
e d'altri colori, ugualmente mancanti di Valore
cromatico: « perchè il problema sia appoggiato
alle vere regole della prospettiva aerea » egli dice
«si deve stabilire per principio che i gradi del co-
1 Le scene, ecc., pag. 35.
2 Pag. 198.
lorito van composti con tanto più di bianco o di
nero o d'altri colori partecipanti dell'aria, quanto
più vanno a sfuggire verso l'orizzonte»1 questo
« sfuggire » verso il fondo della scena, deve avve-
nire grado a grado, seconda l'Orsini: mai con vio-
lenti passaggi: « sul davanti della prospettiva »
aggiunge « si caricano tutte le ombre, a grado che
le tinte accompagnano in dentro l'architettura deb-
bono svanire dal proprio colore, ed entrare nel-
l'ultimo grado, che è il pavonazzo rossiccio assai
chiaro ».
Senza dubbio l'Orsini, con questa scala ideale di
colori secondo la loro maggiore o minore forza
cromatica, porta molto innanzi, la ricerca nel
campo coloristico: egli si trova, anzi, ad affrontare
il problema centrale di tutta la pittura moderna:
l'esaltazione reciproca dei colori per complemen-
tarismo:
« Per colorire il fondo » egli scrive, illustrando
una sua scena di paese « mi son servito della terra
nera di Roma unita col bianco e con la terra rossa
d'I nghilterra... e sul davanti ho usato la terra nera,
la terra d'ombra, la terra gialla chiara e oscura e
detta terra rossa... non ho mai nelle ombre del da-
vanti meschiato il bianco, fuorché in qualche
tinta bigia del davanti... ho anche talvolta usato
dell' indico per moderare l'acutezza dei gialli e dei
rossi nelle parti ombrate ».2 E dall'aver notato che
i colori influiscono uno sull'altro, l'Orsini trae la
conseguenza immediata che sia necessario servirsi
di questa reciproca esaltazione di « piazze » lumi-
nose, separando sottilmente le tinte, equilibrando,
in certo modo, la forza del colore puro con l'acco-
starvi macchie di colore di natura diversa. Questo
divisionismo embrionale non rappresenta certo
una novità nella Storia della pittura, egli tuttavia
ne fa la più larga e personale applicazione nella pit-
tura di scena, intuendo tutta l'importanza che
questo « mezzo » poteva avere nel campo della sce-
nografia, indirizzata ormai verso quella carat-
teristica forma di verismo paesistico dominante
in tutta la fine del settecento.
« Il buon gusto del colorito » egli dice « domanda
che nel dipingere le prospettive non si faccia uso
d'una sola tinta, ma che questa sia macchiata,
variata e dirotta » e. dirompere le tinte, per lo sce-
nografo, vale: spezzarle,3 variarle cioè in modo che
le « piazze » non appaiano intere e opache, ma ac-
quistino quella luminosità delle grandi masse av-
volte dalla luce, che sembrano realmente frantu-
1 Trattato di geometria, ecc., cap. V, pag. 198 e Seggi
2 Le scene, ecc., pag. in.
3 «... in guisa tormentateli dice l'Orsini «e tutta la vivezza
della tinta... nell'oggetto che dee saltar fuori ». (V. Le
scene, ecc., pag. no).
L'Arte XXVI, 16.