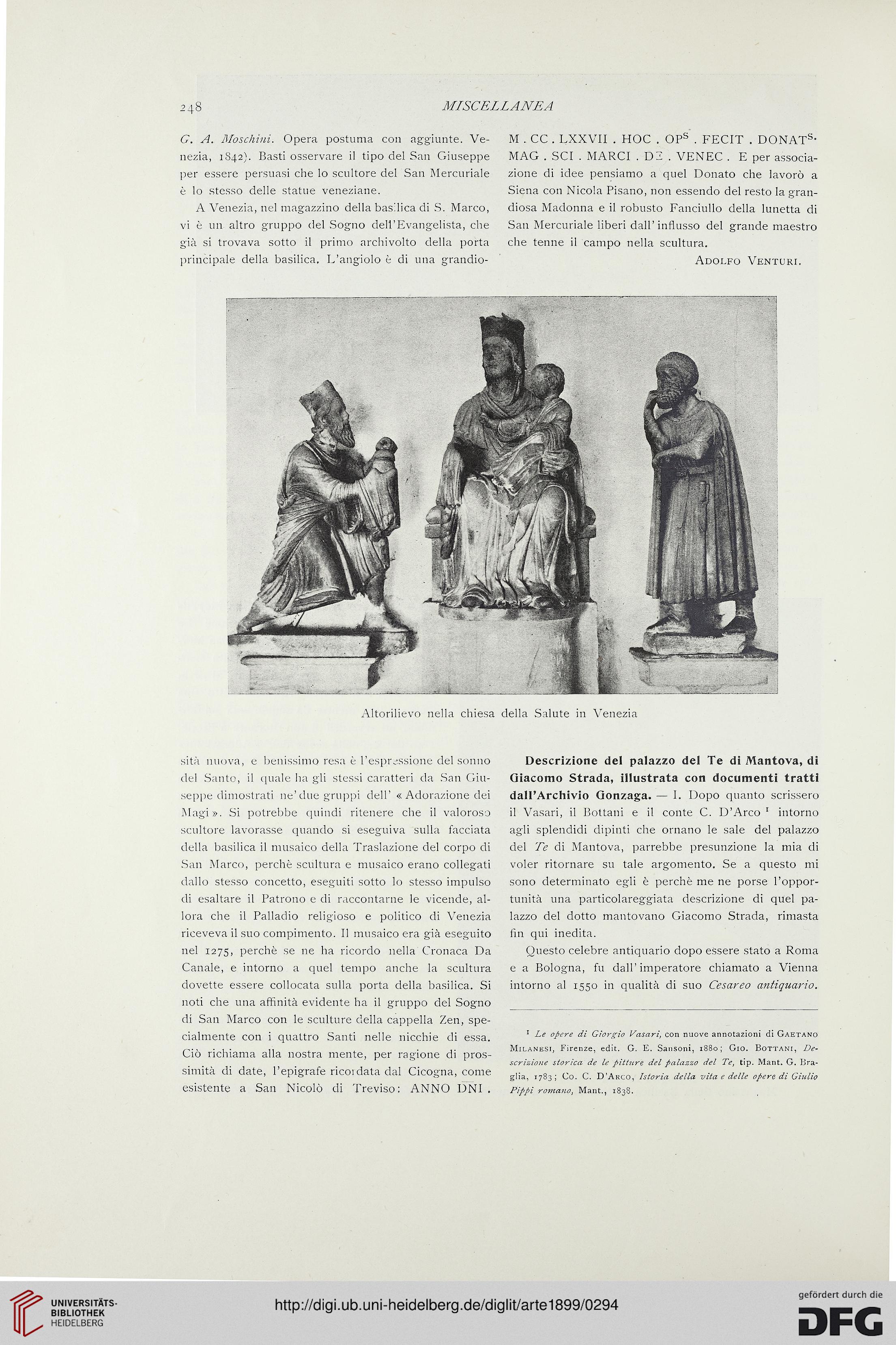248
MISCELLANEA
G. A. Mose/lini. Opera postuma con aggiunte. Ve-
nezia, 1842). Basti osservare il tipo del San Giuseppe
per essere persuasi che lo scultore elei San Mercuriale
è lo stesso delle statue veneziane.
A Venezia, nel magazzino della basilica di S. Marco,
vi è un altro gruppo del Sogno dell'Evangelista, che
già si trovava sotto il primo archivolto della porta
principale della basilica. L'angiolo è di una grandio-
M . CC . LXXVII . HOC . OPs . FECIT . DONATs*
MAG . SCI . MARCI . DZ . VENEC . E per associa-
zione di idee pensiamo a quel Donato che lavorò a
Siena con Nicola Pisano, non essendo del resto la gran-
diosa Madonna e il robusto Fanciullo della lunetta di
San Mercuriale liberi dall'influsso del grande maestro
che tenne il campo nella scultura.
Adolfo Venturi.
Altorilievo nella chiesa della Salute in Venezia
sita nuova, e benissimo resa è l'espressione del sonno
del Santo, il (piale ha gli stessi caratteri da San Giu-
seppe dimostrati ne'due gruppi dell' « Adorazione dei
Magi». Si potrebbe quindi ritenere che il valoroso
scultore lavorasse quando si eseguiva sulla facciata
della basilica il musaico della Traslazione del corpo di
San Marco, perchè scultura e musaico erano collegati
dallo stesso concetto, eseguiti sotto lo stesso impulso
di esaltare il Patrono e di raccontarne le vicende, al-
lora che il Palladio religioso e politico di Venezia
riceveva il suo compimento. Il musaico era già eseguito
nel 1275, perchè se ne ha ricordo nella Cronaca Da
Canale, e intorno a quel tempo anche la scultura
dovette essere collocata sulla porta della basilica. Si
noti che una affinità evidente ha il gruppo del Sogno
di San Marco con le sculture della cappella Zen, spe-
cialmente con i quattro Santi nelle nicchie di essa.
Ciò richiama alla nostra mente, per ragione di pros-
simità di date, l'epigrafe ricordata dal Cicogna, come
esistente a San Nicolò di Treviso: ANNO DNI .
Descrizione del palazzo del Te di Mantova, di
Giacomo Strada, illustrata con documenti tratti
dall'Archivio Gonzaga. — 1. Dopo quanto scrissero
il Vasari, il Bottani e il conte C. D'Arco 1 intorno
agli splendidi dipinti che ornano le sale del palazzo
del Te di Mantova, parrebbe presunzione la mia di
voler ritornare su tale argomento. Se a questo mi
sono determinato egli è perchè me ne porse l'oppor-
tunità una particolareggiata descrizione di quel pa-
lazzo del dotto mantovano Giacomo Strada, rimasta
fin qui inedita.
Questo celebre antiquario dopo essere stato a Roma
e a Bologna, fu dall'imperatore chiamato a Vienna
intorno al 1550 in qualità di suo Cesareo antiquario.
1 Le opere di Giorgio Vasari, con nuove annotazioni di Gaetano
Milanesi, Firenze, edit. G. e. Sansoni, 1880; Gio. Bottani, De-
scrizione storica de le pitture del palazzo del Te, tip. Mant. G. Bra-
glia, 1783; Co. C. D'Anto, Istoria della -vita e delle opere di Giulio
Pippi romatw, Mant., 1838.
MISCELLANEA
G. A. Mose/lini. Opera postuma con aggiunte. Ve-
nezia, 1842). Basti osservare il tipo del San Giuseppe
per essere persuasi che lo scultore elei San Mercuriale
è lo stesso delle statue veneziane.
A Venezia, nel magazzino della basilica di S. Marco,
vi è un altro gruppo del Sogno dell'Evangelista, che
già si trovava sotto il primo archivolto della porta
principale della basilica. L'angiolo è di una grandio-
M . CC . LXXVII . HOC . OPs . FECIT . DONATs*
MAG . SCI . MARCI . DZ . VENEC . E per associa-
zione di idee pensiamo a quel Donato che lavorò a
Siena con Nicola Pisano, non essendo del resto la gran-
diosa Madonna e il robusto Fanciullo della lunetta di
San Mercuriale liberi dall'influsso del grande maestro
che tenne il campo nella scultura.
Adolfo Venturi.
Altorilievo nella chiesa della Salute in Venezia
sita nuova, e benissimo resa è l'espressione del sonno
del Santo, il (piale ha gli stessi caratteri da San Giu-
seppe dimostrati ne'due gruppi dell' « Adorazione dei
Magi». Si potrebbe quindi ritenere che il valoroso
scultore lavorasse quando si eseguiva sulla facciata
della basilica il musaico della Traslazione del corpo di
San Marco, perchè scultura e musaico erano collegati
dallo stesso concetto, eseguiti sotto lo stesso impulso
di esaltare il Patrono e di raccontarne le vicende, al-
lora che il Palladio religioso e politico di Venezia
riceveva il suo compimento. Il musaico era già eseguito
nel 1275, perchè se ne ha ricordo nella Cronaca Da
Canale, e intorno a quel tempo anche la scultura
dovette essere collocata sulla porta della basilica. Si
noti che una affinità evidente ha il gruppo del Sogno
di San Marco con le sculture della cappella Zen, spe-
cialmente con i quattro Santi nelle nicchie di essa.
Ciò richiama alla nostra mente, per ragione di pros-
simità di date, l'epigrafe ricordata dal Cicogna, come
esistente a San Nicolò di Treviso: ANNO DNI .
Descrizione del palazzo del Te di Mantova, di
Giacomo Strada, illustrata con documenti tratti
dall'Archivio Gonzaga. — 1. Dopo quanto scrissero
il Vasari, il Bottani e il conte C. D'Arco 1 intorno
agli splendidi dipinti che ornano le sale del palazzo
del Te di Mantova, parrebbe presunzione la mia di
voler ritornare su tale argomento. Se a questo mi
sono determinato egli è perchè me ne porse l'oppor-
tunità una particolareggiata descrizione di quel pa-
lazzo del dotto mantovano Giacomo Strada, rimasta
fin qui inedita.
Questo celebre antiquario dopo essere stato a Roma
e a Bologna, fu dall'imperatore chiamato a Vienna
intorno al 1550 in qualità di suo Cesareo antiquario.
1 Le opere di Giorgio Vasari, con nuove annotazioni di Gaetano
Milanesi, Firenze, edit. G. e. Sansoni, 1880; Gio. Bottani, De-
scrizione storica de le pitture del palazzo del Te, tip. Mant. G. Bra-
glia, 1783; Co. C. D'Anto, Istoria della -vita e delle opere di Giulio
Pippi romatw, Mant., 1838.