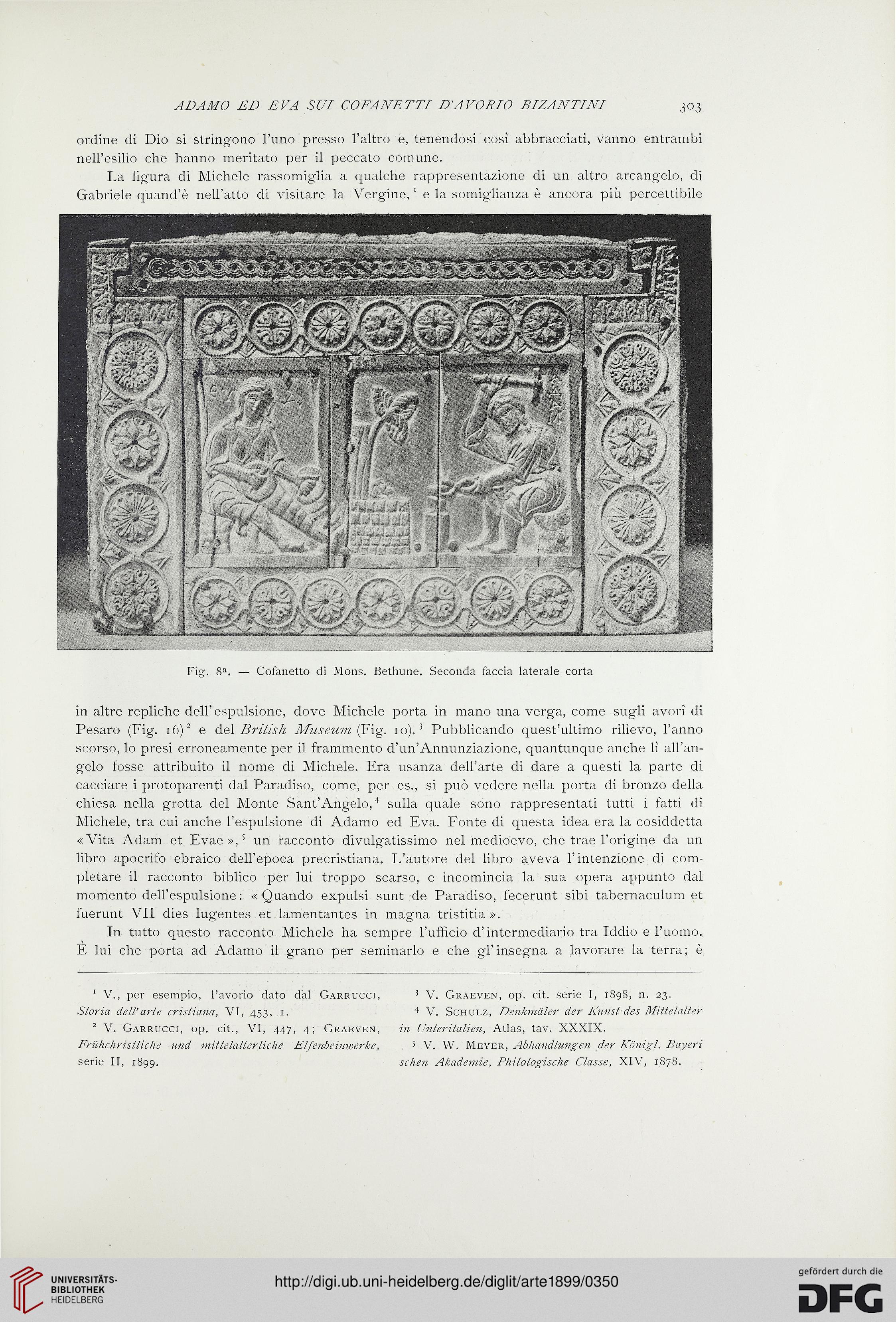ADAMO ED EVA SUI COFANETTI D'AVORIO BIZANTINI
303
ordine di Dio si stringono l'uno presso l'altro e, tenendosi così abbracciati, vanno entrambi
nell'esilio che hanno meritato per il peccato comune.
Là figura di Michele rassomiglia a qualche rappresentazione di un altro arcangelo, di
Gabriele quand'è nell'atto di visitare la Vergine, ' e la somiglianza è ancora più percettibile
Fig. 8a. — Cofanetto di Mons. Bethune. Seconda faccia laterale corta
in altre repliche dell'espulsione, dove Michele porta in mano una verga, come sugli avori di
Pesaro (Fig. 16)2 e del Brìtish Museum (Fig. 10).3 Pubblicando quest'ultimo rilievo, l'anno
scorso, lo presi erroneamente per il frammento d'un'Annunziazione, quantunque anche lì all'an-
gelo fosse attribuito il nome di Michele. Era usanza dell'arte di dare a questi la parte di
cacciare i protoparenti dal Paradiso, come, per es., si può vedere nella porta di bronzo della
chiesa nella grotta del Monte Sant'Angelo,4 sulla quale sono rappresentati tutti i fatti di
Michele, tra cui anche l'espulsione di Adamo ed Eva. Fonte di questa idea era la cosiddetta
«Vita Adam et Evae»,5 un racconto divulgatissimo nel medioevo, che trae l'origine da un
libro apocrifo ebraico dell'epoca precristiana. L'autore del libro aveva l'intenzione di com-
pletare il racconto biblico per lui troppo scarso, e incomincia la sua opera appunto dal
momento dell'espulsione: «Quando expulsi sunt de Paradiso, fecerunt sibi tabernaculum et
fuerunt VII dies lugentes et lamentantes in magna tristitia ».
In tutto questo racconto-Michele ha sempre l'ufficio d'intermediario tra Iddio e l'uomo.
E lui che porta ad Adamo il grano per seminarlo e che gl'insegna a lavorare la terra; è
1 V., per esempio, l'avorio dato dal Garrucci,
Storia dell'arte cristiana, VI, 453, 1.
2 V. Garrucci, op. cit., VI, 447, 4; Graeven,
Fruhchrislliche und mii'telalterlidie E/fenbeimverke,
serie II, 1899.
5 V. Graeven, op. cit. serie I, 1898, n. 23.
4 V. Schulz, Denkmàler der Kunst des Mittelalter
in Unteritalien, Atlas, tav. XXXIX.
5 V. W. Meyer, Abhandlungen der Kónigl. Bay eri
schen Akademie, Philologische Classe, XIV, 1878.
303
ordine di Dio si stringono l'uno presso l'altro e, tenendosi così abbracciati, vanno entrambi
nell'esilio che hanno meritato per il peccato comune.
Là figura di Michele rassomiglia a qualche rappresentazione di un altro arcangelo, di
Gabriele quand'è nell'atto di visitare la Vergine, ' e la somiglianza è ancora più percettibile
Fig. 8a. — Cofanetto di Mons. Bethune. Seconda faccia laterale corta
in altre repliche dell'espulsione, dove Michele porta in mano una verga, come sugli avori di
Pesaro (Fig. 16)2 e del Brìtish Museum (Fig. 10).3 Pubblicando quest'ultimo rilievo, l'anno
scorso, lo presi erroneamente per il frammento d'un'Annunziazione, quantunque anche lì all'an-
gelo fosse attribuito il nome di Michele. Era usanza dell'arte di dare a questi la parte di
cacciare i protoparenti dal Paradiso, come, per es., si può vedere nella porta di bronzo della
chiesa nella grotta del Monte Sant'Angelo,4 sulla quale sono rappresentati tutti i fatti di
Michele, tra cui anche l'espulsione di Adamo ed Eva. Fonte di questa idea era la cosiddetta
«Vita Adam et Evae»,5 un racconto divulgatissimo nel medioevo, che trae l'origine da un
libro apocrifo ebraico dell'epoca precristiana. L'autore del libro aveva l'intenzione di com-
pletare il racconto biblico per lui troppo scarso, e incomincia la sua opera appunto dal
momento dell'espulsione: «Quando expulsi sunt de Paradiso, fecerunt sibi tabernaculum et
fuerunt VII dies lugentes et lamentantes in magna tristitia ».
In tutto questo racconto-Michele ha sempre l'ufficio d'intermediario tra Iddio e l'uomo.
E lui che porta ad Adamo il grano per seminarlo e che gl'insegna a lavorare la terra; è
1 V., per esempio, l'avorio dato dal Garrucci,
Storia dell'arte cristiana, VI, 453, 1.
2 V. Garrucci, op. cit., VI, 447, 4; Graeven,
Fruhchrislliche und mii'telalterlidie E/fenbeimverke,
serie II, 1899.
5 V. Graeven, op. cit. serie I, 1898, n. 23.
4 V. Schulz, Denkmàler der Kunst des Mittelalter
in Unteritalien, Atlas, tav. XXXIX.
5 V. W. Meyer, Abhandlungen der Kónigl. Bay eri
schen Akademie, Philologische Classe, XIV, 1878.