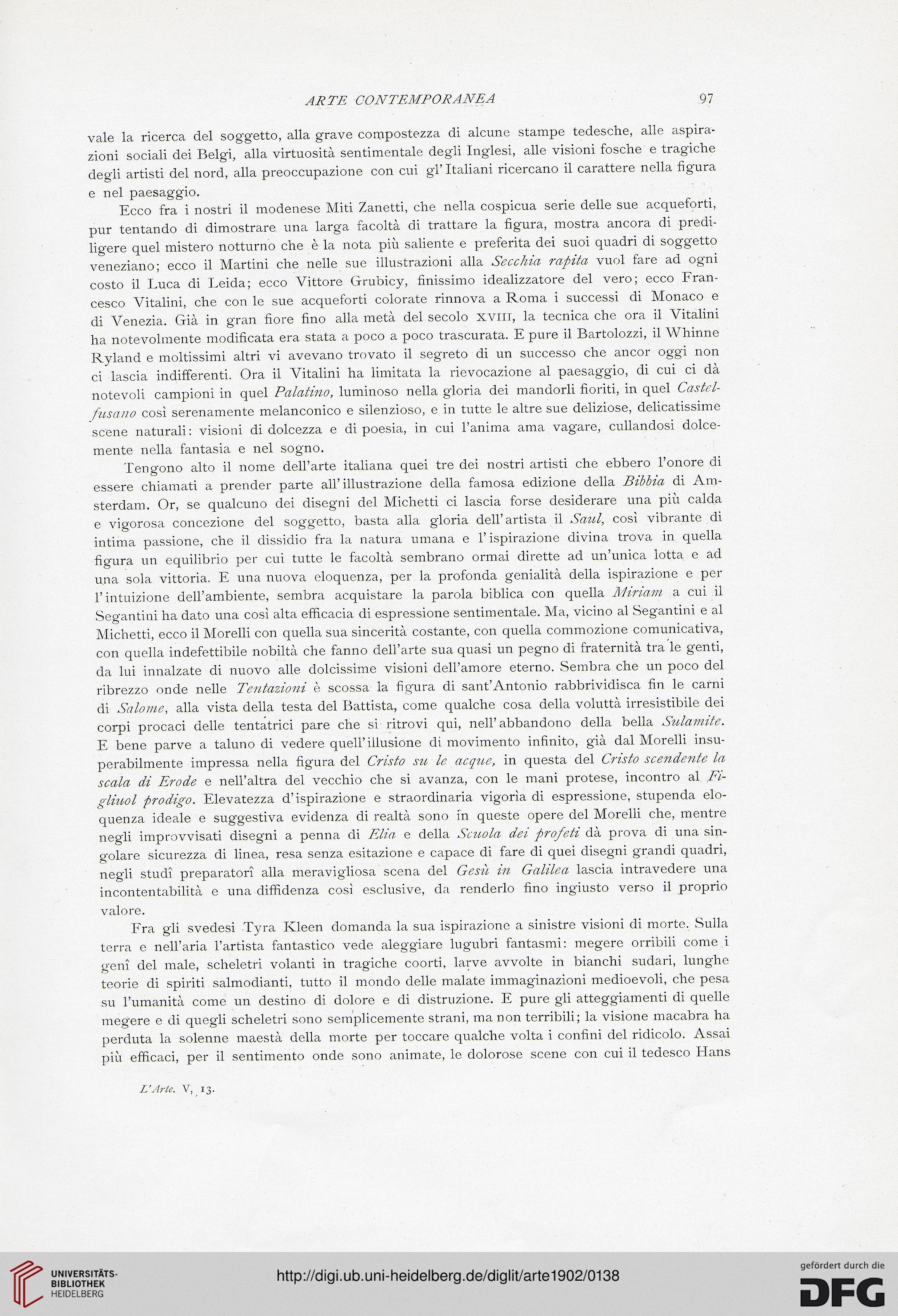ARTE CONTEMPORANEA
97
vale la ricerca del soggetto, alla grave compostezza di alcune stampe tedesche, alle aspira-
zioni sociali dei Belgi, alla virtuosità sentimentale degli Inglesi, alle visioni fosche e tragiche
degli artisti del nord, alla preoccupazione con cui gl’Italiani ricercano il carattere nella figura
e nel paesaggio.
Ecco fra i nostri il modenese Miti Zanetti, che nella cospicua serie delle sue acqueforti,
pur tentando di dimostrare una larga facoltà di trattare la figura, mostra ancora di predi-
ligere quel mistero notturno che è la nota più saliente e preferita dei suoi quadri di soggetto
veneziano; ecco il Martini che nelle sue illustrazioni alla Secchia rapita vuol fare ad ogni
costo il Luca di Leida; ecco Vittore Grubicy, finissimo idealizzatore del vero; ecco Fran-
cesco Vitalini, che con le sue acqueforti colorate rinnova a Roma i successi di Monaco e
di Venezia. Già in gran fiore fino alla metà del secolo XVIII, la tecnica che ora il Vitalini
ha notevolmente modificata era stata a poco a poco trascurata. E pure il Bartolozzi, il Whinne
Ryland e moltissimi altri vi avevano trovato il segreto di un successo che ancor oggi non
ci lascia indifferenti. Ora il Vitalini ha limitata la rievocazione al paesaggio, di cui ci dà
notevoli campioni in quel Palatino, luminoso nella gloria dei mandorli fioriti, in quel Castel-
fusano così serenamente melanconico e silenzioso, e in tutte le altre sue deliziose, delicatissime
scene naturali: visioni di dolcezza e di poesia, in cui l’anima ama vagare, cullandosi dolce-
mente nella fantasia e nel sogno.
Tengono alto il nome dell’arte italiana quei tre dei nostri artisti che ebbero l’onore di
essere chiamati a prender parte all’illustrazione della famosa edizione della Bibbia di Am-
sterdam. Or, se qualcuno dei disegni del Michetti ci lascia forse desiderare una più calda
e vigorosa concezione del soggetto, basta alla gloria dell’artista il Saul, così vibrante di
intima passione, che il dissidio fra la natura umana e l’ispirazione divina trova in quella
figura un equilibrio per cui tutte le facoltà sembrano ormai dirette ad un’unica lotta e ad
una sola vittoria. E una nuova eloquenza, per la profonda genialità della ispirazione e per
l’intuizione dell’ambiente, sembra acquistare la parola biblica con quella Miriam a cui il
Segantini ha dato una così alta efficacia di espressione sentimentale. Ma, vicino al Segantini e al
Michetti, ecco il Morelli con quella sua sincerità costante, con quella commozione comunicativa,
con quella indefettibile nobiltà che fanno dell’arte sua quasi un pegno di fraternità tra le genti,
da lui innalzate di nuovo alle dolcissime visioni dell’amore eterno. Sembra che un poco del
ribrezzo onde nelle Tentazioni è scossa la figura di sant’Antonio rabbrividisca fin le carni
di Salome, alla vista della testa del Battista, come qualche cosa della voluttà irresistibile dei
corpi procaci delle tentatrici pare che si ritrovi qui, nell’abbandono della bella Sulamite.
E bene parve a taluno di vedere quell’illusione di movimento infinito, già dal Morelli insu-
perabilmente impressa nella figura del Cristo su le acque, in questa del Cristo scendente la
scala di Erode e nell’altra del vecchio che si avanza, con le mani protese, incontro al Fi-
gliuol prodigo. Elevatezza d’ispirazione e straordinaria vigorìa di espressione, stupenda elo-
quenza ideale e suggestiva evidenza di realtà sono in queste opere del Morelli che, mentre
negli improvvisati disegni a penna di Elia e della Scuola dei profeti dà prova di una sin-
golare sicurezza di linea, resa senza esitazione e capace di fare di quei disegni grandi quadri,
negli studi preparatori alla meravigliosa scena del Gesù in Galilea lascia intravedere una
incontentabilità e una diffidenza così esclusive, da renderlo fino ingiusto verso il proprio
valore.
Fra gli svedesi Tyra Kleen domanda la sua ispirazione a sinistre visioni di morte. Sulla
terra e nell’aria l’artista fantastico vede aleggiare lugubri fantasmi: megere orribili corne i
geni del male, scheletri volanti in tragiche coorti, larve avvolte in bianchi sudari, lunghe
teorie di spiriti salmodianti, tutto il mondo delle malate immaginazioni medioevoli, che pesa
su l’umanità come un destino di dolore e di distruzione. E pure gli atteggiamenti di quelle
megere e di quegli scheletri sono semplicemente strani, ma non terribili; la visione macabra ha
perduta la solenne maestà della morte per toccare qualche volta i confini del ridicolo. Assai
più efficaci, per il sentimento onde sono animate, le dolorose scene con cui il tedesco Hans
L'Arte. V, 13.
97
vale la ricerca del soggetto, alla grave compostezza di alcune stampe tedesche, alle aspira-
zioni sociali dei Belgi, alla virtuosità sentimentale degli Inglesi, alle visioni fosche e tragiche
degli artisti del nord, alla preoccupazione con cui gl’Italiani ricercano il carattere nella figura
e nel paesaggio.
Ecco fra i nostri il modenese Miti Zanetti, che nella cospicua serie delle sue acqueforti,
pur tentando di dimostrare una larga facoltà di trattare la figura, mostra ancora di predi-
ligere quel mistero notturno che è la nota più saliente e preferita dei suoi quadri di soggetto
veneziano; ecco il Martini che nelle sue illustrazioni alla Secchia rapita vuol fare ad ogni
costo il Luca di Leida; ecco Vittore Grubicy, finissimo idealizzatore del vero; ecco Fran-
cesco Vitalini, che con le sue acqueforti colorate rinnova a Roma i successi di Monaco e
di Venezia. Già in gran fiore fino alla metà del secolo XVIII, la tecnica che ora il Vitalini
ha notevolmente modificata era stata a poco a poco trascurata. E pure il Bartolozzi, il Whinne
Ryland e moltissimi altri vi avevano trovato il segreto di un successo che ancor oggi non
ci lascia indifferenti. Ora il Vitalini ha limitata la rievocazione al paesaggio, di cui ci dà
notevoli campioni in quel Palatino, luminoso nella gloria dei mandorli fioriti, in quel Castel-
fusano così serenamente melanconico e silenzioso, e in tutte le altre sue deliziose, delicatissime
scene naturali: visioni di dolcezza e di poesia, in cui l’anima ama vagare, cullandosi dolce-
mente nella fantasia e nel sogno.
Tengono alto il nome dell’arte italiana quei tre dei nostri artisti che ebbero l’onore di
essere chiamati a prender parte all’illustrazione della famosa edizione della Bibbia di Am-
sterdam. Or, se qualcuno dei disegni del Michetti ci lascia forse desiderare una più calda
e vigorosa concezione del soggetto, basta alla gloria dell’artista il Saul, così vibrante di
intima passione, che il dissidio fra la natura umana e l’ispirazione divina trova in quella
figura un equilibrio per cui tutte le facoltà sembrano ormai dirette ad un’unica lotta e ad
una sola vittoria. E una nuova eloquenza, per la profonda genialità della ispirazione e per
l’intuizione dell’ambiente, sembra acquistare la parola biblica con quella Miriam a cui il
Segantini ha dato una così alta efficacia di espressione sentimentale. Ma, vicino al Segantini e al
Michetti, ecco il Morelli con quella sua sincerità costante, con quella commozione comunicativa,
con quella indefettibile nobiltà che fanno dell’arte sua quasi un pegno di fraternità tra le genti,
da lui innalzate di nuovo alle dolcissime visioni dell’amore eterno. Sembra che un poco del
ribrezzo onde nelle Tentazioni è scossa la figura di sant’Antonio rabbrividisca fin le carni
di Salome, alla vista della testa del Battista, come qualche cosa della voluttà irresistibile dei
corpi procaci delle tentatrici pare che si ritrovi qui, nell’abbandono della bella Sulamite.
E bene parve a taluno di vedere quell’illusione di movimento infinito, già dal Morelli insu-
perabilmente impressa nella figura del Cristo su le acque, in questa del Cristo scendente la
scala di Erode e nell’altra del vecchio che si avanza, con le mani protese, incontro al Fi-
gliuol prodigo. Elevatezza d’ispirazione e straordinaria vigorìa di espressione, stupenda elo-
quenza ideale e suggestiva evidenza di realtà sono in queste opere del Morelli che, mentre
negli improvvisati disegni a penna di Elia e della Scuola dei profeti dà prova di una sin-
golare sicurezza di linea, resa senza esitazione e capace di fare di quei disegni grandi quadri,
negli studi preparatori alla meravigliosa scena del Gesù in Galilea lascia intravedere una
incontentabilità e una diffidenza così esclusive, da renderlo fino ingiusto verso il proprio
valore.
Fra gli svedesi Tyra Kleen domanda la sua ispirazione a sinistre visioni di morte. Sulla
terra e nell’aria l’artista fantastico vede aleggiare lugubri fantasmi: megere orribili corne i
geni del male, scheletri volanti in tragiche coorti, larve avvolte in bianchi sudari, lunghe
teorie di spiriti salmodianti, tutto il mondo delle malate immaginazioni medioevoli, che pesa
su l’umanità come un destino di dolore e di distruzione. E pure gli atteggiamenti di quelle
megere e di quegli scheletri sono semplicemente strani, ma non terribili; la visione macabra ha
perduta la solenne maestà della morte per toccare qualche volta i confini del ridicolo. Assai
più efficaci, per il sentimento onde sono animate, le dolorose scene con cui il tedesco Hans
L'Arte. V, 13.