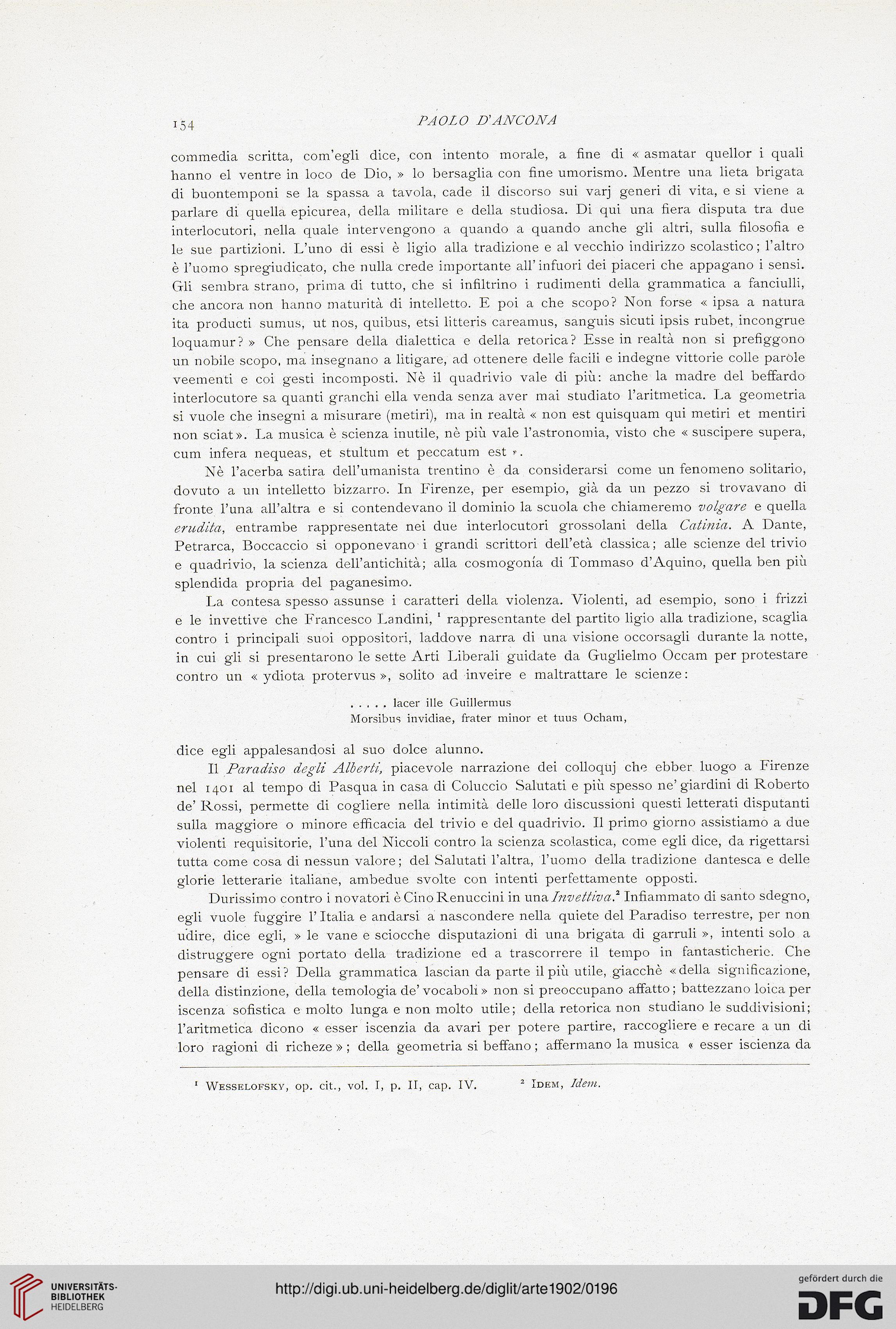154
PAOLO D'ANCONA
commedia scritta, com’egli dice, con intento morale, a fine di « asmatar quellor i quali
hanno el ventre in loco de Dio, » lo bersaglia con fine umorismo. Mentre una lieta brigata
di buontemponi se la spassa a tavola, cade il discorso sui varj generi di vita, e si viene a
parlare di quella epicurea, della militare e della studiosa. Di qui una fiera disputa tra due
interlocutori, nella quale intervengono a quando à quando anche gli altri, sulla filosofia e
le sue partizioni. L’uno di essi è ligio alla tradizione e al vecchio indirizzo scolastico ; l’altro
è l’uomo spregiudicato, che nulla crede importante all’infuori dei piaceri che appagano i sensi.
Gli sembra strano, prima di tutto, che si infiltrino i rudimenti della grammatica a fanciulli,
che ancora non hanno maturità di intelletto. E poi a che scopo? Non forse « ipsa a natura
ita producti sumus, ut nos, quibus, etsi litteris careamus, sanguis sicuti ipsis rubet, incongrue
loquamur? » Che pensare della dialettica e della retorica? Esse in realtà non si prefiggono
un nobile scopo, ma insegnano a litigare, ad ottenere delle facili e indegne vittorie colle paròle
veementi e coi gesti incomposti. Nè il quadrivio vale di più: anche la madre del beffardo
interlocutore sa quanti granchi ella venda senza aver mai studiato l’aritmetica. La geometria
si vuole che insegni a misurare (metiri), ma in realtà « non est quisquam qui metiri et mentiri
non sciat». La musica è scienza inutile, nè più vale l’astronomia, visto che « suscipere supera,
cum infera nequeas, et stultum et peccatum est *.
Nè l’acerba satira dell’umanista trentino è da considerarsi come un fenomeno solitario,
dovuto a un intelletto bizzarro. In Firenze, per esempio, già da un pezzo si trovavano di
fronte l’una all’altra e si contendevano il dominio la scuola che chiameremo volgare e quella
erudita, entrambe rappresentate nei due interlocutori grossolani della Catinia. A Dante,
Petrarca, Boccaccio si opponevano i grandi scrittori dell’età classica ; alle scienze del trivio
e quadrivio, la scienza dell’antichità; alla cosmogonia di Tommaso d’Aquino, quella ben più
splendida propria del paganesimo.
La contesa spesso assunse i caratteri della violenza. Violenti, ad esempio, sono i frizzi
e le invettive che Francesco Landini, 1 rappresentante del partito ligio alla tradizione, scaglia
contro i principali suoi oppositori, laddove narra di una visione occorsagli durante la notte,
in cui gli si presentarono le sette Arti Liberali guidate da Guglielmo Occam per protestare
contro un « ydiota protervus », solito ad inveire e maltrattare le scienze :
.lacer ille Guillermus
Morsibus invidiae, frater minor et tuus Ocham,
dice egli appalesandosi al suo dolce alunno.
Il Paradiso degli Alberti, piacevole narrazione dei colloquj che ebber luogo a Firenze
nel 1401 al tempo di Pasqua in casa di Coluccio Salutati e più spesso ne’giardini di Roberto
de’ Rossi, permette di cogliere nella intimità delle loro discussioni questi letterati disputanti
sulla maggiore o minore efficacia del trivio e del quadrivio. Il primo giorno assistiamo a due
violenti requisitorie, l’un a del Niccoli contro la scienza scolastica, come egli dice, da rigettarsi
tutta come cosa di nessun valore ; del Salutati l’altra, l’uomo della tradizione dantesca e delle
glorie letterarie italiane, ambedue svolte con intenti perfettamente opposti.
Durissimo contro i novatori è Cino Renuccini in una Invettiva? Infiammato di santo sdegno,
egli vuole fuggire l’Italia e andarsi a nascondere nella quiete del Paradiso terrestre, per non
udire, dice egli, » le vane e sciocche disputazioni di una brigata di garruli », intenti solo a
distruggere ogni portato della tradizione ed a trascorrere il tempo in fantasticherie. Che
pensare di essi? Della grammatica lasciali da parte il più utile, giacché «della significazione,
della distinzione, della temologia de’ vocaboli » non si preoccupano affatto ; battezzano loica per
iscenza sofistica e molto lunga e non molto utile; della retorica non studiano le suddivisioni;
l’aritmetica dicono « esser iscenzia da avari per potere partire, raccogliere e recare a un di
loro ragioni di richeze » ; della geometria si beffano ; affermano la musica << esser iscienza da
1 Wesselofsky, op. cit., voi. I, p. II, cap. IV. 2 Idem, Idem.
PAOLO D'ANCONA
commedia scritta, com’egli dice, con intento morale, a fine di « asmatar quellor i quali
hanno el ventre in loco de Dio, » lo bersaglia con fine umorismo. Mentre una lieta brigata
di buontemponi se la spassa a tavola, cade il discorso sui varj generi di vita, e si viene a
parlare di quella epicurea, della militare e della studiosa. Di qui una fiera disputa tra due
interlocutori, nella quale intervengono a quando à quando anche gli altri, sulla filosofia e
le sue partizioni. L’uno di essi è ligio alla tradizione e al vecchio indirizzo scolastico ; l’altro
è l’uomo spregiudicato, che nulla crede importante all’infuori dei piaceri che appagano i sensi.
Gli sembra strano, prima di tutto, che si infiltrino i rudimenti della grammatica a fanciulli,
che ancora non hanno maturità di intelletto. E poi a che scopo? Non forse « ipsa a natura
ita producti sumus, ut nos, quibus, etsi litteris careamus, sanguis sicuti ipsis rubet, incongrue
loquamur? » Che pensare della dialettica e della retorica? Esse in realtà non si prefiggono
un nobile scopo, ma insegnano a litigare, ad ottenere delle facili e indegne vittorie colle paròle
veementi e coi gesti incomposti. Nè il quadrivio vale di più: anche la madre del beffardo
interlocutore sa quanti granchi ella venda senza aver mai studiato l’aritmetica. La geometria
si vuole che insegni a misurare (metiri), ma in realtà « non est quisquam qui metiri et mentiri
non sciat». La musica è scienza inutile, nè più vale l’astronomia, visto che « suscipere supera,
cum infera nequeas, et stultum et peccatum est *.
Nè l’acerba satira dell’umanista trentino è da considerarsi come un fenomeno solitario,
dovuto a un intelletto bizzarro. In Firenze, per esempio, già da un pezzo si trovavano di
fronte l’una all’altra e si contendevano il dominio la scuola che chiameremo volgare e quella
erudita, entrambe rappresentate nei due interlocutori grossolani della Catinia. A Dante,
Petrarca, Boccaccio si opponevano i grandi scrittori dell’età classica ; alle scienze del trivio
e quadrivio, la scienza dell’antichità; alla cosmogonia di Tommaso d’Aquino, quella ben più
splendida propria del paganesimo.
La contesa spesso assunse i caratteri della violenza. Violenti, ad esempio, sono i frizzi
e le invettive che Francesco Landini, 1 rappresentante del partito ligio alla tradizione, scaglia
contro i principali suoi oppositori, laddove narra di una visione occorsagli durante la notte,
in cui gli si presentarono le sette Arti Liberali guidate da Guglielmo Occam per protestare
contro un « ydiota protervus », solito ad inveire e maltrattare le scienze :
.lacer ille Guillermus
Morsibus invidiae, frater minor et tuus Ocham,
dice egli appalesandosi al suo dolce alunno.
Il Paradiso degli Alberti, piacevole narrazione dei colloquj che ebber luogo a Firenze
nel 1401 al tempo di Pasqua in casa di Coluccio Salutati e più spesso ne’giardini di Roberto
de’ Rossi, permette di cogliere nella intimità delle loro discussioni questi letterati disputanti
sulla maggiore o minore efficacia del trivio e del quadrivio. Il primo giorno assistiamo a due
violenti requisitorie, l’un a del Niccoli contro la scienza scolastica, come egli dice, da rigettarsi
tutta come cosa di nessun valore ; del Salutati l’altra, l’uomo della tradizione dantesca e delle
glorie letterarie italiane, ambedue svolte con intenti perfettamente opposti.
Durissimo contro i novatori è Cino Renuccini in una Invettiva? Infiammato di santo sdegno,
egli vuole fuggire l’Italia e andarsi a nascondere nella quiete del Paradiso terrestre, per non
udire, dice egli, » le vane e sciocche disputazioni di una brigata di garruli », intenti solo a
distruggere ogni portato della tradizione ed a trascorrere il tempo in fantasticherie. Che
pensare di essi? Della grammatica lasciali da parte il più utile, giacché «della significazione,
della distinzione, della temologia de’ vocaboli » non si preoccupano affatto ; battezzano loica per
iscenza sofistica e molto lunga e non molto utile; della retorica non studiano le suddivisioni;
l’aritmetica dicono « esser iscenzia da avari per potere partire, raccogliere e recare a un di
loro ragioni di richeze » ; della geometria si beffano ; affermano la musica << esser iscienza da
1 Wesselofsky, op. cit., voi. I, p. II, cap. IV. 2 Idem, Idem.