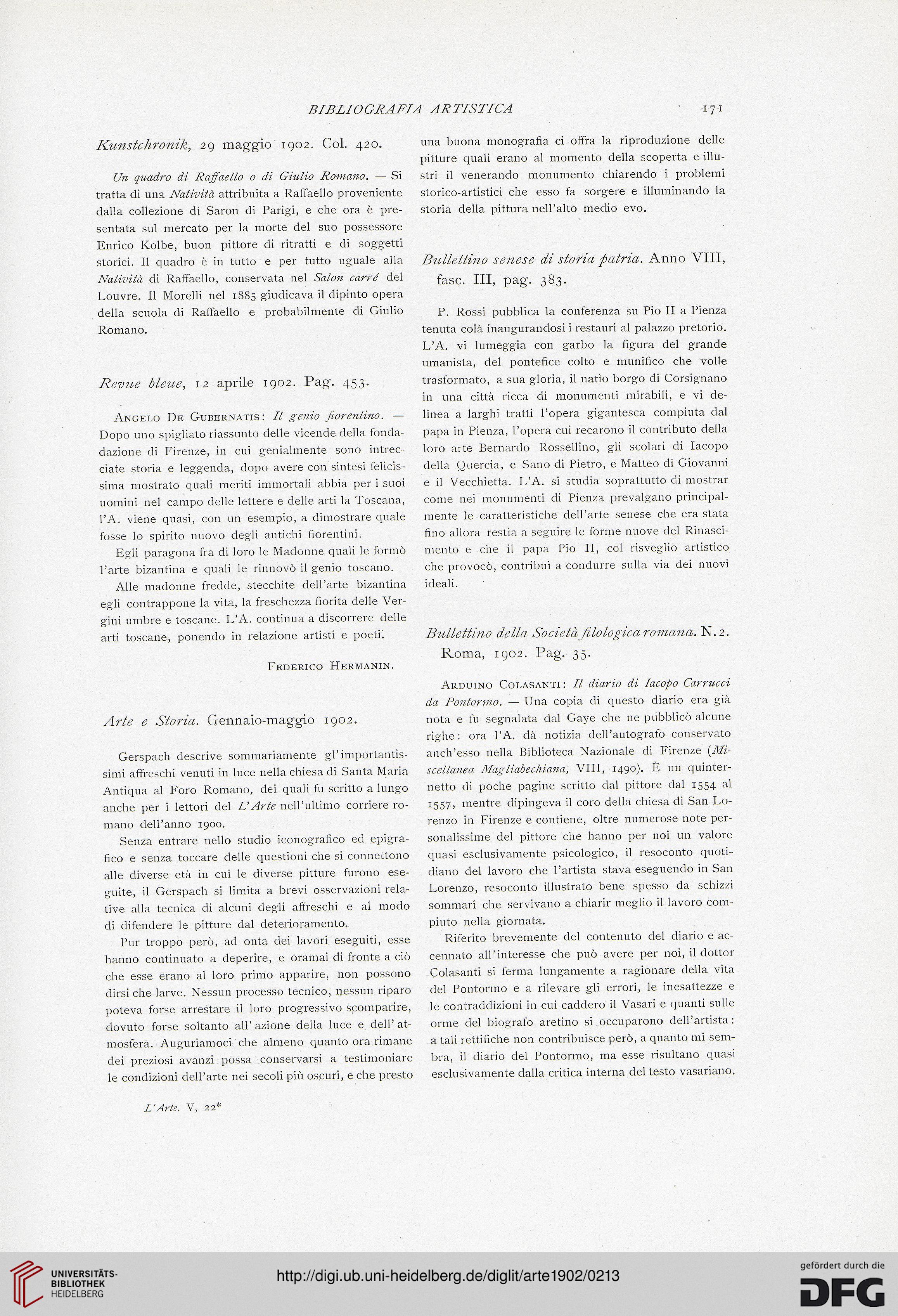BIBLIOGRAFIA ARTISTICA
Kunstchronik, 29 maggio 1902. Col. 420.
Un quadro di Raffaello o di Giulio Romano. — Si
tratta di una Natività attribuita a Raffaello proveniente
dalla collezione di Saron di Parigi, e che ora è pre-
sentata sul mercato per la morte del suo possessore
Enrico Kolbe, buon pittore di ritratti e di soggetti
storici. Il quadro è in tutto e per tutto uguale alla
Natività di Raffaello, conservata nel Salon carré del
Louvre. Il Morelli nel 1885 giudicava il dipinto opera
della scuola di Raffaello e probabilmente di Giulio
Romano.
Revue bleue, 12 aprile 1902. Pag. 453.
Angelo De Gubernatis : Il genio fiorentino. —
Dopo uno spigliato riassunto delle vicende della fonda-
dazione di Firenze, in cui genialmente sono intrec-
ciate storia e leggenda, dopo avere con sintesi felicis-
sima mostrato quali meriti immortali abbia per i suoi
uomini nel campo delle lettere e delle arti la Toscana,
l’A. viene quasi, con un esempio, a dimostrare quale
fosse lo spirito nuovo degli antichi fiorentini.
Egli paragona fra di loro le Madonne quali le formò
l’arte bizantina e quali le rinnovò il genio toscano.
Alle madonne fredde, stecchite dell’arte bizantina
egli contrappone la vita, la freschezza fiorita delle Ver-
gini umbre e toscane. L’A. continua a discorrere delle
arti toscane, ponendo in relazione artisti e poeti!
Federico Hermanin.
Arte e Storia. Gennaio-maggio 1902.
Gerspach descrive sommariamente gl’importantis-
simi affreschi venuti in luce nella chiesa di Santa Maria
Antiqua al Foro Romano, dei quali fu scritto a lungo
anche per i lettori del L'Arte nell’ultimo corriere ro-
mano dell’anno 1900.
Senza entrare nello studio iconografico ed epigra-
fico e senza toccare delle questioni che si connettono
alle diverse età in cui le diverse pitture furono ese-
guite, il Gerspach si limita a brevi osservazioni rela-
tive alla tecnica di alcuni degli affreschi e al modo
di difendere le pitture dal deterioramento.
Pur troppo però, ad onta dei lavori eseguiti, esse
hanno continuato a deperire, e oramai di fronte a ciò
che esse erano al loro primo apparire, non possono
dirsi che larve. Nessun processo tecnico, nessun riparo
poteva forse arrestare il loro progressivo spomparire,
dovuto forse soltanto all’azione della luce e dell’at-
mosfera. Auguriamoci che almeno quanto ora rimane
dei preziosi avanzi possa conservarsi a testimoniare
le condizioni dell’arte nei secoli più oscuri, e che presto
171
una buona monografia ci offra la riproduzione delle
pitture quali erano al momento della scoperta e illu-
stri il venerando monumento chiarendo i problemi
storico-artistici che esso fa sorgere e illuminando la
storia della pittura nell’alto medio evo.
Bullettino senese di storia patria. Anno Vili,
fase. Ili, pag. 383.
P. Rossi pubblica la conferenza su Pio II a Pienza
tenuta colà inaugurandosi i restauri al palazzo pretorio.
L’A. vi lumeggia con garbo la figura del grande
umanista, del pontefice colto e munifico che volle
trasformato, a sua gloria, il natio borgo di Corsignano
in una città ricca di monumenti mirabili, e vi de-
linea a larghi tratti l’opera gigantesca compiuta dal
papa in Pienza, l’opera cui recarono il contributo della
loro arte Bernardo Rossellino, gli scolari di Iacopo
della Quercia, e Sano di Pietro, e Matteo di Giovanni
e il Vecchietta. L’A. si studia soprattutto di mostrar
come nei monumenti di Pienza prevalgano principal-
mente le caratteristiche dell’arte senese che era stata
fino allora restia a seguire le forme nuove del Rinasci-
mento e che il papa Pio II, col risveglio artistico
che provocò, contribuì a condurre sulla via dei nuovi
ideali.
Bullettino della Società filologica romana. N.2.
Roma, 1902. Pag. 35.
Arduino Colasanti : Il diario di Iacopo Carrucci
da Pontormo. — Una copia di questo diario era già
nota e fu segnalata dal Gaye che ne pubblicò alcune
righe : ora l’A. dà notizia dell’autografo conservato
anch’esso nella Biblioteca Nazionale di Firenze (Mi-
scellanea Magliabechiana, Vili, 1490). È un quinter-
netto di poche pagine scritto dal pittore dal 1554 al
1557, mentre dipingeva il coro della chiesa di San Lo-
renzo in Firenze e contiene, oltre numerose note per-
sonalissime del pittore che hanno per noi un valore
quasi esclusivamente psicologico, il resoconto quoti-
diano del lavoro che l’artista stava eseguendo in San
Lorenzo, resoconto illustrato bene spesso da schizzi
sommari che servivano a chiarir meglio il lavoro com-
piuto nella giornata.
Riferito brevemente del contenuto del diario e ac-
cennato all’interesse che può avere per noi, il dottor
Colasanti si ferma lungamente a ragionare della vita
del Pontormo e a rilevare gli errori, le inesattezze e
le contraddizioni in cui caddero il Vasari e quanti sulle
orme del biografo aretino si occuparono dell’artista :
a tali rettifiche non contribuisce però, a quanto mi sem-
bra, il diario del Pontormo, ma esse risultano quasi
esclusivamente dalla critica interna del testo vasariano.
L’Arte. V, 22’
Kunstchronik, 29 maggio 1902. Col. 420.
Un quadro di Raffaello o di Giulio Romano. — Si
tratta di una Natività attribuita a Raffaello proveniente
dalla collezione di Saron di Parigi, e che ora è pre-
sentata sul mercato per la morte del suo possessore
Enrico Kolbe, buon pittore di ritratti e di soggetti
storici. Il quadro è in tutto e per tutto uguale alla
Natività di Raffaello, conservata nel Salon carré del
Louvre. Il Morelli nel 1885 giudicava il dipinto opera
della scuola di Raffaello e probabilmente di Giulio
Romano.
Revue bleue, 12 aprile 1902. Pag. 453.
Angelo De Gubernatis : Il genio fiorentino. —
Dopo uno spigliato riassunto delle vicende della fonda-
dazione di Firenze, in cui genialmente sono intrec-
ciate storia e leggenda, dopo avere con sintesi felicis-
sima mostrato quali meriti immortali abbia per i suoi
uomini nel campo delle lettere e delle arti la Toscana,
l’A. viene quasi, con un esempio, a dimostrare quale
fosse lo spirito nuovo degli antichi fiorentini.
Egli paragona fra di loro le Madonne quali le formò
l’arte bizantina e quali le rinnovò il genio toscano.
Alle madonne fredde, stecchite dell’arte bizantina
egli contrappone la vita, la freschezza fiorita delle Ver-
gini umbre e toscane. L’A. continua a discorrere delle
arti toscane, ponendo in relazione artisti e poeti!
Federico Hermanin.
Arte e Storia. Gennaio-maggio 1902.
Gerspach descrive sommariamente gl’importantis-
simi affreschi venuti in luce nella chiesa di Santa Maria
Antiqua al Foro Romano, dei quali fu scritto a lungo
anche per i lettori del L'Arte nell’ultimo corriere ro-
mano dell’anno 1900.
Senza entrare nello studio iconografico ed epigra-
fico e senza toccare delle questioni che si connettono
alle diverse età in cui le diverse pitture furono ese-
guite, il Gerspach si limita a brevi osservazioni rela-
tive alla tecnica di alcuni degli affreschi e al modo
di difendere le pitture dal deterioramento.
Pur troppo però, ad onta dei lavori eseguiti, esse
hanno continuato a deperire, e oramai di fronte a ciò
che esse erano al loro primo apparire, non possono
dirsi che larve. Nessun processo tecnico, nessun riparo
poteva forse arrestare il loro progressivo spomparire,
dovuto forse soltanto all’azione della luce e dell’at-
mosfera. Auguriamoci che almeno quanto ora rimane
dei preziosi avanzi possa conservarsi a testimoniare
le condizioni dell’arte nei secoli più oscuri, e che presto
171
una buona monografia ci offra la riproduzione delle
pitture quali erano al momento della scoperta e illu-
stri il venerando monumento chiarendo i problemi
storico-artistici che esso fa sorgere e illuminando la
storia della pittura nell’alto medio evo.
Bullettino senese di storia patria. Anno Vili,
fase. Ili, pag. 383.
P. Rossi pubblica la conferenza su Pio II a Pienza
tenuta colà inaugurandosi i restauri al palazzo pretorio.
L’A. vi lumeggia con garbo la figura del grande
umanista, del pontefice colto e munifico che volle
trasformato, a sua gloria, il natio borgo di Corsignano
in una città ricca di monumenti mirabili, e vi de-
linea a larghi tratti l’opera gigantesca compiuta dal
papa in Pienza, l’opera cui recarono il contributo della
loro arte Bernardo Rossellino, gli scolari di Iacopo
della Quercia, e Sano di Pietro, e Matteo di Giovanni
e il Vecchietta. L’A. si studia soprattutto di mostrar
come nei monumenti di Pienza prevalgano principal-
mente le caratteristiche dell’arte senese che era stata
fino allora restia a seguire le forme nuove del Rinasci-
mento e che il papa Pio II, col risveglio artistico
che provocò, contribuì a condurre sulla via dei nuovi
ideali.
Bullettino della Società filologica romana. N.2.
Roma, 1902. Pag. 35.
Arduino Colasanti : Il diario di Iacopo Carrucci
da Pontormo. — Una copia di questo diario era già
nota e fu segnalata dal Gaye che ne pubblicò alcune
righe : ora l’A. dà notizia dell’autografo conservato
anch’esso nella Biblioteca Nazionale di Firenze (Mi-
scellanea Magliabechiana, Vili, 1490). È un quinter-
netto di poche pagine scritto dal pittore dal 1554 al
1557, mentre dipingeva il coro della chiesa di San Lo-
renzo in Firenze e contiene, oltre numerose note per-
sonalissime del pittore che hanno per noi un valore
quasi esclusivamente psicologico, il resoconto quoti-
diano del lavoro che l’artista stava eseguendo in San
Lorenzo, resoconto illustrato bene spesso da schizzi
sommari che servivano a chiarir meglio il lavoro com-
piuto nella giornata.
Riferito brevemente del contenuto del diario e ac-
cennato all’interesse che può avere per noi, il dottor
Colasanti si ferma lungamente a ragionare della vita
del Pontormo e a rilevare gli errori, le inesattezze e
le contraddizioni in cui caddero il Vasari e quanti sulle
orme del biografo aretino si occuparono dell’artista :
a tali rettifiche non contribuisce però, a quanto mi sem-
bra, il diario del Pontormo, ma esse risultano quasi
esclusivamente dalla critica interna del testo vasariano.
L’Arte. V, 22’