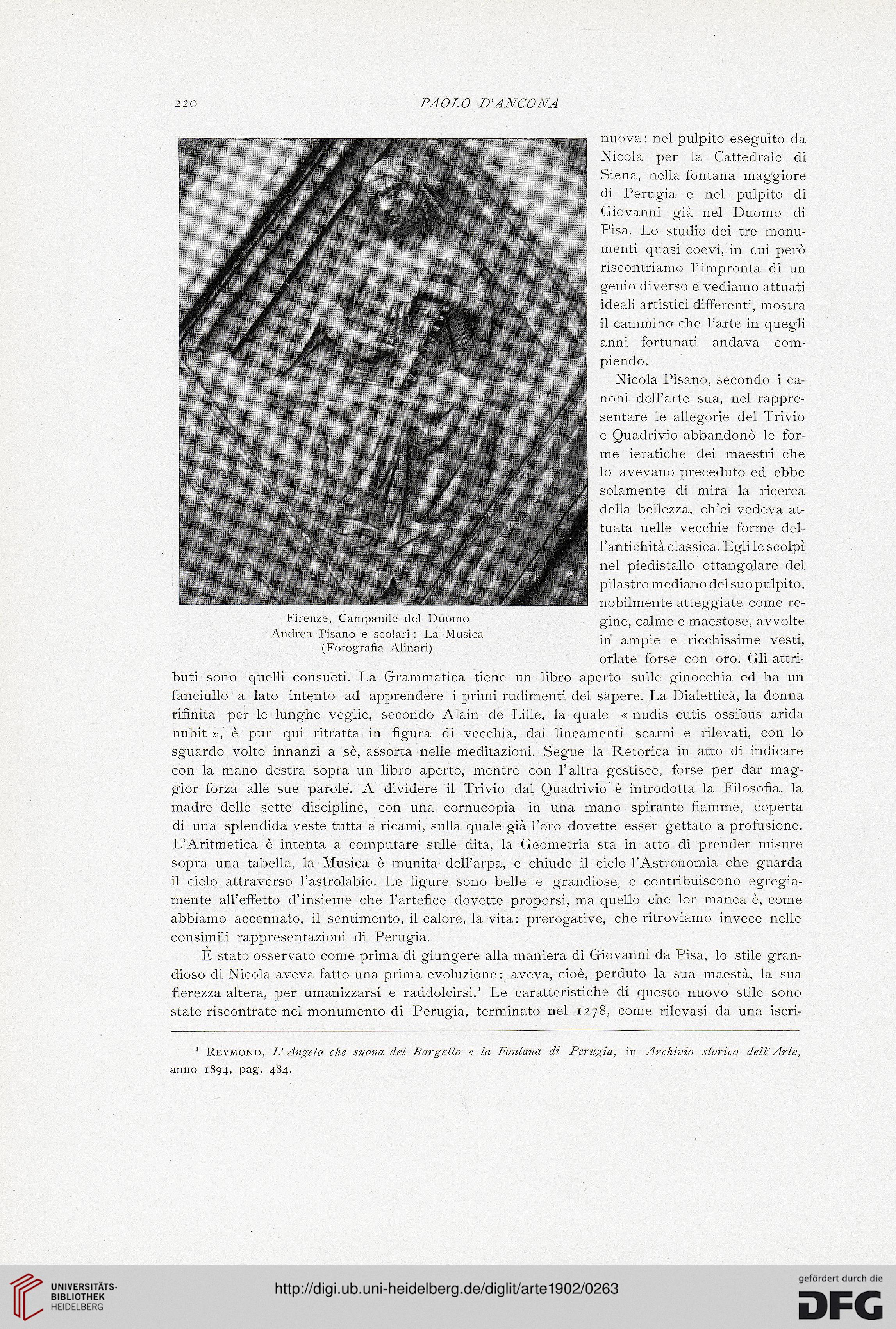220
PAOLO D'ANCONA
nuova : nel pulpito eseguito da
Nicola per la Cattedrale di
Siena, nella fontana maggiore
di Perugia e nel pulpito di
Giovanni già nel Duomo di
Pisa. Lo studio dei tre monu-
menti quasi coevi, in cui però
riscontriamo l’impronta di un
genio diverso e vediamo attuati
ideali artistici differenti, mostra
il cammino che l’arte in quegli
anni fortunati andava com-
piendo.
Nicola Pisano, secondo i ca-
noni dell’arte sua, nel rappre-
sentare le allegorie del Trivio
e Quadrivio abbandonò le for-
me ieratiche dei maestri che
lo avevano preceduto ed ebbe
solamente di mira la ricerca
della bellezza, ch’ei vedeva at-
tuata nelle vecchie forme del-
l’antichità classica. Egli le scolpì
nel piedistallo ottangolare del
pilastro mediano del suo pulpito,
nobilmente atteggiate come re-
gine, calme e maestose, avvolte
in ampie e ricchissime vesti,
orlate forse con oro. Gli attri-
buti sono quelli consueti. La Grammatica tiene un libro aperto sulle ginocchia ed ha un
fanciullo a lato intento ad apprendere i primi rudimenti del sapere. La Dialettica, la donna
rifinita per le lunghe veglie, secondo Alain de Lille, la quale « nudis cutis ossibus arida
nubit », è pur qui ritratta in figura di vecchia, dai lineamenti scarni e rilevati, con lo
sguardo volto innanzi a sè, assorta nelle meditazioni. Segue la Retorica in atto di indicare
con la mano destra sopra un libro aperto, mentre con l’altra gestisce, forse per dar mag-
gior forza alle sue parole. A dividere il Trivio dal Quadrivio è introdotta la Filosofia, la
madre delle sette discipline, con una cornucopia in una mano spirante fiamme, coperta
di una splendida veste tutta a ricami, sulla quale già l’oro dovette esser gettato a profusione.
L’Aritmetica è intenta a computare sulle dita, la Geometria sta in atto di prender misure
sopra una tabella, la Musica è munita dell’arpa, e chiude il ciclo l’Astronomia che guarda
il cielo attraverso l’astrolabio. Le figure sono belle e grandiose, e contribuiscono egregia-
mente all’effetto d’insieme che l’artefice dovette proporsi, ma quello che lor manca è, come
abbiamo accennato, il sentimento, il calore, la vita: prerogative, che ritroviamo invece nelle
consimili rappresentazioni di Perugia.
E stato osservato come prima di giungere alla maniera di Giovanni da Pisa, lo stile gran-
dioso di Nicola aveva fatto una prima evoluzione: aveva, cioè, perduto la sua maestà, la sua
fierezza altera, per umanizzarsi e raddolcirsi.1 Le caratteristiche di questo nuovo stile sono
state riscontrate nel monumento di Perugia, terminato nel 1278, come rilevasi da una iscri-
Firenze, Campanile del Duomo
Andrea Pisano e scolari : La Musica
(Fotografia Alinari)
1 Reymond, L’Angelo che suona del Bargello e la Fontana di Perugia, in Archivio storico dell’Arte,
anno 1894, pag. 484.
PAOLO D'ANCONA
nuova : nel pulpito eseguito da
Nicola per la Cattedrale di
Siena, nella fontana maggiore
di Perugia e nel pulpito di
Giovanni già nel Duomo di
Pisa. Lo studio dei tre monu-
menti quasi coevi, in cui però
riscontriamo l’impronta di un
genio diverso e vediamo attuati
ideali artistici differenti, mostra
il cammino che l’arte in quegli
anni fortunati andava com-
piendo.
Nicola Pisano, secondo i ca-
noni dell’arte sua, nel rappre-
sentare le allegorie del Trivio
e Quadrivio abbandonò le for-
me ieratiche dei maestri che
lo avevano preceduto ed ebbe
solamente di mira la ricerca
della bellezza, ch’ei vedeva at-
tuata nelle vecchie forme del-
l’antichità classica. Egli le scolpì
nel piedistallo ottangolare del
pilastro mediano del suo pulpito,
nobilmente atteggiate come re-
gine, calme e maestose, avvolte
in ampie e ricchissime vesti,
orlate forse con oro. Gli attri-
buti sono quelli consueti. La Grammatica tiene un libro aperto sulle ginocchia ed ha un
fanciullo a lato intento ad apprendere i primi rudimenti del sapere. La Dialettica, la donna
rifinita per le lunghe veglie, secondo Alain de Lille, la quale « nudis cutis ossibus arida
nubit », è pur qui ritratta in figura di vecchia, dai lineamenti scarni e rilevati, con lo
sguardo volto innanzi a sè, assorta nelle meditazioni. Segue la Retorica in atto di indicare
con la mano destra sopra un libro aperto, mentre con l’altra gestisce, forse per dar mag-
gior forza alle sue parole. A dividere il Trivio dal Quadrivio è introdotta la Filosofia, la
madre delle sette discipline, con una cornucopia in una mano spirante fiamme, coperta
di una splendida veste tutta a ricami, sulla quale già l’oro dovette esser gettato a profusione.
L’Aritmetica è intenta a computare sulle dita, la Geometria sta in atto di prender misure
sopra una tabella, la Musica è munita dell’arpa, e chiude il ciclo l’Astronomia che guarda
il cielo attraverso l’astrolabio. Le figure sono belle e grandiose, e contribuiscono egregia-
mente all’effetto d’insieme che l’artefice dovette proporsi, ma quello che lor manca è, come
abbiamo accennato, il sentimento, il calore, la vita: prerogative, che ritroviamo invece nelle
consimili rappresentazioni di Perugia.
E stato osservato come prima di giungere alla maniera di Giovanni da Pisa, lo stile gran-
dioso di Nicola aveva fatto una prima evoluzione: aveva, cioè, perduto la sua maestà, la sua
fierezza altera, per umanizzarsi e raddolcirsi.1 Le caratteristiche di questo nuovo stile sono
state riscontrate nel monumento di Perugia, terminato nel 1278, come rilevasi da una iscri-
Firenze, Campanile del Duomo
Andrea Pisano e scolari : La Musica
(Fotografia Alinari)
1 Reymond, L’Angelo che suona del Bargello e la Fontana di Perugia, in Archivio storico dell’Arte,
anno 1894, pag. 484.