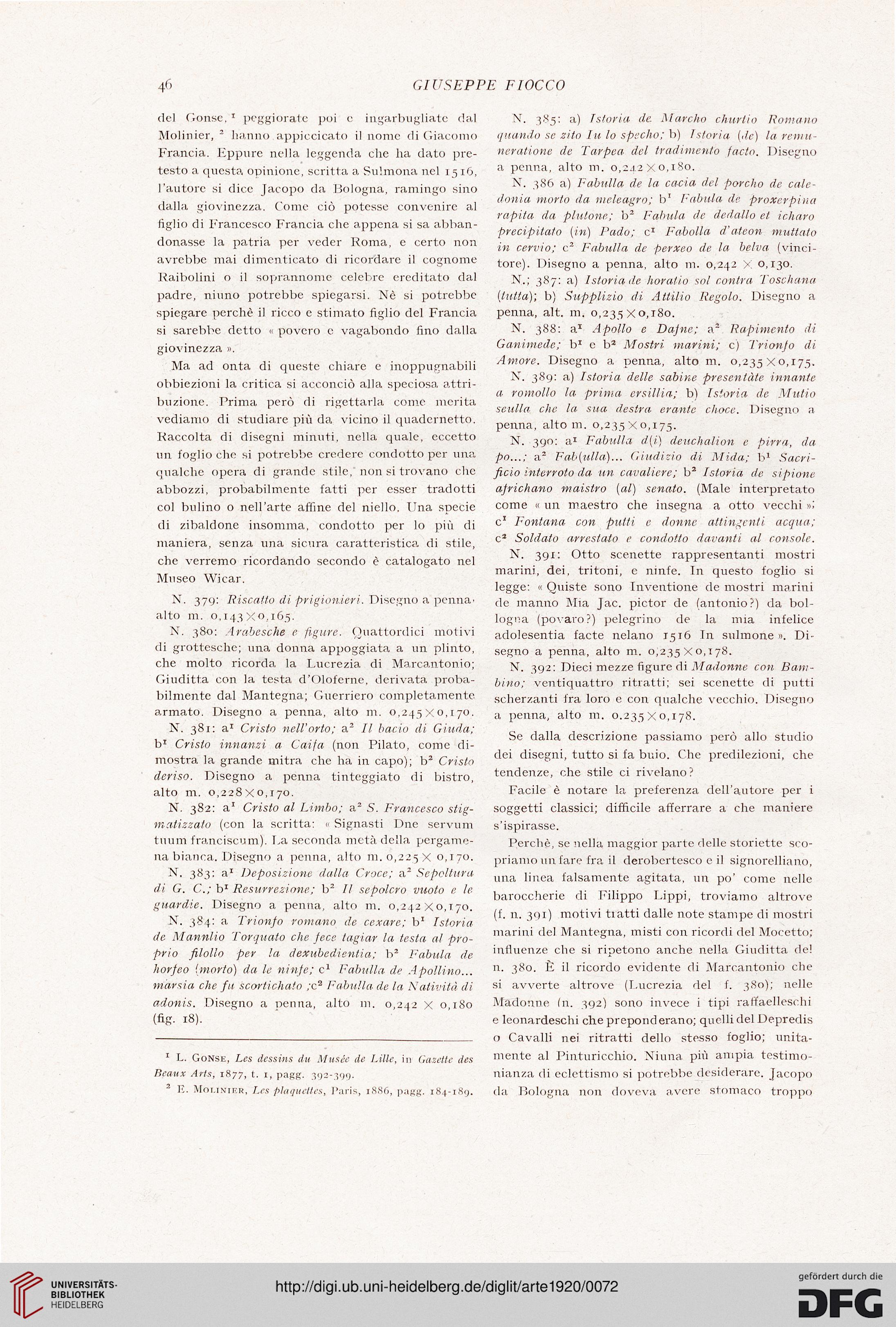46
GIUSEPPE FIOCCO
del C.onse,1 peggiorate poi c ingarbugliate dal
Molinier, 2 hanno appiccicato il nome di Giacomo
Francia. Eppure nella leggenda che ha dato pre-
testo a questa opinione, scritta a Sulmona nel 15 16,
l'autore si dice Jacopo da Bologna, ramingo sino
dalla giovinezza. Come ciò potesse convenire al
figlio di Francesco Francia che appena si sa abban-
donasse la patria per veder Roma, e certo non
avrebbe mai dimenticato di ricordare il cognome
Raibolini o il soprannome celebre ereditato dal
padre, ninno potrebbe spiegarsi. Nè si potrebbe
spiegare perchè il ricco e stimato figlio del Francia
si sarebbe detto « povero e vagabondo fino dalla
giovinezza ».
Ma ad onta di queste chiare e inoppugnabili
obbiezioni la critica si acconciò alla speciosa attri-
buzione. Prima però di rigettarla come merita
vediamo di studiare più da vicino il quadernetto.
Raccolta di disegni minuti, nella quale, eccetto
Un foglio che si potrebbe credere condotto per una
qualche opera di grande stile," non si trovano che
abbozzi, probabilmente fatti per esser tradotti
col bulino o nell'arte affine del niello. Una specie
di zibaldone insomma, condotto per lo più dì
maniera, senza una sicura caratteristica di stile,
che verremo ricordando secondo è catalogato nel
Museo Wicar.
N. 379: Riscatto di prigionieri. Disegno a penna'
alto m. 0,143 X0,165.
N. 380: Arabesche e figure. Quattordici motivi
di grottesche; una donna appoggiata a un plinto,
che molto ricorda la Lucrezia di Marcantonio;
Giuditta con la testa d'Oloferne, derivata proba-
bilmente dal Mantegna; Guerriero completamente
armato. Disegno a penna, alto m. 0,245x0,170.
N. 381: a1 Cristo nell'orto; a2 77 bacio di Giuda;
b1 Cristo innanzi a Caifa (non Pilato, come di-
mostra la grande mitra che ha in capo); b2 Cristo
deriso. Disegno a penna tinteggiato di bistro,
alto m. 0,228x0,170.
N. 382: a1 Cristo al Limbo; a2 S. Francesco stig-
matizzato (con la scritta: « Signasti Dne servum
tuum franciscum). La seconda metà della pergame-
na bianca. Disegno a penna, alto ni. 0,225 X o.1/0-
N. 383: a1 Deposizione dalla Croce; a2 Sepoltura
di G. C; b1 Resurrezione; b2 // sepolcro vuoto e le
guardie. Disegno a penna, alto m. 0,242x0,170.
N. 384: a Trionfo romano de cexare; b1 Istoria
de Mann!io Torquato che fece tagiar la testa al pro-
prio fllollo per la dexubedientia; b2 Tabula de
hor/eo [morto) da le ninfe; c1 Fabulla de A pollino...
marsia che fu scortichato ;c2 l'abulia de la Natività di
adonis. Disegno a penna, alto 111. 0,242 x 0,180
(fig. 18).
1 L. Gonse, Les dessins du Muséc de Lille, in Gaiette des
Bcaux Aris, 1877, t. 1, pagg. 393-399.
2 E. Mounier, Les plaquettes, Paris, 1886, pagg. 184-189.
N. 385: a) Istoria de Marcito churtio Romano
quando se zito In lo specho; b) Istoria (de) la remu-
neratone de Tarpea del tradimento facto. Disegno
a penna, alto m. 0,2.1.2X0,180.
N. 386 a) Fabulla de la cada del porcho de cale-
donia morto da meleagro; b1 Fabula de proxerpi na
rapi/a da plutone; b2 Fabula de dedallo et icharo
precipitato (in) Rado; c1 Fabolla d'ateon multato
in cervio; c2 Fabulla de perxeo de la belva (vinci-
tore). Disegno a penna, alto m. 0,242 X 0,130.
N.; 387: a) Istoria de horatio sol contra Toschana
(tutta)', b) Supplizio di Attilio Regolo. Disegno a
penna, alt. m. 0,235X0,180.
N. 388: a1 Apollo e Dafne; a2 Rapimento di
Ganimede; b1 e ba Mostri, marini; c) Trionfo di
Amore. Disegno a. penna, alto m. 0,235X0,175.
N. 389: a) Istoria delle sabine presentate innante
a romollo la prima ersil/ia; b) Istoria de Mutio
sculla che la. sua destra eran/c choce. Disegno a
penna, alto m. 0,235X0,175.
N. 390: a1 Fabulla d.(i) deuchalion e pirra, da
po...; a2 Fab(ulla)... Giudizio di Mid.a; b1 Sacri-
ficio interroto da un cavaliere; b2 Istoria de sipione
africhano maistro (al) senato. (Male interpretato
come « un maestro che insegna a otto vecchi »i
e* Fontana con putti e donne attingenti acqua;
cJ Soldato arrestalo e condotto davanti al console.
N. 391: Otto scenette rappresentanti mostri
marini, dei, tritoni, e ninfe. In questo foglio si
legge: « Quiste sono Inventione de mostri marini
de manno Mia Jac. pictor de (antonio?) da bol-
logna (povaro?) pelegrìno de la mia infelice
adolesentia facte nelano 1516 In sulmone ». Di-
segno a penna, alto m. 0,235X0,178.
N. 392: Dieci mezze figure di Madonne con Bam-
bino; ventiquattro ritratti; sei scenette di putti
scherzanti fra loro e con qualche vecchio. Disegno
a penna, alto m. 0,235X0,178.
Se dalla descrizione passiamo però allo studio
dei disegni, tutto si fa buio. Che predilezioni, che
tendenze, che stile ci rivelano?
Facile è notare la preferenza dell'autore per i
soggetti classici; difficile afferrare a che maniere
s'ispirasse.
Perchè, se nella maggior parte delle storiette sco-
priamo un fare fra il derobertesco e il signorelliano,
una linea falsamente agitata, un po' come nelle
baroccherie di Filippo Lippi, troviamo altrove
(f. n. 391) motivi riatti dalle note stampe di mostri
marini del Mantegna, misti con ricordi del Mocetto;
influenze che si ripetono anche nella Giuditta de!
n. 380. E il ricordo evidente di Marcantonio che
si avverte altrove (Lucrezia del f. 3.So); nelle
Madonne (n. 392) sono invece i tipi raffaelleschi
e leonardeschi che preponderano; quelli del Depredis
o Cavalli nei ritratti dello stesso foglio; unita-
mente al Pinturicchio. Niuna più ampia testimo-
nianza di eclettismo si potrebbe desiderare. Jacopo
da Bologna non doveva, avere stomaco troppo
GIUSEPPE FIOCCO
del C.onse,1 peggiorate poi c ingarbugliate dal
Molinier, 2 hanno appiccicato il nome di Giacomo
Francia. Eppure nella leggenda che ha dato pre-
testo a questa opinione, scritta a Sulmona nel 15 16,
l'autore si dice Jacopo da Bologna, ramingo sino
dalla giovinezza. Come ciò potesse convenire al
figlio di Francesco Francia che appena si sa abban-
donasse la patria per veder Roma, e certo non
avrebbe mai dimenticato di ricordare il cognome
Raibolini o il soprannome celebre ereditato dal
padre, ninno potrebbe spiegarsi. Nè si potrebbe
spiegare perchè il ricco e stimato figlio del Francia
si sarebbe detto « povero e vagabondo fino dalla
giovinezza ».
Ma ad onta di queste chiare e inoppugnabili
obbiezioni la critica si acconciò alla speciosa attri-
buzione. Prima però di rigettarla come merita
vediamo di studiare più da vicino il quadernetto.
Raccolta di disegni minuti, nella quale, eccetto
Un foglio che si potrebbe credere condotto per una
qualche opera di grande stile," non si trovano che
abbozzi, probabilmente fatti per esser tradotti
col bulino o nell'arte affine del niello. Una specie
di zibaldone insomma, condotto per lo più dì
maniera, senza una sicura caratteristica di stile,
che verremo ricordando secondo è catalogato nel
Museo Wicar.
N. 379: Riscatto di prigionieri. Disegno a penna'
alto m. 0,143 X0,165.
N. 380: Arabesche e figure. Quattordici motivi
di grottesche; una donna appoggiata a un plinto,
che molto ricorda la Lucrezia di Marcantonio;
Giuditta con la testa d'Oloferne, derivata proba-
bilmente dal Mantegna; Guerriero completamente
armato. Disegno a penna, alto m. 0,245x0,170.
N. 381: a1 Cristo nell'orto; a2 77 bacio di Giuda;
b1 Cristo innanzi a Caifa (non Pilato, come di-
mostra la grande mitra che ha in capo); b2 Cristo
deriso. Disegno a penna tinteggiato di bistro,
alto m. 0,228x0,170.
N. 382: a1 Cristo al Limbo; a2 S. Francesco stig-
matizzato (con la scritta: « Signasti Dne servum
tuum franciscum). La seconda metà della pergame-
na bianca. Disegno a penna, alto ni. 0,225 X o.1/0-
N. 383: a1 Deposizione dalla Croce; a2 Sepoltura
di G. C; b1 Resurrezione; b2 // sepolcro vuoto e le
guardie. Disegno a penna, alto m. 0,242x0,170.
N. 384: a Trionfo romano de cexare; b1 Istoria
de Mann!io Torquato che fece tagiar la testa al pro-
prio fllollo per la dexubedientia; b2 Tabula de
hor/eo [morto) da le ninfe; c1 Fabulla de A pollino...
marsia che fu scortichato ;c2 l'abulia de la Natività di
adonis. Disegno a penna, alto 111. 0,242 x 0,180
(fig. 18).
1 L. Gonse, Les dessins du Muséc de Lille, in Gaiette des
Bcaux Aris, 1877, t. 1, pagg. 393-399.
2 E. Mounier, Les plaquettes, Paris, 1886, pagg. 184-189.
N. 385: a) Istoria de Marcito churtio Romano
quando se zito In lo specho; b) Istoria (de) la remu-
neratone de Tarpea del tradimento facto. Disegno
a penna, alto m. 0,2.1.2X0,180.
N. 386 a) Fabulla de la cada del porcho de cale-
donia morto da meleagro; b1 Fabula de proxerpi na
rapi/a da plutone; b2 Fabula de dedallo et icharo
precipitato (in) Rado; c1 Fabolla d'ateon multato
in cervio; c2 Fabulla de perxeo de la belva (vinci-
tore). Disegno a penna, alto m. 0,242 X 0,130.
N.; 387: a) Istoria de horatio sol contra Toschana
(tutta)', b) Supplizio di Attilio Regolo. Disegno a
penna, alt. m. 0,235X0,180.
N. 388: a1 Apollo e Dafne; a2 Rapimento di
Ganimede; b1 e ba Mostri, marini; c) Trionfo di
Amore. Disegno a. penna, alto m. 0,235X0,175.
N. 389: a) Istoria delle sabine presentate innante
a romollo la prima ersil/ia; b) Istoria de Mutio
sculla che la. sua destra eran/c choce. Disegno a
penna, alto m. 0,235X0,175.
N. 390: a1 Fabulla d.(i) deuchalion e pirra, da
po...; a2 Fab(ulla)... Giudizio di Mid.a; b1 Sacri-
ficio interroto da un cavaliere; b2 Istoria de sipione
africhano maistro (al) senato. (Male interpretato
come « un maestro che insegna a otto vecchi »i
e* Fontana con putti e donne attingenti acqua;
cJ Soldato arrestalo e condotto davanti al console.
N. 391: Otto scenette rappresentanti mostri
marini, dei, tritoni, e ninfe. In questo foglio si
legge: « Quiste sono Inventione de mostri marini
de manno Mia Jac. pictor de (antonio?) da bol-
logna (povaro?) pelegrìno de la mia infelice
adolesentia facte nelano 1516 In sulmone ». Di-
segno a penna, alto m. 0,235X0,178.
N. 392: Dieci mezze figure di Madonne con Bam-
bino; ventiquattro ritratti; sei scenette di putti
scherzanti fra loro e con qualche vecchio. Disegno
a penna, alto m. 0,235X0,178.
Se dalla descrizione passiamo però allo studio
dei disegni, tutto si fa buio. Che predilezioni, che
tendenze, che stile ci rivelano?
Facile è notare la preferenza dell'autore per i
soggetti classici; difficile afferrare a che maniere
s'ispirasse.
Perchè, se nella maggior parte delle storiette sco-
priamo un fare fra il derobertesco e il signorelliano,
una linea falsamente agitata, un po' come nelle
baroccherie di Filippo Lippi, troviamo altrove
(f. n. 391) motivi riatti dalle note stampe di mostri
marini del Mantegna, misti con ricordi del Mocetto;
influenze che si ripetono anche nella Giuditta de!
n. 380. E il ricordo evidente di Marcantonio che
si avverte altrove (Lucrezia del f. 3.So); nelle
Madonne (n. 392) sono invece i tipi raffaelleschi
e leonardeschi che preponderano; quelli del Depredis
o Cavalli nei ritratti dello stesso foglio; unita-
mente al Pinturicchio. Niuna più ampia testimo-
nianza di eclettismo si potrebbe desiderare. Jacopo
da Bologna non doveva, avere stomaco troppo