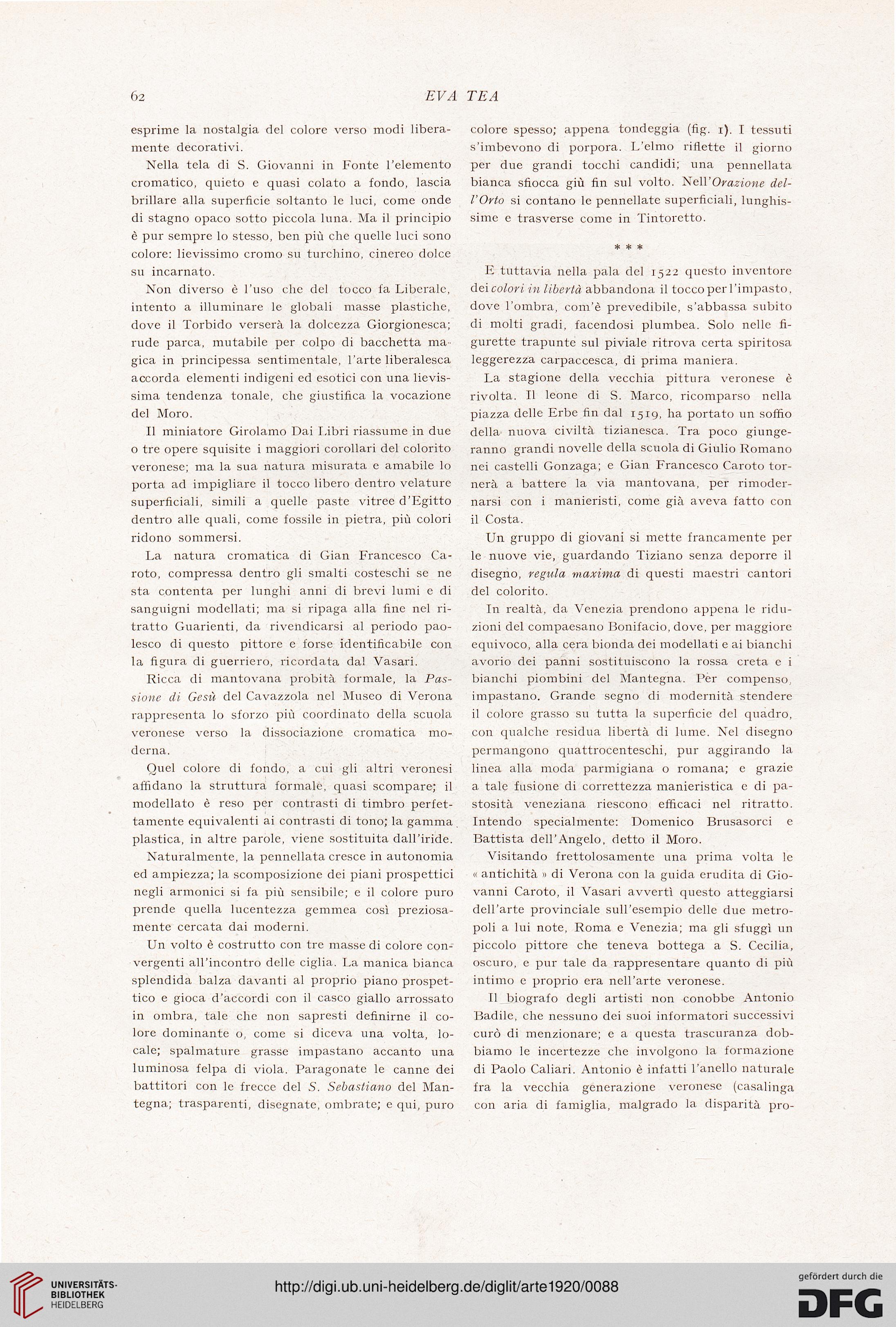62
EVA TEA
esprime la nostalgia del colore verso modi libera-
mente decorativi.
Nella tela di S. Giovanni in Fonte l'elemento
cromatico, quieto e quasi colato a fondo, lascia
brillare alla superficie soltanto le luci, come onde
di stagno opaco sotto piccola luna. Ma il principio
è pur sempre lo stesso, ben più che quelle luci sono
colore: lievissimo cromo su turchino, cinereo dolce
su incarnato.
Non diverso è l'uso che del tocco fa Liberale,
intento a illuminare le globali masse plastiche,
dove il Torbido verserà la dolcezza Giorgionesca;
rude parca, mutabile per colpo di bacchetta ma-
gica in principessa sentimentale, l'arte liberalesca
accorda elementi indigeni ed esotici con una lievis-
sima tendenza tonale, che giustifica la vocazione
del Moro.
Il miniatore Girolamo Dai Libri riassume in due
o tre opere squisite i maggiori corollari del colorito
veronese; ma la sua natura misurata e amabile lo
porta ad impigliare il tocco libero dentro velature
superficiali, simili a quelle paste vitree d'Egitto
dentro alle quali, come fossile in pietra, più colori
ridono sommersi.
La natura cromatica di Gian Francesco Ca-
roto, compressa dentro gli smalti costeschi se ne
sta contenta per lunghi anni di brevi lumi e di
sanguigni modellati; ma si ripaga alla fine nel ri-
tratto Guarienti, da rivendicarsi al periodo pao-
lesco di questo pittore e forse identificabile con
la figura di guerriero, ricordata dal Vasari.
Ricca di mantovana probità formale, la Pas-
sione di Gesù del Cavazzola nel Museo di Verona
rappresenta lo sforzo più coordinato della scuola
veronese verso la dissociazione cromatica mo-
derna.
Quel colore di fondo, a cui gli altri veronesi
affidano la struttura formale, quasi scompare; il
modellato è reso per contrasti di timbro perfet-
tamente equivalenti ai contrasti di tono; la gamma
plastica, in altre parole, viene sostituita dall'iride.
Naturalmente, la pennellata cresce in autonomia
ed ampiezza; la scomposizione dei piani prospettici
negli armonici si fa più sensibile; e il colore puro
prende quella lucentezza gemmea così preziosa-
mente cercata dai moderni.
Un volto è costrutto con tre masse di colore con-
vergenti all'incontro delle ciglia. La manica bianca
splendida balza davanti al proprio piano prospet-
tico e gioca d'accordi con il casco giallo arrossato
in ombra, tale che non sapresti definirne il co-
lore dominante o, come si diceva una volta, lo-
cale; spalmature grasse impastano accanto una
luminosa felpa di viola. Paragonate le canne dei
battitori con le frecce del .S*. Sebastiano del Man-
tegna; trasparenti, disegnate, ombrate; e qui, puro
colore spesso; appena tondeggia (fig. i). I tessuti
s'imbevono di porpora. L'elmo riflette il giorno
per due grandi tocchi candidi; una pennellata
bianca sfìocca giù fin sul volto. Nell'Orazione del-
l'Orto si contano le pennellate superficiali, lunghis-
sime e trasverse come in Tintoretto.
* * *
E tuttavia nella pala del 1522 questo inventore
dei colori in libertà abbandona il tocco per l'impasto,
dove l'ombra, com'è prevedibile, s'abbassa subito
di molti gradi, facendosi plumbea. Solo nelle fi-
gurette trapunte sul piviale ritrova certa spiritosa
leggerezza carpaccesca, di prima maniera.
La stagione della vecchia pittura veronese è
rivolta. Il leone di S. Marco, ricomparso nella
piazza delle Erbe fin dal 1519, ha portato un soffio
della nuova civiltà tizianesca. Tra poco giunge-
ranno grandi novelle della scuola di Giulio Romano
nei castelli Gonzaga; e Gian Francesco Caroto tor-
nerà a battere la via mantovana, per rimoder-
narsi con i manieristi, come già aveva fatto con
il Costa.
Un gruppo di giovani si mette francamente per
le nuove vie, guardando Tiziano senza deporre il
disegno, regula maxima di questi maestri cantori
del colorito.
In realtà, da Venezia prendono appena le ridu-
zioni del compaesano Bonifacio, dove, per maggiore
equivoco, alla cera bionda dei modellati e ai bianchi
avorio dei panni sostituiscono la rossa creta e i
bianchi piombini del Mantegna. Per compenso,
impastano. Grande segno di modernità stendere
il colore grasso su tutta la superficie del quadro,
con qualche residua libertà di lume. Nel disegno
permangono quattrocenteschi, pur aggirando la
linea alla moda parmigiana o romana; e grazie
a tale fusione di correttezza manieristica e di pa-
stosità veneziana riescono efficaci nel ritratto.
Intendo specialmente: Domenico Brusasorci e
Battista dell'Angelo, detto il Moro.
Visitando frettolosamente una prima volta le
« antichità » di Verona con la guida erudita di Gio-
vanni Caroto, il Vasari avvertì questo atteggiarsi
dell'arte provinciale sull'esempio delle due metro-
poli a lui note, Roma e Venezia; ma gli sfuggì un
piccolo pittore che teneva bottega a S. Cecilia,
oscuro, e pur tale da rappresentare quanto di più
intimo e proprio era nell'arte veronese.
Il biografo degli artisti non conobbe Antonio
Badile, che nessuno dei suoi informatori successivi
curò di menzionare; e a questa trascuranza dob-
biamo le incertezze che involgono la formazione
di Paolo Caliari. Antonio è infatti l'anello naturale
fra la vecchia generazione veronese (casalinga
con aria di famiglia, malgrado la disparità prò-
EVA TEA
esprime la nostalgia del colore verso modi libera-
mente decorativi.
Nella tela di S. Giovanni in Fonte l'elemento
cromatico, quieto e quasi colato a fondo, lascia
brillare alla superficie soltanto le luci, come onde
di stagno opaco sotto piccola luna. Ma il principio
è pur sempre lo stesso, ben più che quelle luci sono
colore: lievissimo cromo su turchino, cinereo dolce
su incarnato.
Non diverso è l'uso che del tocco fa Liberale,
intento a illuminare le globali masse plastiche,
dove il Torbido verserà la dolcezza Giorgionesca;
rude parca, mutabile per colpo di bacchetta ma-
gica in principessa sentimentale, l'arte liberalesca
accorda elementi indigeni ed esotici con una lievis-
sima tendenza tonale, che giustifica la vocazione
del Moro.
Il miniatore Girolamo Dai Libri riassume in due
o tre opere squisite i maggiori corollari del colorito
veronese; ma la sua natura misurata e amabile lo
porta ad impigliare il tocco libero dentro velature
superficiali, simili a quelle paste vitree d'Egitto
dentro alle quali, come fossile in pietra, più colori
ridono sommersi.
La natura cromatica di Gian Francesco Ca-
roto, compressa dentro gli smalti costeschi se ne
sta contenta per lunghi anni di brevi lumi e di
sanguigni modellati; ma si ripaga alla fine nel ri-
tratto Guarienti, da rivendicarsi al periodo pao-
lesco di questo pittore e forse identificabile con
la figura di guerriero, ricordata dal Vasari.
Ricca di mantovana probità formale, la Pas-
sione di Gesù del Cavazzola nel Museo di Verona
rappresenta lo sforzo più coordinato della scuola
veronese verso la dissociazione cromatica mo-
derna.
Quel colore di fondo, a cui gli altri veronesi
affidano la struttura formale, quasi scompare; il
modellato è reso per contrasti di timbro perfet-
tamente equivalenti ai contrasti di tono; la gamma
plastica, in altre parole, viene sostituita dall'iride.
Naturalmente, la pennellata cresce in autonomia
ed ampiezza; la scomposizione dei piani prospettici
negli armonici si fa più sensibile; e il colore puro
prende quella lucentezza gemmea così preziosa-
mente cercata dai moderni.
Un volto è costrutto con tre masse di colore con-
vergenti all'incontro delle ciglia. La manica bianca
splendida balza davanti al proprio piano prospet-
tico e gioca d'accordi con il casco giallo arrossato
in ombra, tale che non sapresti definirne il co-
lore dominante o, come si diceva una volta, lo-
cale; spalmature grasse impastano accanto una
luminosa felpa di viola. Paragonate le canne dei
battitori con le frecce del .S*. Sebastiano del Man-
tegna; trasparenti, disegnate, ombrate; e qui, puro
colore spesso; appena tondeggia (fig. i). I tessuti
s'imbevono di porpora. L'elmo riflette il giorno
per due grandi tocchi candidi; una pennellata
bianca sfìocca giù fin sul volto. Nell'Orazione del-
l'Orto si contano le pennellate superficiali, lunghis-
sime e trasverse come in Tintoretto.
* * *
E tuttavia nella pala del 1522 questo inventore
dei colori in libertà abbandona il tocco per l'impasto,
dove l'ombra, com'è prevedibile, s'abbassa subito
di molti gradi, facendosi plumbea. Solo nelle fi-
gurette trapunte sul piviale ritrova certa spiritosa
leggerezza carpaccesca, di prima maniera.
La stagione della vecchia pittura veronese è
rivolta. Il leone di S. Marco, ricomparso nella
piazza delle Erbe fin dal 1519, ha portato un soffio
della nuova civiltà tizianesca. Tra poco giunge-
ranno grandi novelle della scuola di Giulio Romano
nei castelli Gonzaga; e Gian Francesco Caroto tor-
nerà a battere la via mantovana, per rimoder-
narsi con i manieristi, come già aveva fatto con
il Costa.
Un gruppo di giovani si mette francamente per
le nuove vie, guardando Tiziano senza deporre il
disegno, regula maxima di questi maestri cantori
del colorito.
In realtà, da Venezia prendono appena le ridu-
zioni del compaesano Bonifacio, dove, per maggiore
equivoco, alla cera bionda dei modellati e ai bianchi
avorio dei panni sostituiscono la rossa creta e i
bianchi piombini del Mantegna. Per compenso,
impastano. Grande segno di modernità stendere
il colore grasso su tutta la superficie del quadro,
con qualche residua libertà di lume. Nel disegno
permangono quattrocenteschi, pur aggirando la
linea alla moda parmigiana o romana; e grazie
a tale fusione di correttezza manieristica e di pa-
stosità veneziana riescono efficaci nel ritratto.
Intendo specialmente: Domenico Brusasorci e
Battista dell'Angelo, detto il Moro.
Visitando frettolosamente una prima volta le
« antichità » di Verona con la guida erudita di Gio-
vanni Caroto, il Vasari avvertì questo atteggiarsi
dell'arte provinciale sull'esempio delle due metro-
poli a lui note, Roma e Venezia; ma gli sfuggì un
piccolo pittore che teneva bottega a S. Cecilia,
oscuro, e pur tale da rappresentare quanto di più
intimo e proprio era nell'arte veronese.
Il biografo degli artisti non conobbe Antonio
Badile, che nessuno dei suoi informatori successivi
curò di menzionare; e a questa trascuranza dob-
biamo le incertezze che involgono la formazione
di Paolo Caliari. Antonio è infatti l'anello naturale
fra la vecchia generazione veronese (casalinga
con aria di famiglia, malgrado la disparità prò-