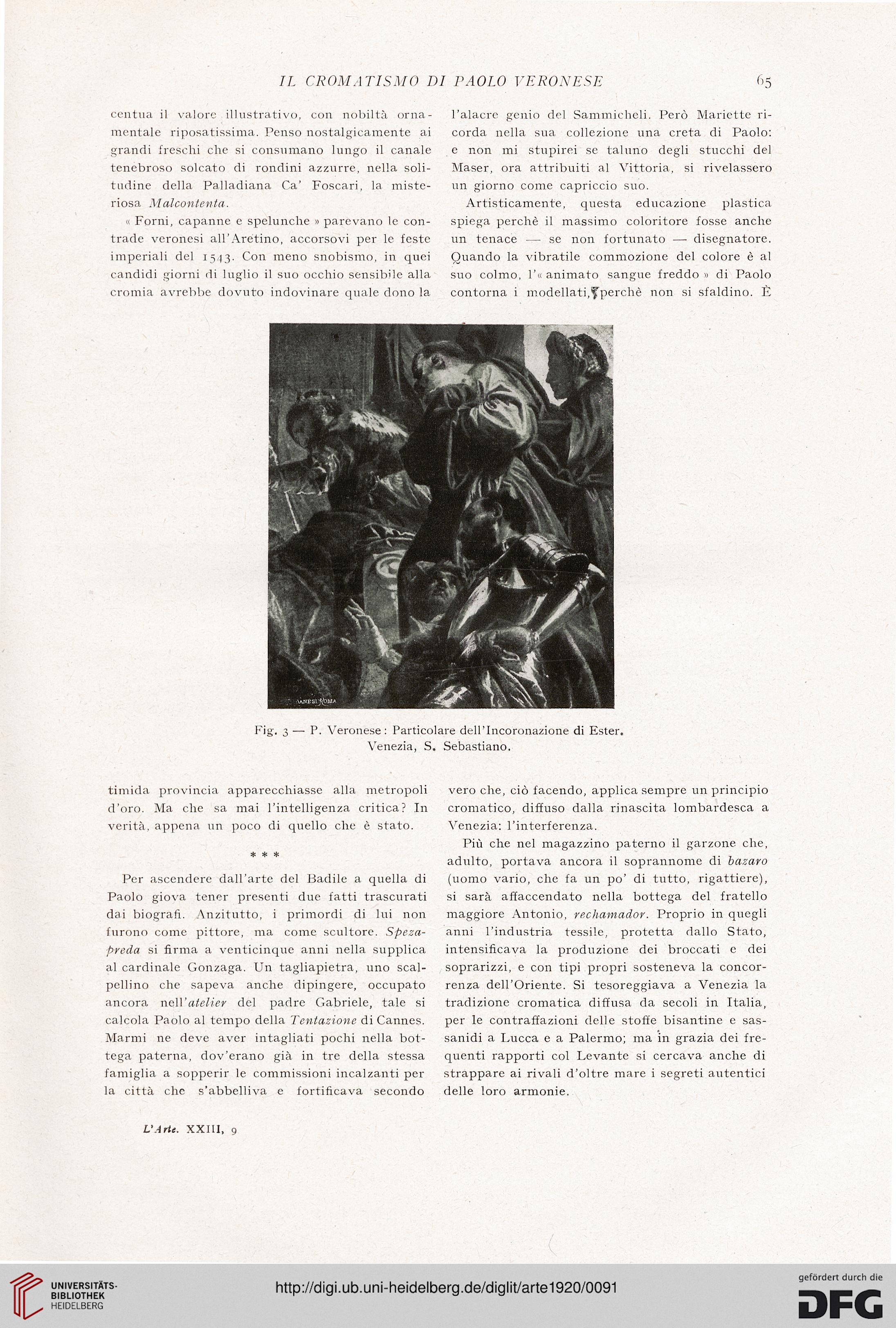IL CROMATISMO DI PAOLO VERONESE
65
centua il valore illustrativo, con nobiltà orna-
mentale riposatissima. Penso nostalgicamente ai
grandi freschi che si consumano lungo il canale
tenebroso solcato di rondini azzurre, nella soli-
tudine della Palladiana Ca' Foscari, la miste-
riosa Malcontenta.
« Forni, capanne e spelunche » parevano le con-
trade veronesi all'Aretino, accorsovi per le feste
imperiali del 1513. Con meno snobismo, in quei
candidi giorni di luglio il suo occhio sensibile alla
cromia avrebbe dovuto indovinare quale dono la
l'alacre genio del Sammichcli. Però Mariette ri-
corda nella sua collezione una creta di Paolo:
e non mi stupirei se taluno degli stucchi del
Maser, ora attribuiti al Vittoria, si rivelassero
un giorno come capriccio suo.
Artisticamente, questa educazione plastica
spiega perchè il massimo coloritore fosse anche
un tenace — se non fortunato — disegnatore.
Quando la vibratile commozione del colore è al
suo colmo, l'« animato sangue freddo » di Paolo
contorna i modellati,fperchè non si sfaldino. È
Fig. 3 — P. Veronese: Particolare dell'Incoronazione di Ester.
Venezia, S. Sebastiano.
timida provincia apparecchiasse alla metropoli
d'oro. Ma che sa mai l'intelligenza critica? In
verità, appena un poco di quello che è stato.
* * *
Per ascendere dall'arte del Badile a quella di
Paolo giova tener presenti due fatti trascurati
dai biografi. Anzitutto, i primordi di lui non
furono come pittore, ma come scultore. Speza-
preda si firma a venticinque anni nella supplica
al cardinale Gonzaga. Un tagliapietra, uno scal-
pellino che sapeva anche dipingere, occupato
ancora ncW atelier del padre Gabriele, tale si
calcola Paolo al tempo della Tentazione di Cannes.
Marmi ne deve aver intagliati pochi nella bot-
tega paterna, dov'erano già in tre della stessa
famiglia a sopperir le commissioni incalzanti per
la città che s'abbelliva e fortificava secondo
vero che, ciò facendo, applica sempre un principio
cromatico, diffuso dalla rinascita lombardesca a
Venezia: l'interferenza.
Più che nel magazzino paterno il garzone che,
adulto, portava ancora il soprannome di bazaro
(uomo vario, che fa un po' di tutto, rigattiere),
si sarà affaccendato nella bottega del fratello
maggiore Antonio, rechamador. Proprio in quegli
anni l'industria tessile, protetta dallo Stato,
intensificava la produzione dei broccati e dei
soprarizzi, e con tipi propri sosteneva la concor-
renza dell'Oriente. Si tesoreggiava a Venezia la
tradizione cromatica diffusa da secoli in Italia,
per le contraffazioni delle stoffe bisantine e sas-
sanidi a Lucca e a Palermo; ma in grazia dei fre-
quenti rapporti col Levante si cercava anche di
strappare ai rivali d'oltre mare i segreti autentici
delle loro armonie.
L'Arte. XXIII, 9
65
centua il valore illustrativo, con nobiltà orna-
mentale riposatissima. Penso nostalgicamente ai
grandi freschi che si consumano lungo il canale
tenebroso solcato di rondini azzurre, nella soli-
tudine della Palladiana Ca' Foscari, la miste-
riosa Malcontenta.
« Forni, capanne e spelunche » parevano le con-
trade veronesi all'Aretino, accorsovi per le feste
imperiali del 1513. Con meno snobismo, in quei
candidi giorni di luglio il suo occhio sensibile alla
cromia avrebbe dovuto indovinare quale dono la
l'alacre genio del Sammichcli. Però Mariette ri-
corda nella sua collezione una creta di Paolo:
e non mi stupirei se taluno degli stucchi del
Maser, ora attribuiti al Vittoria, si rivelassero
un giorno come capriccio suo.
Artisticamente, questa educazione plastica
spiega perchè il massimo coloritore fosse anche
un tenace — se non fortunato — disegnatore.
Quando la vibratile commozione del colore è al
suo colmo, l'« animato sangue freddo » di Paolo
contorna i modellati,fperchè non si sfaldino. È
Fig. 3 — P. Veronese: Particolare dell'Incoronazione di Ester.
Venezia, S. Sebastiano.
timida provincia apparecchiasse alla metropoli
d'oro. Ma che sa mai l'intelligenza critica? In
verità, appena un poco di quello che è stato.
* * *
Per ascendere dall'arte del Badile a quella di
Paolo giova tener presenti due fatti trascurati
dai biografi. Anzitutto, i primordi di lui non
furono come pittore, ma come scultore. Speza-
preda si firma a venticinque anni nella supplica
al cardinale Gonzaga. Un tagliapietra, uno scal-
pellino che sapeva anche dipingere, occupato
ancora ncW atelier del padre Gabriele, tale si
calcola Paolo al tempo della Tentazione di Cannes.
Marmi ne deve aver intagliati pochi nella bot-
tega paterna, dov'erano già in tre della stessa
famiglia a sopperir le commissioni incalzanti per
la città che s'abbelliva e fortificava secondo
vero che, ciò facendo, applica sempre un principio
cromatico, diffuso dalla rinascita lombardesca a
Venezia: l'interferenza.
Più che nel magazzino paterno il garzone che,
adulto, portava ancora il soprannome di bazaro
(uomo vario, che fa un po' di tutto, rigattiere),
si sarà affaccendato nella bottega del fratello
maggiore Antonio, rechamador. Proprio in quegli
anni l'industria tessile, protetta dallo Stato,
intensificava la produzione dei broccati e dei
soprarizzi, e con tipi propri sosteneva la concor-
renza dell'Oriente. Si tesoreggiava a Venezia la
tradizione cromatica diffusa da secoli in Italia,
per le contraffazioni delle stoffe bisantine e sas-
sanidi a Lucca e a Palermo; ma in grazia dei fre-
quenti rapporti col Levante si cercava anche di
strappare ai rivali d'oltre mare i segreti autentici
delle loro armonie.
L'Arte. XXIII, 9