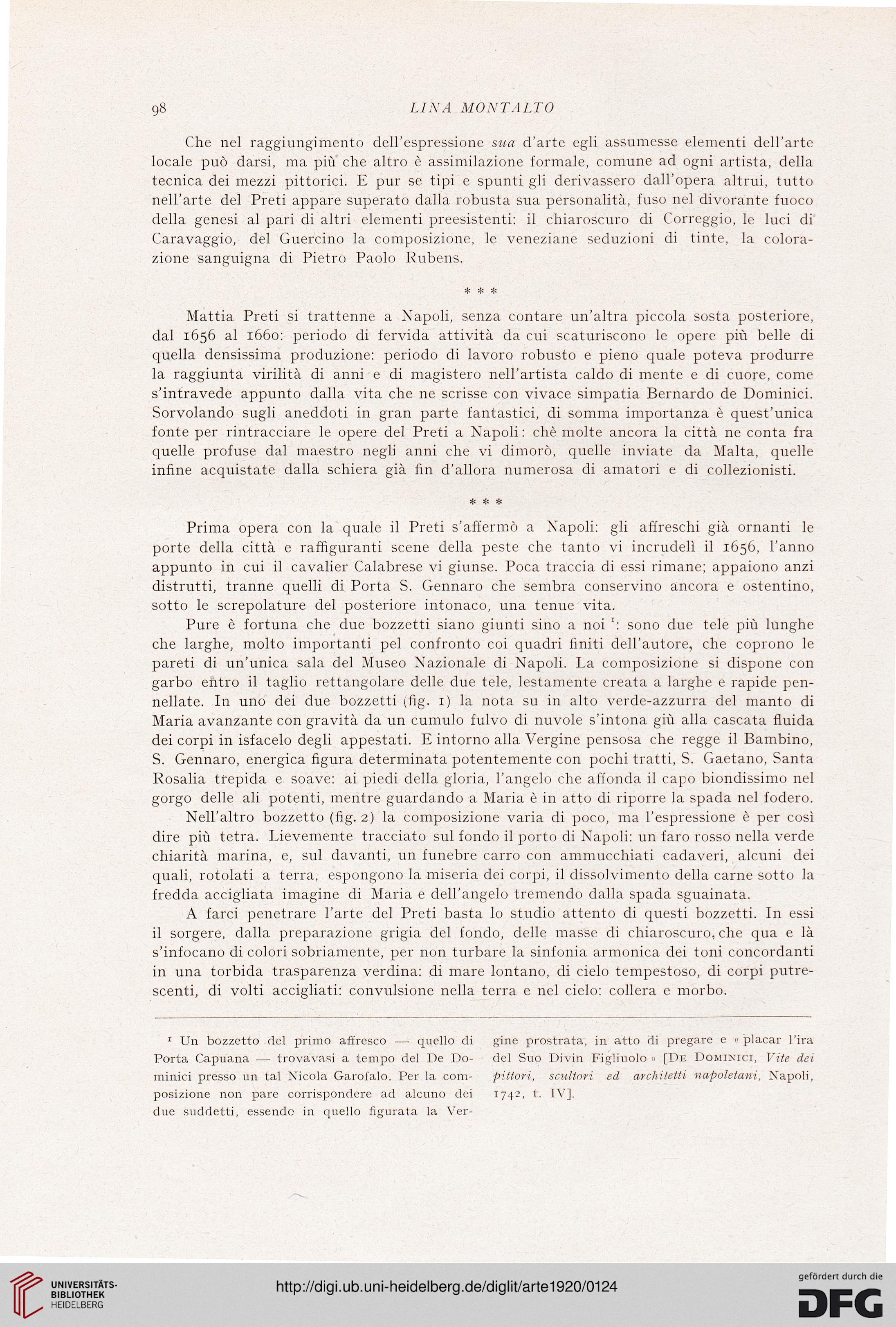98
UNA MO NT ALTO
Che nel raggiungimento dell'espressione sua d'arte egli assumesse elementi dell'arte
locale può darsi, ma più che altro è assimilazione formale, comune ad ogni artista, della
tecnica dei mezzi pittorici. E pur se tipi e spunti gli derivassero dall'opera altrui, tutto
nell'arte del Preti appare superato dalla robusta sua personalità, fuso nel divorante fuoco
della genesi al pari di altri elementi preesistenti: il chiaroscuro di Correggio, le luci di
Caravaggio, del Guercino la composizione, le veneziane seduzioni di tinte, la colora-
zione sanguigna di Pietro Paolo Rubens.
* * *
Mattia Preti si trattenne a Napoli, senza contare un'altra piccola sosta posteriore,
dal 1656 al 1660: periodo di fervida attività da cui scaturiscono le opere più belle di
quella densissima produzione: periodo di lavoro robusto e pieno quale poteva produrre
la raggiunta virilità di anni e di magistero nell'artista caldo di mente e di cuore, come
s'intravede appunto dalla vita che ne scrisse con vivace simpatia Bernardo de Dominici.
Sorvolando sugli aneddoti in gran parte fantastici, di somma importanza è quest'unica
fonte per rintracciare le opere del Preti a Napoli: chè molte ancora la città ne conta fra
quelle profuse dal maestro negli anni che vi dimorò, quelle inviate da Malta, quelle
infine acquistate dalla schiera già fin d'allora numerosa di amatori e di collezionisti.
* * *
Prima opera con la quale il Preti s'affermò a Napoli: gli affreschi già ornanti le
porte della città e raffiguranti scene della peste che tanto vi incrudelì il 1656, l'anno
appunto in cui il cavalier Calabrese vi giunse. Poca traccia di essi rimane; appaiono anzi
distrutti, tranne quelli di Porta S. Gennaro che sembra conservino ancora e ostentino,
sotto le screpolature del posteriore intonaco, una tenue vita.
Pure è fortuna che due bozzetti siano giunti sino a noi sono due tele più lunghe
che larghe, molto importanti pel confronto coi quadri finiti dell'autore, che coprono le
pareti di un'unica sala del Museo Nazionale di Napoli. La composizione si dispone con
garbo entro il taglio rettangolare delle due tele, lestamente creata a larghe e rapide pen-
nellate. In uno dei due bozzetti (fig. 1) la nota su in alto verde-azzurra del manto di
Maria avanzante con gravità da un cumulo fulvo di nuvole s'intona giù alla cascata fluida
dei corpi in isfacelo degli appestati. E intorno alla Vergine pensosa che regge il Bambino,
S. Gennaro, energica figura determinata potentemente con pochi tratti, S. Gaetano, Santa
Rosalia trepida e soave: ai piedi della gloria, l'angelo che affonda il capo biondissimo nel
gorgo delle ali potenti, mentre guardando a Maria è in atto di riporre la spada nel fodero.
Nell'altro bozzetto (fig. 2) la composizione varia di poco, ma l'espressione è per così
dire più tetra. Lievemente tracciato sul fondo il porto di Napoli: un faro rosso nella verde
chiarità marina, e, sul davanti, un funebre carro con ammucchiati cadaveri, alcuni dei
quali, rotolati a terra, espongono la miseria dei corpi, il dissolvimento della carne sotto la
fredda accigliata imagine di Maria e dell'angelo tremendo dalla spada sguainata.
A farci penetrare l'arte del Preti basta lo studio attento di questi bozzetti. In essi
il sorgere, dalla preparazione grigia del fondo, delle masse di chiaroscuro, che qua e là
s'infocano di colori sobriamente, per non turbare la sinfonia armonica dei toni concordanti
in una torbida trasparenza verdina: di mare lontano, di cielo tempestoso, di corpi putre-
scenti, di volti accigliati: convulsione nella terra e nel cielo: collera e morbo.
1 Un bozzetto del primo affresco — quello di
Porta Capuana — trova vasi a tempo del De Do-
minici presso un tal Nicola Garofalo. Per la com-
posizione non pare corrispondere ad alcuno dei
due suddetti, essendo in quello figurata la Ver-
gine prostrata, in atto di pregare e » placar l'ira
del Suo Divin Figliuolo » [De Dominici, Vite dei
pittori, scultori ed architetti napoletani, Napoli,
1742, t. IV].
UNA MO NT ALTO
Che nel raggiungimento dell'espressione sua d'arte egli assumesse elementi dell'arte
locale può darsi, ma più che altro è assimilazione formale, comune ad ogni artista, della
tecnica dei mezzi pittorici. E pur se tipi e spunti gli derivassero dall'opera altrui, tutto
nell'arte del Preti appare superato dalla robusta sua personalità, fuso nel divorante fuoco
della genesi al pari di altri elementi preesistenti: il chiaroscuro di Correggio, le luci di
Caravaggio, del Guercino la composizione, le veneziane seduzioni di tinte, la colora-
zione sanguigna di Pietro Paolo Rubens.
* * *
Mattia Preti si trattenne a Napoli, senza contare un'altra piccola sosta posteriore,
dal 1656 al 1660: periodo di fervida attività da cui scaturiscono le opere più belle di
quella densissima produzione: periodo di lavoro robusto e pieno quale poteva produrre
la raggiunta virilità di anni e di magistero nell'artista caldo di mente e di cuore, come
s'intravede appunto dalla vita che ne scrisse con vivace simpatia Bernardo de Dominici.
Sorvolando sugli aneddoti in gran parte fantastici, di somma importanza è quest'unica
fonte per rintracciare le opere del Preti a Napoli: chè molte ancora la città ne conta fra
quelle profuse dal maestro negli anni che vi dimorò, quelle inviate da Malta, quelle
infine acquistate dalla schiera già fin d'allora numerosa di amatori e di collezionisti.
* * *
Prima opera con la quale il Preti s'affermò a Napoli: gli affreschi già ornanti le
porte della città e raffiguranti scene della peste che tanto vi incrudelì il 1656, l'anno
appunto in cui il cavalier Calabrese vi giunse. Poca traccia di essi rimane; appaiono anzi
distrutti, tranne quelli di Porta S. Gennaro che sembra conservino ancora e ostentino,
sotto le screpolature del posteriore intonaco, una tenue vita.
Pure è fortuna che due bozzetti siano giunti sino a noi sono due tele più lunghe
che larghe, molto importanti pel confronto coi quadri finiti dell'autore, che coprono le
pareti di un'unica sala del Museo Nazionale di Napoli. La composizione si dispone con
garbo entro il taglio rettangolare delle due tele, lestamente creata a larghe e rapide pen-
nellate. In uno dei due bozzetti (fig. 1) la nota su in alto verde-azzurra del manto di
Maria avanzante con gravità da un cumulo fulvo di nuvole s'intona giù alla cascata fluida
dei corpi in isfacelo degli appestati. E intorno alla Vergine pensosa che regge il Bambino,
S. Gennaro, energica figura determinata potentemente con pochi tratti, S. Gaetano, Santa
Rosalia trepida e soave: ai piedi della gloria, l'angelo che affonda il capo biondissimo nel
gorgo delle ali potenti, mentre guardando a Maria è in atto di riporre la spada nel fodero.
Nell'altro bozzetto (fig. 2) la composizione varia di poco, ma l'espressione è per così
dire più tetra. Lievemente tracciato sul fondo il porto di Napoli: un faro rosso nella verde
chiarità marina, e, sul davanti, un funebre carro con ammucchiati cadaveri, alcuni dei
quali, rotolati a terra, espongono la miseria dei corpi, il dissolvimento della carne sotto la
fredda accigliata imagine di Maria e dell'angelo tremendo dalla spada sguainata.
A farci penetrare l'arte del Preti basta lo studio attento di questi bozzetti. In essi
il sorgere, dalla preparazione grigia del fondo, delle masse di chiaroscuro, che qua e là
s'infocano di colori sobriamente, per non turbare la sinfonia armonica dei toni concordanti
in una torbida trasparenza verdina: di mare lontano, di cielo tempestoso, di corpi putre-
scenti, di volti accigliati: convulsione nella terra e nel cielo: collera e morbo.
1 Un bozzetto del primo affresco — quello di
Porta Capuana — trova vasi a tempo del De Do-
minici presso un tal Nicola Garofalo. Per la com-
posizione non pare corrispondere ad alcuno dei
due suddetti, essendo in quello figurata la Ver-
gine prostrata, in atto di pregare e » placar l'ira
del Suo Divin Figliuolo » [De Dominici, Vite dei
pittori, scultori ed architetti napoletani, Napoli,
1742, t. IV].