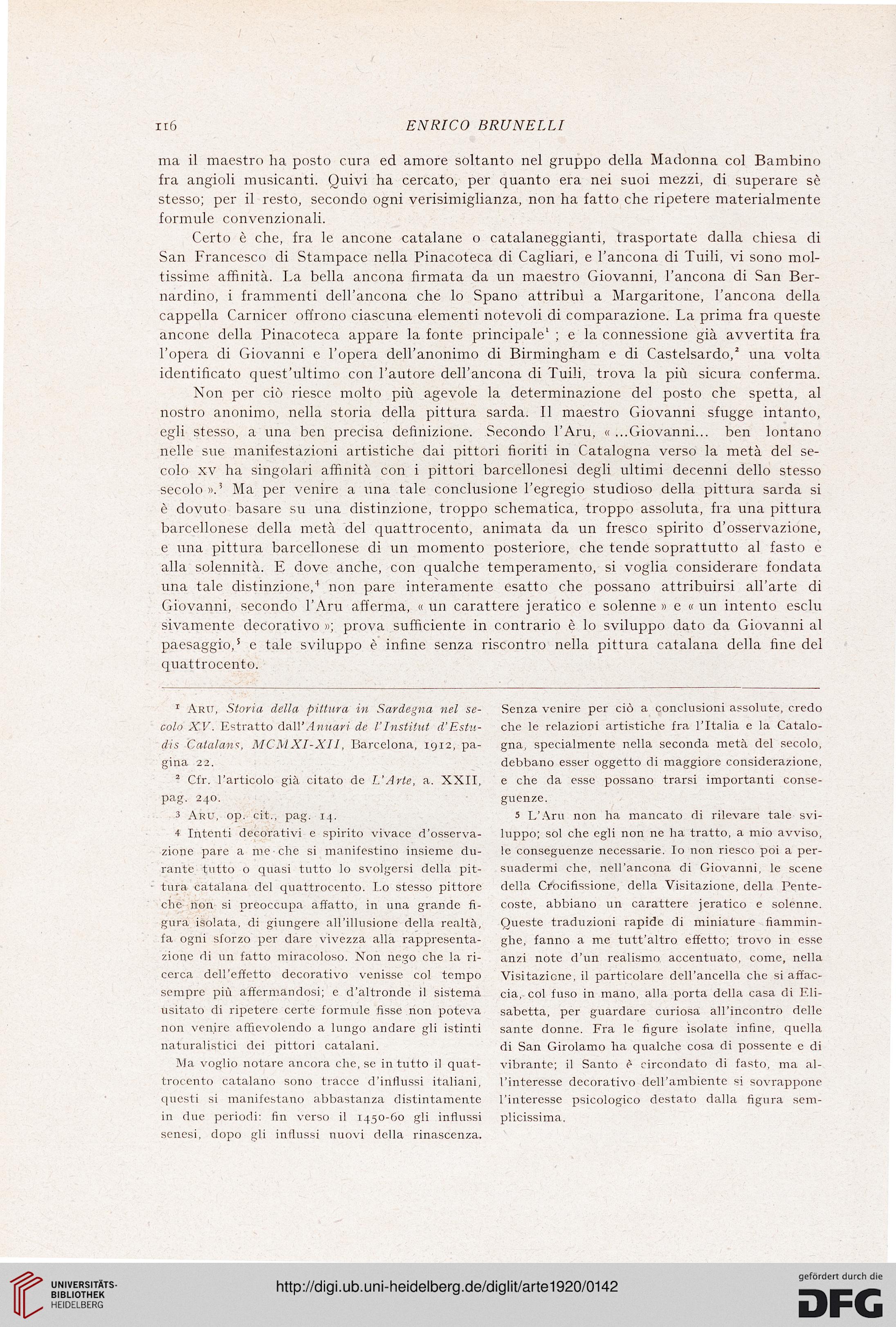xi6
ENRICO BRUNELLI
ma il maestro ha posto cura ed amore soltanto nel gruppo della Madonna col Bambino
fra angioli musicanti. Quivi ha cercato, per quanto era nei suoi mezzi, di superare se
stesso; per il resto, secondo ogni verisimiglianza, non ha fatto che ripetere materialmente
formule convenzionali.
Certo è che, fra le ancone catalane 0 catalaneggianti, trasportate dalla chiesa di
San Francesco di Stampace nella Pinacoteca di Cagliari, e l'ancona di Tuili, vi sono mol-
tissime affinità. La bella ancona firmata da un maestro Giovanni, l'ancona di San Ber-
nardino, i frammenti dell'ancona che lo Spano attribuì a Margaritone, l'ancona della
cappella Carnicer offrono ciascuna elementi notevoli di comparazione. La prima fra queste
ancone della Pinacoteca appare la fonte principale1 ; e la connessione già avvertita fra
l'opera di Giovanni e l'opera dell'anonimo di Birmingham e di Castelsardo,2 una volta
identificato quest'ultimo con l'autore dell'ancona di Tuili, trova la più sicura conferma.
Non per ciò riesce molto più agevole la determinazione del posto che spetta, al
nostro anonimo, nella storia della pittura sarda. Il maestro Giovanni sfugge intanto,
egli stesso, a una ben precisa definizione. Secondo l'Ani, « ...Giovanni... ben lontano
nelle sue manifestazioni artistiche dai pittori fioriti in Catalogna verso la metà del se-
colo xv ha singolari affinità con i pittori barcellonesi degli ultimi decenni dello stesso
secolo».5 Ma per venire a una tale conclusione l'egregio studioso della pittura sarda si
è dovuto basare su una distinzione, troppo schematica, troppo assoluta, fra una pittura
barcellonese della metà del quattrocento, animata da un fresco spirito d'osservazione,
e una pittura barcellonese di un momento posteriore, che tende soprattutto al fasto e
alla solennità. E dove anche, con qualche temperamento, si voglia considerare fondata
una tale distinzione,4 non pare interamente esatto che possano attribuirsi all'arte di
Giovanni, secondo l'Aru afferma, « un carattere jeratico e solenne » e « un intento esclu
sivamente decorativo »; prova sufficiente in contrario è lo sviluppo dato da Giovanni al
paesaggio,5 e tale sviluppo è infine senza riscontro nella pittura catalana della fine del
quattrocento.
1 Arti, Storia della pittura in Sardegna nel se-
colo XV. Estratto dall' Attuari de l'Institut d'Estit-
dis Catalana, MCMXI-XII, Barcelona, 1912, pa-
gina 22.
2 Cfr. l'articolo già citato de L'Arte, a. XXII,
pag. 240.
3 Aru, op. cit., pag. 14.
4 Intenti decorativi e spirito vivace d'osserva-
zione pare a me che si manifestino insieme du-
rante tutto o quasi tutto lo svolgersi della pit-
tura catalana del quattrocento. Lo stesso pittore
clic non si preoccupa affatto, in una grande fi-
gura isolata, di giungere all'illusione della realtà,
fa ogni sforzo per dare vivezza alla rappresenta-
zione di un fatto miracoloso. Non nego che la ri-
cerca dell'effetto decorativo venisse col tempo
sempre più affermandosi; e d'altronde il sistema
usitato di ripetere certe formule fisse non poteva
non venire affievolendo a lungo andare gli istinti
naturalistici dei pittori catalani.
Ma voglio notare ancora che, se in tutto il quat-
trocento catalano sono tracce d'influssi italiani,
questi si manifestano abbastanza distintamente
in due periodi: fin verso il 1450-60 gli influssi
senesi, dopo gli influssi nuovi della rinascenza.
Senza venire per ciò a conclusioni assolute, credo
che le relazioni artistiche fra l'Italia e la Catalo-
gna, specialmente nella seconda metà del secolo,
debbano esser oggetto di maggiore considerazione,
e che da esse possano trarsi importanti conse-
guenze.
5 L'Aru non ha mancato di rilevare tale svi-
luppo; sol che egli non ne ha tratto, a mio avviso,
le conseguenze necessarie. Io non riesco poi a per-
suadermi che, nell'ancona di Giovanni, le scene
della Crocifissione, della Visitazione, della Pente-
coste, abbiano un carattere jeratico e solenne.
Queste traduzioni rapide di miniature fiammin-
ghe, fanno a me tutt'altro effetto; trovo in esse
anzi note d'un realismo accentuato, come, nella
Visitazione, il particolare dell'ancella che si affac-
cia, col fuso in mano, alla porta della casa di Eli-
sabetta, per guardare curiosa all'incontro delle
sante donne. Fra le figure isolate infine, quella
di San Girolamo ha qualche cosa di possente e di
vibrante; il Santo è circondato di fasto, ma al-
l'interesse decorativo dell'ambiente si sovrappone
l'interesse psicologico destato dalla figura sem-
plicissima.
ENRICO BRUNELLI
ma il maestro ha posto cura ed amore soltanto nel gruppo della Madonna col Bambino
fra angioli musicanti. Quivi ha cercato, per quanto era nei suoi mezzi, di superare se
stesso; per il resto, secondo ogni verisimiglianza, non ha fatto che ripetere materialmente
formule convenzionali.
Certo è che, fra le ancone catalane 0 catalaneggianti, trasportate dalla chiesa di
San Francesco di Stampace nella Pinacoteca di Cagliari, e l'ancona di Tuili, vi sono mol-
tissime affinità. La bella ancona firmata da un maestro Giovanni, l'ancona di San Ber-
nardino, i frammenti dell'ancona che lo Spano attribuì a Margaritone, l'ancona della
cappella Carnicer offrono ciascuna elementi notevoli di comparazione. La prima fra queste
ancone della Pinacoteca appare la fonte principale1 ; e la connessione già avvertita fra
l'opera di Giovanni e l'opera dell'anonimo di Birmingham e di Castelsardo,2 una volta
identificato quest'ultimo con l'autore dell'ancona di Tuili, trova la più sicura conferma.
Non per ciò riesce molto più agevole la determinazione del posto che spetta, al
nostro anonimo, nella storia della pittura sarda. Il maestro Giovanni sfugge intanto,
egli stesso, a una ben precisa definizione. Secondo l'Ani, « ...Giovanni... ben lontano
nelle sue manifestazioni artistiche dai pittori fioriti in Catalogna verso la metà del se-
colo xv ha singolari affinità con i pittori barcellonesi degli ultimi decenni dello stesso
secolo».5 Ma per venire a una tale conclusione l'egregio studioso della pittura sarda si
è dovuto basare su una distinzione, troppo schematica, troppo assoluta, fra una pittura
barcellonese della metà del quattrocento, animata da un fresco spirito d'osservazione,
e una pittura barcellonese di un momento posteriore, che tende soprattutto al fasto e
alla solennità. E dove anche, con qualche temperamento, si voglia considerare fondata
una tale distinzione,4 non pare interamente esatto che possano attribuirsi all'arte di
Giovanni, secondo l'Aru afferma, « un carattere jeratico e solenne » e « un intento esclu
sivamente decorativo »; prova sufficiente in contrario è lo sviluppo dato da Giovanni al
paesaggio,5 e tale sviluppo è infine senza riscontro nella pittura catalana della fine del
quattrocento.
1 Arti, Storia della pittura in Sardegna nel se-
colo XV. Estratto dall' Attuari de l'Institut d'Estit-
dis Catalana, MCMXI-XII, Barcelona, 1912, pa-
gina 22.
2 Cfr. l'articolo già citato de L'Arte, a. XXII,
pag. 240.
3 Aru, op. cit., pag. 14.
4 Intenti decorativi e spirito vivace d'osserva-
zione pare a me che si manifestino insieme du-
rante tutto o quasi tutto lo svolgersi della pit-
tura catalana del quattrocento. Lo stesso pittore
clic non si preoccupa affatto, in una grande fi-
gura isolata, di giungere all'illusione della realtà,
fa ogni sforzo per dare vivezza alla rappresenta-
zione di un fatto miracoloso. Non nego che la ri-
cerca dell'effetto decorativo venisse col tempo
sempre più affermandosi; e d'altronde il sistema
usitato di ripetere certe formule fisse non poteva
non venire affievolendo a lungo andare gli istinti
naturalistici dei pittori catalani.
Ma voglio notare ancora che, se in tutto il quat-
trocento catalano sono tracce d'influssi italiani,
questi si manifestano abbastanza distintamente
in due periodi: fin verso il 1450-60 gli influssi
senesi, dopo gli influssi nuovi della rinascenza.
Senza venire per ciò a conclusioni assolute, credo
che le relazioni artistiche fra l'Italia e la Catalo-
gna, specialmente nella seconda metà del secolo,
debbano esser oggetto di maggiore considerazione,
e che da esse possano trarsi importanti conse-
guenze.
5 L'Aru non ha mancato di rilevare tale svi-
luppo; sol che egli non ne ha tratto, a mio avviso,
le conseguenze necessarie. Io non riesco poi a per-
suadermi che, nell'ancona di Giovanni, le scene
della Crocifissione, della Visitazione, della Pente-
coste, abbiano un carattere jeratico e solenne.
Queste traduzioni rapide di miniature fiammin-
ghe, fanno a me tutt'altro effetto; trovo in esse
anzi note d'un realismo accentuato, come, nella
Visitazione, il particolare dell'ancella che si affac-
cia, col fuso in mano, alla porta della casa di Eli-
sabetta, per guardare curiosa all'incontro delle
sante donne. Fra le figure isolate infine, quella
di San Girolamo ha qualche cosa di possente e di
vibrante; il Santo è circondato di fasto, ma al-
l'interesse decorativo dell'ambiente si sovrappone
l'interesse psicologico destato dalla figura sem-
plicissima.