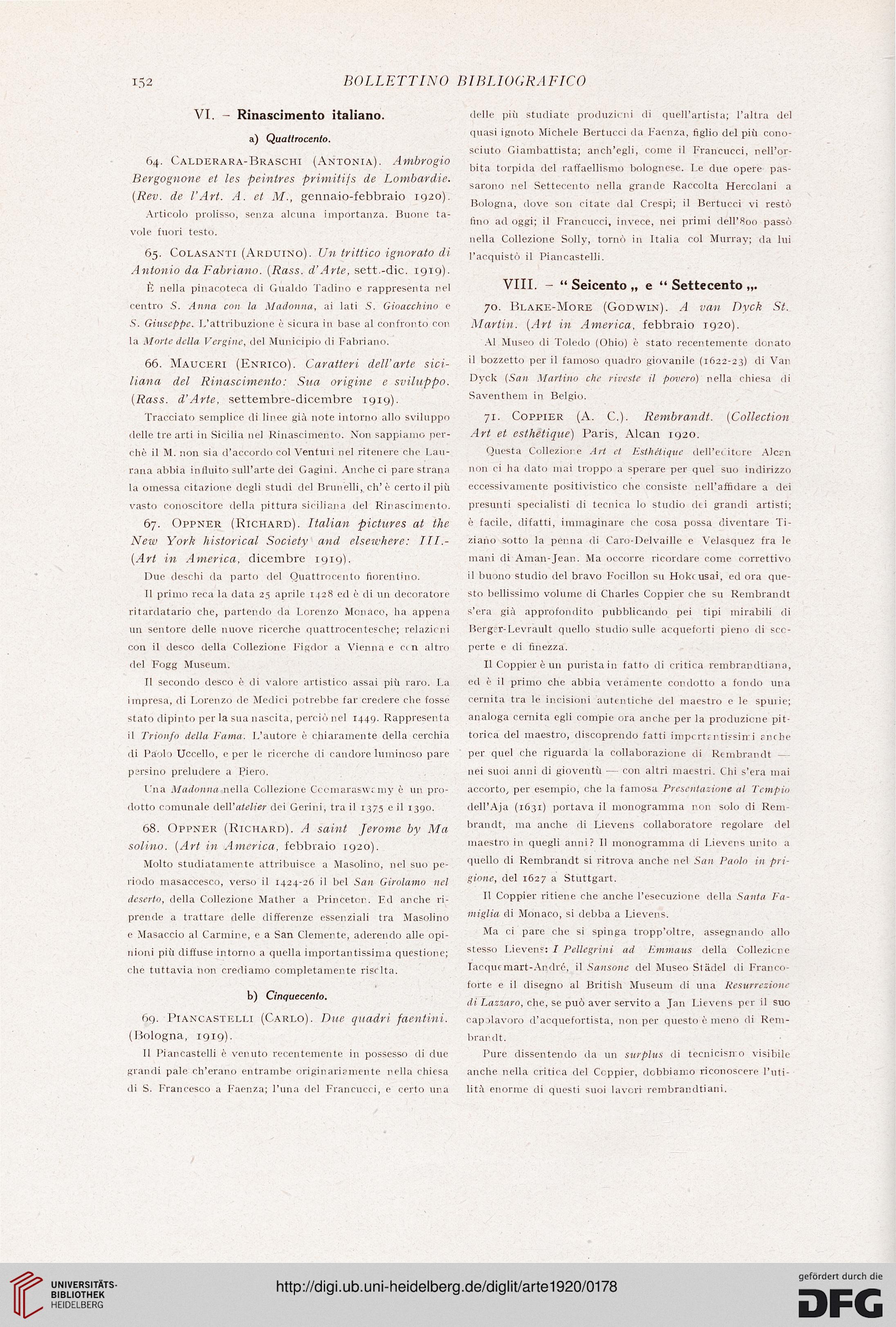152
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
VI. - Rinascimento italiano.
a) Quattrocento.
64. Calderara-Braschi (Antonia). Ambrogio
Borgognone et les peintres primitifs de Lombardie.
(Rev. de l'Art. A. et M., gennaio-febbraio 1920).
Articolo prolisso, senza alcuna importanza. Buone ta-
vole fuori testo.
65. Colasanti (Arduino). Un trittico ignorato di
Antonio da Fabriano. (Rass. d'Arte, sett.-dic. 1919).
fi nella pinacoteca di Gualdo Tadino e rappresenta nel
centro ,S. Anna con la Madonna, ai lati S, Gioacchino e
S. Giuseppe. L'attribuzione è sicura in base al confronto con
La Morte della Vergine, del Municipio di Fabriano.
66. Mauceri (Enrico). Caratteri dell'arte sici-
liana del Rinascimento: Sita origine e sviluppo.
(Rass. d'Arte, settembre-dicembre 1919).
Tracciato semplice di linee già note intorno allo sviluppo
delle tre arti in Sicilia nel Rinascimento. Non sappiamo per-
chè il M. non sia d'accordo col Ventini nel ritenere che Lau-
rana abbia influito sull'arte dei Gagini. Anche ci pare strana
la omessa citazione degli studi del Brunelli, eh'è certo il più
vasto conoscitore della pittura siciliana del Rinascimento.
67. Oppner (Richard). Italian pictures at the
New York historical Society and elsewhere: III.-
(Art in America, dicembre 1919).
Due deschi da parto del Quattrocento fiorentino.
11 primo reca la data 25 aprile 1428 ed è di un decoratore
ritardatario che, partendo da Lorenzo Monaco, ha appena
un sentore delle nuove ricerche quattrocentesche; relazii ci
con il desco della Collezione Figdor a Vienna e et n altro
del Fogg Museum.
TI secondo desco è di valore artistico assai più raro, l.a
impresa, di Lorenzo de Medici potrebbe far credere che fosse
stato dipinto per la sua nascita, perciò nel 1449. Rappresenta
il Trionfo della Fama. L'autore è chiaramente della cerchia
di Bàtolo Uccello, e per le ricerche di candore luminoso pare
persino preludere a Piero.
Tua Madonna nella Collezione Ccemaraswc niy è un pro-
dotto comunale i\e\V atelier dei Gerini, tra il 1375 e il 1390.
68. Oppner (Richard). A saint Jerome by Ma
solino. (Art in America, febbraio 1920).
Molto studiatamente attribuisce a Masolino, nel suo pe-
riodo masaccesco, verso il 1424-26 il bel San Girolamo nel
deserto, della Collezione Mather a Princeton. Ed anche ri-
prende a trattare delle differenze essenziali tra Masolino
e Masaccio al Carmine, e a San Clemente, aderendo alle opi-
nioni più diffuse intorno a quella importantissima questione;
che tuttavia non crediamo completamente risclta.
b) Cinquecento.
69. Piancastelli (Carlo). Due quadri faentini.
(Bologna, 1919).
Il Piancastelli è venuto recentemente in possesso di due
grandi pale ch'erano entrambe originariamente nella chiesa
di S. Francesco a Faenza; Luna del Francucci, e certo una
delle piii studiate produzu ni di quell'artista; l'altra del
quasi ignoto Michele Bertucci da Faenza, figlio del più cono-
sciuto Giambattista; anch'egli, come il Francucci, nell'or-
bita torpida del raffaellismo bolognese. Le due opere pas-
sarono nel Settecento nella grande Raccolta Hercolani a
Bologna, dove son citate dal Crespi; il Bertucci vi restò
fino ad oggi; il Francucci, invece, nei primi dell'800 passò
nella Collezione Solly, tornò in Italia col Murray; da lui
l'acquistò il Piancastelli.
Vili. - "Seicento,, e "Settecento,,.
70. Blake-More (Godwin). A vati Dyck St.
Martin. (Art in America, febbraio 1920).
Al Museo di 'Toledo (Ohio) è stato recentemente donato
il bozzetto per il famoso quadro giovanile (1622-23) 'li Van
Dyck (San Martino che riveste il povero) nella chiesa di
Saventhem in Belgio.
71. Coppier (A. C). Rembrandt. (Collection
Art et esthetique) Paris, Alcan 1920.
Questa Collezione Art et Esthetique dell'ei itcre Alcen
non ci ha dato mai troppo a sperare per quel suo indirizzo
eccessivamente positivistico che consiste nell'affidare a dei
presunti specialisti di tecnica lo studio dei grandi artisti;
è facile, difatti, immaginare che cosa possa diventare Ti-
ziano sotto la penna di Caro-Delvaille e Velasquez fra le
mani di Aman-Jean. Ma occorre ricordare come correttivo
il buono studio del bravo FociHon su Hokcusai, ed ora que-
sto bellissimo volume di Charles Coppier che su Rembrandt
s'era già approfondito pubblicando pei tipi mirabili di
Berger-Levràult quello studio sulle acquaforti pieno di sco-
perte e di finezza.
Il Coppier è un purista in fatto di critica rembrandtiana,
ed è il primo che abbia veramente condotto a fondo una
cernita tra le incisioni autentiche del maestro e le Spurie;
analoga cernita egli compie ora anche perla produzione pit-
torica del maestro, discoprendo fatti impcrtfntifsimi anche
per quel che riguarda la collaborazione di Rembrandt —
nei suoi anni di gioventù — con altri maestri. Chi s'era mai
accorto, per esempio, che la famosa Presentazione al Tempio
dell'Aia (1631) portava il monogramma non solo di Rem-
brandt, ma anche di Lievens collaboratore regolare del
maestro in quegli anni? Il monogramma di Lievens unito a
quello di Rembrandt si ritrova anche nel San l'anlo in pri-
gione, del 1627 a Stuttgart.
Il Coppier ritiene che anche l'esecuzione della Santa Fa-
tnigHa di Monaco, si debba a Lievens.
Ma ci pare che si spinga tropp'oltre, assegnando allo
stesso Lievenf: I Pellegrini ad Emmaus della Collezione
Tacqurmart-André, il Sansone del Museo Stàdel di Franco-
forte e il disegno al British Museum di una Resurrezione
di Lazzaro, che, se può aver servito a Jan Lievens per il suo
capolavoro d'acquefortista, non per questo è meno di Rem-
brandt.
Pure dissentendo da un surplus di tecnicisn o visibile
anche nella critica del Coppier, dobbiamo riconoscere l'uti-
lità enorme di questi suoi lavori rembrandt)ani.
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
VI. - Rinascimento italiano.
a) Quattrocento.
64. Calderara-Braschi (Antonia). Ambrogio
Borgognone et les peintres primitifs de Lombardie.
(Rev. de l'Art. A. et M., gennaio-febbraio 1920).
Articolo prolisso, senza alcuna importanza. Buone ta-
vole fuori testo.
65. Colasanti (Arduino). Un trittico ignorato di
Antonio da Fabriano. (Rass. d'Arte, sett.-dic. 1919).
fi nella pinacoteca di Gualdo Tadino e rappresenta nel
centro ,S. Anna con la Madonna, ai lati S, Gioacchino e
S. Giuseppe. L'attribuzione è sicura in base al confronto con
La Morte della Vergine, del Municipio di Fabriano.
66. Mauceri (Enrico). Caratteri dell'arte sici-
liana del Rinascimento: Sita origine e sviluppo.
(Rass. d'Arte, settembre-dicembre 1919).
Tracciato semplice di linee già note intorno allo sviluppo
delle tre arti in Sicilia nel Rinascimento. Non sappiamo per-
chè il M. non sia d'accordo col Ventini nel ritenere che Lau-
rana abbia influito sull'arte dei Gagini. Anche ci pare strana
la omessa citazione degli studi del Brunelli, eh'è certo il più
vasto conoscitore della pittura siciliana del Rinascimento.
67. Oppner (Richard). Italian pictures at the
New York historical Society and elsewhere: III.-
(Art in America, dicembre 1919).
Due deschi da parto del Quattrocento fiorentino.
11 primo reca la data 25 aprile 1428 ed è di un decoratore
ritardatario che, partendo da Lorenzo Monaco, ha appena
un sentore delle nuove ricerche quattrocentesche; relazii ci
con il desco della Collezione Figdor a Vienna e et n altro
del Fogg Museum.
TI secondo desco è di valore artistico assai più raro, l.a
impresa, di Lorenzo de Medici potrebbe far credere che fosse
stato dipinto per la sua nascita, perciò nel 1449. Rappresenta
il Trionfo della Fama. L'autore è chiaramente della cerchia
di Bàtolo Uccello, e per le ricerche di candore luminoso pare
persino preludere a Piero.
Tua Madonna nella Collezione Ccemaraswc niy è un pro-
dotto comunale i\e\V atelier dei Gerini, tra il 1375 e il 1390.
68. Oppner (Richard). A saint Jerome by Ma
solino. (Art in America, febbraio 1920).
Molto studiatamente attribuisce a Masolino, nel suo pe-
riodo masaccesco, verso il 1424-26 il bel San Girolamo nel
deserto, della Collezione Mather a Princeton. Ed anche ri-
prende a trattare delle differenze essenziali tra Masolino
e Masaccio al Carmine, e a San Clemente, aderendo alle opi-
nioni più diffuse intorno a quella importantissima questione;
che tuttavia non crediamo completamente risclta.
b) Cinquecento.
69. Piancastelli (Carlo). Due quadri faentini.
(Bologna, 1919).
Il Piancastelli è venuto recentemente in possesso di due
grandi pale ch'erano entrambe originariamente nella chiesa
di S. Francesco a Faenza; Luna del Francucci, e certo una
delle piii studiate produzu ni di quell'artista; l'altra del
quasi ignoto Michele Bertucci da Faenza, figlio del più cono-
sciuto Giambattista; anch'egli, come il Francucci, nell'or-
bita torpida del raffaellismo bolognese. Le due opere pas-
sarono nel Settecento nella grande Raccolta Hercolani a
Bologna, dove son citate dal Crespi; il Bertucci vi restò
fino ad oggi; il Francucci, invece, nei primi dell'800 passò
nella Collezione Solly, tornò in Italia col Murray; da lui
l'acquistò il Piancastelli.
Vili. - "Seicento,, e "Settecento,,.
70. Blake-More (Godwin). A vati Dyck St.
Martin. (Art in America, febbraio 1920).
Al Museo di 'Toledo (Ohio) è stato recentemente donato
il bozzetto per il famoso quadro giovanile (1622-23) 'li Van
Dyck (San Martino che riveste il povero) nella chiesa di
Saventhem in Belgio.
71. Coppier (A. C). Rembrandt. (Collection
Art et esthetique) Paris, Alcan 1920.
Questa Collezione Art et Esthetique dell'ei itcre Alcen
non ci ha dato mai troppo a sperare per quel suo indirizzo
eccessivamente positivistico che consiste nell'affidare a dei
presunti specialisti di tecnica lo studio dei grandi artisti;
è facile, difatti, immaginare che cosa possa diventare Ti-
ziano sotto la penna di Caro-Delvaille e Velasquez fra le
mani di Aman-Jean. Ma occorre ricordare come correttivo
il buono studio del bravo FociHon su Hokcusai, ed ora que-
sto bellissimo volume di Charles Coppier che su Rembrandt
s'era già approfondito pubblicando pei tipi mirabili di
Berger-Levràult quello studio sulle acquaforti pieno di sco-
perte e di finezza.
Il Coppier è un purista in fatto di critica rembrandtiana,
ed è il primo che abbia veramente condotto a fondo una
cernita tra le incisioni autentiche del maestro e le Spurie;
analoga cernita egli compie ora anche perla produzione pit-
torica del maestro, discoprendo fatti impcrtfntifsimi anche
per quel che riguarda la collaborazione di Rembrandt —
nei suoi anni di gioventù — con altri maestri. Chi s'era mai
accorto, per esempio, che la famosa Presentazione al Tempio
dell'Aia (1631) portava il monogramma non solo di Rem-
brandt, ma anche di Lievens collaboratore regolare del
maestro in quegli anni? Il monogramma di Lievens unito a
quello di Rembrandt si ritrova anche nel San l'anlo in pri-
gione, del 1627 a Stuttgart.
Il Coppier ritiene che anche l'esecuzione della Santa Fa-
tnigHa di Monaco, si debba a Lievens.
Ma ci pare che si spinga tropp'oltre, assegnando allo
stesso Lievenf: I Pellegrini ad Emmaus della Collezione
Tacqurmart-André, il Sansone del Museo Stàdel di Franco-
forte e il disegno al British Museum di una Resurrezione
di Lazzaro, che, se può aver servito a Jan Lievens per il suo
capolavoro d'acquefortista, non per questo è meno di Rem-
brandt.
Pure dissentendo da un surplus di tecnicisn o visibile
anche nella critica del Coppier, dobbiamo riconoscere l'uti-
lità enorme di questi suoi lavori rembrandt)ani.