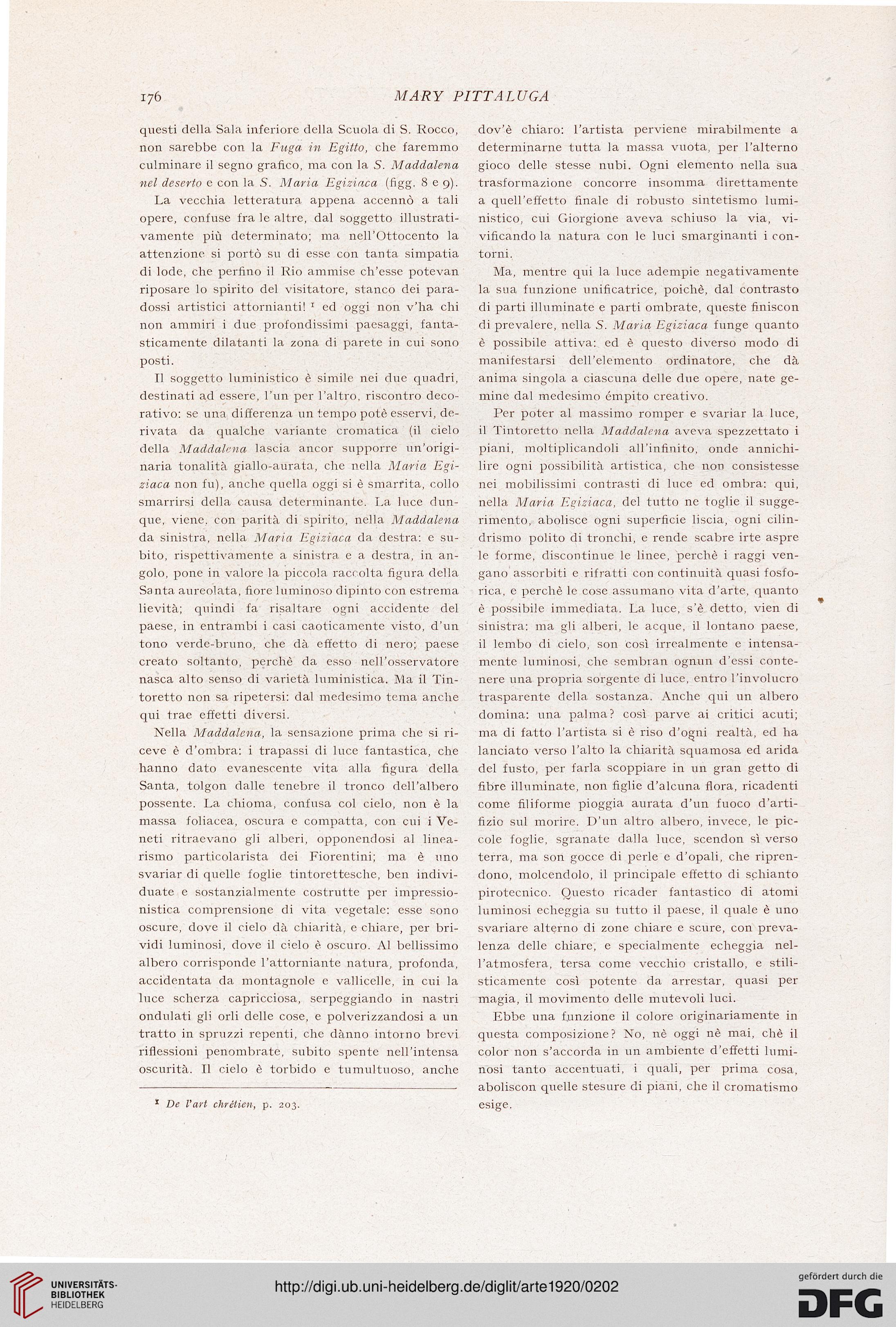176
MARY PITTALUGA
questi della Sala inferiore della Scuola di S. Rocco,
non sarebbe con la Fuga in Egitto, che faremmo
culminare il segno grafico, ma con la S. Maddalena
nel deserto e con la S. Maria Egiziaca (figg. 8 e 9).
La vecchia letteratura appena accennò a tali
opere, confuse fra le altre, dal soggetto illustrati-
vamente più determinato; ma nell'Ottocento la
attenzione si portò su di esse con tanta simpatia
di lode, che perfino il Rio ammise ch'esse potevan
riposare lo spirito del visitatore, stanco dei para-
dossi artistici attornianti! 1 ed oggi non v'ha chi
non ammiri i due profondissimi paesaggi, fanta-
sticamente dilatanti la zona di parete in cui sono
posti.
Il soggetto luministico è simile nei due quadri,
destinati ad essere, l'un per l'altro, riscontro deco-
rativo: se una differenza un tempo potè esservi, de-
rivata da qualche variante cromatica (il cielo
della Maddalena lascia ancor supporre un'origi-
naria tonalità giallo-aurata, che nella Maria Egi-
ziaca non fu), anche quella oggi si è smarrita, collo
smarrirsi della causa determinante. La luce dun-
que, viene, con parità di spirito, nella Maddalena
da sinistra, nella Maria Egiziaca da destra: e su-
bito, rispettivamente a sinistra e a destra, in an-
golo, pone in valore la piccola raccolta figura della
Santa aureolata, fiore luminoso dipinto con estrema
lievità; quindi fa risaltare ogni accidente del
paese, in entrambi i casi caoticamente visto, d'un
tono verde-bruno, che dà effetto di nero; paese
creato soltanto, perchè da esso nell'osservatore
nasca alto senso di varietà luministica. Ma il Tin-
toretto non sa ripetersi: dal medesimo tema anche
qui trae effetti diversi.
Nella Maddalena, la sensazione prima che si ri-
ceve è d'ombra: i trapassi di luce fantastica, che
hanno dato evanescente vita alla figura della
Santa, tolgon dalle tenebre il tronco dell'albero
possente. La chioma, confusa col cielo, non è la
massa foliacea, oscura e compatta, con cui i Ve-
neti ritraevano gli alberi, opponendosi al linea-
rismo particolarista dei Fiorentini; ma è uno
svariar di quelle foglie tintorcttesche, ben indivi-
duate e sostanzialmente costrutte per impressio-
nistica comprensione di vita vegetale: esse sono
oscure, dove il cielo dà chiarità, e chiare, per bri-
vidi luminosi, dove il cielo è oscuro. Al bellissimo
albero corrisponde l'attorniante natura, profonda,
accidentata da montagnole e vallicelle, in cui la
luce scherza capricciosa, serpeggiando in nastri
ondulati gli orli delle cose, e polverizzandosi a un
tratto in spruzzi repenti, che dànno intorno brevi
riflessioni penombrate, subito spente nell'intensa
oscurità. Il cielo è torbido e tumultuoso, anche
De Vari chrètien, p. 203.
dov'è chiaro: l'artista perviene mirabilmente a
determinarne tutta la massa vuota, per l'alterno
gioco delle stesse nubi. Ogni elemento nella sua
trasformazione concorre insomma direttamente
a quell'effetto finale di robusto sintetismo lumi-
nistico, cui Giorgione aveva schiuso la via, vi-
vificando la natura con le luci smarginanti i con-
torni.
Ma, mentre qui la luce adempie negativamente
la sua funzione unificatrice, poiché, dal contrasto
di parti illuminate e parti ombrate, queste finiscon
di prevalere, nella S. Maria Egiziaca funge quanto
è possibile attiva: ed è questo diverso modo di
manifestarsi dell'elemento ordinatore, che dà
anima singola a ciascuna delle due opere, nate ge-
mine dal medesimo empito creativo.
Per poter al massimo romper e svariar la luce,
il Tintoretto nella Maddalena aveva spezzettato i
piani, moltiplicandoli all'infinito, onde annichi-
lire ogni possibilità artistica, che non consistesse
nei mobilissimi contrasti di luce ed ombra: qui,
nella Maria Egiziaca, del tutto ne toglie il sugge-
rimento, abolisce ogni superficie liscia, ogni cilin-
drismo polito di tronchi, e rende scabre irte aspre
le forme, discontinue le linee, perchè i raggi ven-
gano assorbiti e rifratti con continuità quasi fosfo-
rica, e perchè le cose assumano vita d'arte, quanto
è possibile immediata. La luce, s'è detto, vien di
sinistra: ma gli alberi, le acque, il lontano paese,
il lembo di cielo, son così irrealmente e intensa-
mente luminosi, che sembtan ognun d'essi conte-
nere una propria sorgente di luce, entro l'involucro
trasparente della sostanza. Anche qui un albero
domina: una palma? così parve ai critici acuti;
ma di fatto l'artista si è riso d'ogni realtà, ed ha
lanciato verso l'alto la chiarità squamosa ed arida
del fusto, per farla scoppiare in un gran getto di
fibre illuminate, non figlie d'alcuna flora, ricadenti
come filiforme pioggia aurata d'un fuoco d'arti-
fizio sul morire. D'un altro albero, invece, le pic-
cole foglie, sgranate dalla luce, scendon sì verso
terra, ma son gocce di perle e d'opali, che ripren-
dono, molccndolo, il principale effetto di schianto
pirotecnico. Questo ricader fantastico di atomi
luminosi echeggia su tutto il paese, il quale è uno
svariare alterno di zone chiare e scure, con preva-
lenza delle chiare, e specialmente echeggia nel-
l'atmosfera, tersa come vecchio cristallo, e stili-
sticamente così potente da arrestar, quasi per
magia, il movimento delle mutevoli luci.
Ebbe una funzione il colore originariamente in
questa composizione? No, nè oggi nè mai, chè il
color non s'accorda in un ambiente d'effetti lumi-
nosi tanto accentuati, i quali, per prima cosa,
aboliscon quelle stesure di piani, che il cromatismo
esige.
MARY PITTALUGA
questi della Sala inferiore della Scuola di S. Rocco,
non sarebbe con la Fuga in Egitto, che faremmo
culminare il segno grafico, ma con la S. Maddalena
nel deserto e con la S. Maria Egiziaca (figg. 8 e 9).
La vecchia letteratura appena accennò a tali
opere, confuse fra le altre, dal soggetto illustrati-
vamente più determinato; ma nell'Ottocento la
attenzione si portò su di esse con tanta simpatia
di lode, che perfino il Rio ammise ch'esse potevan
riposare lo spirito del visitatore, stanco dei para-
dossi artistici attornianti! 1 ed oggi non v'ha chi
non ammiri i due profondissimi paesaggi, fanta-
sticamente dilatanti la zona di parete in cui sono
posti.
Il soggetto luministico è simile nei due quadri,
destinati ad essere, l'un per l'altro, riscontro deco-
rativo: se una differenza un tempo potè esservi, de-
rivata da qualche variante cromatica (il cielo
della Maddalena lascia ancor supporre un'origi-
naria tonalità giallo-aurata, che nella Maria Egi-
ziaca non fu), anche quella oggi si è smarrita, collo
smarrirsi della causa determinante. La luce dun-
que, viene, con parità di spirito, nella Maddalena
da sinistra, nella Maria Egiziaca da destra: e su-
bito, rispettivamente a sinistra e a destra, in an-
golo, pone in valore la piccola raccolta figura della
Santa aureolata, fiore luminoso dipinto con estrema
lievità; quindi fa risaltare ogni accidente del
paese, in entrambi i casi caoticamente visto, d'un
tono verde-bruno, che dà effetto di nero; paese
creato soltanto, perchè da esso nell'osservatore
nasca alto senso di varietà luministica. Ma il Tin-
toretto non sa ripetersi: dal medesimo tema anche
qui trae effetti diversi.
Nella Maddalena, la sensazione prima che si ri-
ceve è d'ombra: i trapassi di luce fantastica, che
hanno dato evanescente vita alla figura della
Santa, tolgon dalle tenebre il tronco dell'albero
possente. La chioma, confusa col cielo, non è la
massa foliacea, oscura e compatta, con cui i Ve-
neti ritraevano gli alberi, opponendosi al linea-
rismo particolarista dei Fiorentini; ma è uno
svariar di quelle foglie tintorcttesche, ben indivi-
duate e sostanzialmente costrutte per impressio-
nistica comprensione di vita vegetale: esse sono
oscure, dove il cielo dà chiarità, e chiare, per bri-
vidi luminosi, dove il cielo è oscuro. Al bellissimo
albero corrisponde l'attorniante natura, profonda,
accidentata da montagnole e vallicelle, in cui la
luce scherza capricciosa, serpeggiando in nastri
ondulati gli orli delle cose, e polverizzandosi a un
tratto in spruzzi repenti, che dànno intorno brevi
riflessioni penombrate, subito spente nell'intensa
oscurità. Il cielo è torbido e tumultuoso, anche
De Vari chrètien, p. 203.
dov'è chiaro: l'artista perviene mirabilmente a
determinarne tutta la massa vuota, per l'alterno
gioco delle stesse nubi. Ogni elemento nella sua
trasformazione concorre insomma direttamente
a quell'effetto finale di robusto sintetismo lumi-
nistico, cui Giorgione aveva schiuso la via, vi-
vificando la natura con le luci smarginanti i con-
torni.
Ma, mentre qui la luce adempie negativamente
la sua funzione unificatrice, poiché, dal contrasto
di parti illuminate e parti ombrate, queste finiscon
di prevalere, nella S. Maria Egiziaca funge quanto
è possibile attiva: ed è questo diverso modo di
manifestarsi dell'elemento ordinatore, che dà
anima singola a ciascuna delle due opere, nate ge-
mine dal medesimo empito creativo.
Per poter al massimo romper e svariar la luce,
il Tintoretto nella Maddalena aveva spezzettato i
piani, moltiplicandoli all'infinito, onde annichi-
lire ogni possibilità artistica, che non consistesse
nei mobilissimi contrasti di luce ed ombra: qui,
nella Maria Egiziaca, del tutto ne toglie il sugge-
rimento, abolisce ogni superficie liscia, ogni cilin-
drismo polito di tronchi, e rende scabre irte aspre
le forme, discontinue le linee, perchè i raggi ven-
gano assorbiti e rifratti con continuità quasi fosfo-
rica, e perchè le cose assumano vita d'arte, quanto
è possibile immediata. La luce, s'è detto, vien di
sinistra: ma gli alberi, le acque, il lontano paese,
il lembo di cielo, son così irrealmente e intensa-
mente luminosi, che sembtan ognun d'essi conte-
nere una propria sorgente di luce, entro l'involucro
trasparente della sostanza. Anche qui un albero
domina: una palma? così parve ai critici acuti;
ma di fatto l'artista si è riso d'ogni realtà, ed ha
lanciato verso l'alto la chiarità squamosa ed arida
del fusto, per farla scoppiare in un gran getto di
fibre illuminate, non figlie d'alcuna flora, ricadenti
come filiforme pioggia aurata d'un fuoco d'arti-
fizio sul morire. D'un altro albero, invece, le pic-
cole foglie, sgranate dalla luce, scendon sì verso
terra, ma son gocce di perle e d'opali, che ripren-
dono, molccndolo, il principale effetto di schianto
pirotecnico. Questo ricader fantastico di atomi
luminosi echeggia su tutto il paese, il quale è uno
svariare alterno di zone chiare e scure, con preva-
lenza delle chiare, e specialmente echeggia nel-
l'atmosfera, tersa come vecchio cristallo, e stili-
sticamente così potente da arrestar, quasi per
magia, il movimento delle mutevoli luci.
Ebbe una funzione il colore originariamente in
questa composizione? No, nè oggi nè mai, chè il
color non s'accorda in un ambiente d'effetti lumi-
nosi tanto accentuati, i quali, per prima cosa,
aboliscon quelle stesure di piani, che il cromatismo
esige.